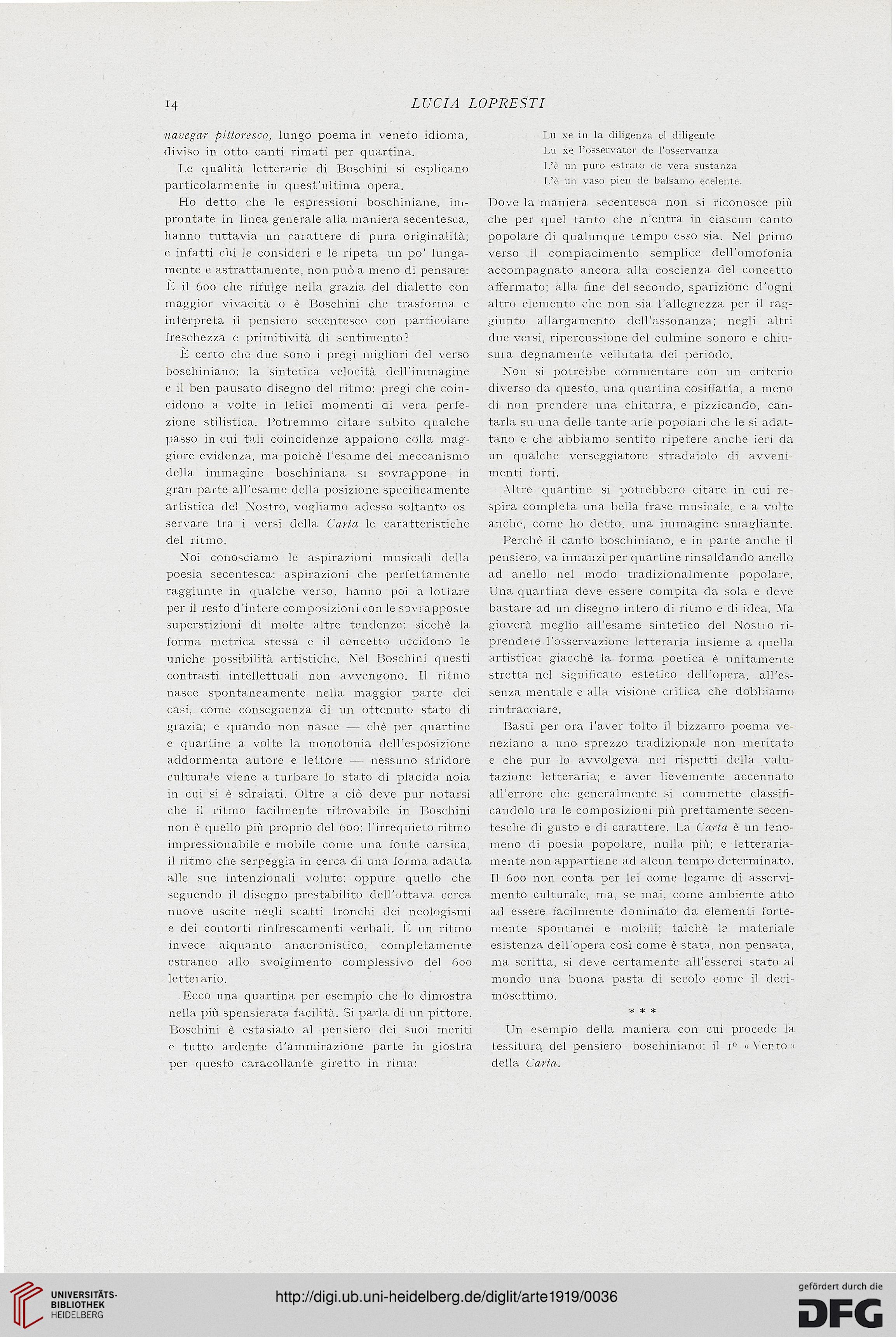14
LUCIA LOPRESTI
havegàr pittoresco, lungo poema in veneto idioma,
diviso in otto canti rimati per quartina.
Le qualità letterarie di Boscbini si esplicano
particolarmente in quest'ultima opera.
Ho detto che le espressioni boschiniane, im-
prontate in linea generale alla maniera secentesca,
hanno tuttavia un carattere di pura originalità;
e infatti chi le consideri e le ripeta un po' lunga-
mente e astrattamente, non può a meno di pensare:
E il 600 che rifulge nella grazia del dialetto con
maggior vivacità o è Boschini che trasforma e
interpreta il pensiero secentesco con particolare
freschezza e primitività di sentimento?
E certo che due sono i pregi migliori del verso
boschiniano: la sintetica velocità dell'immagine
c il ben pausato disegno del ritmo: pregi che coin-
cidono a volte in felici momenti di vera perfe-
zione stilistica. Potremmo citare subito qualche
passo in cui tali coincidenze appaiono colla mag-
giore evidenza, ma poiché l'esame del meccanismo
della immagine boschiniana si sovrappone in
gran parte all'esame delia posizione specificamente
artistica del Nostro, vogliamo adesso soltanto os
servare tra i versi della Carta le caratteristiche
del ritmo.
Noi conosciamo le aspirazioni musicali della,
poesia secentesca: aspirazioni che perfettamente
raggiunte in qualche verso, hanno poi a lotlare
per il resto d'intere composizioni con le sovrapposte
superstizioni di molte altre tendenze: sicché la
forma metrica stessa e il concetto uccidono le
uniche possibilità artistiche. Nel Boschini questi
contrasti intellettuali non avvengono. Il ritmo
nasce spontaneamente nella maggior parte dei
casi, come conseguenza di un ottenuto stato di
grazia; e quando non nasce — chè per quartine
e quartine a volte la monotonia dell'esposizione
addormenta autore e lettore — nessuno stridore
culturale viene a turbare lo stato di placida noia
in cui si è sdraiati. Oltre a ciò deve pur notarsi
che il ritmo facilmente ritrovabile in Boschini
non è quello più proprio del 600: l'irrequieto ritmo
impressionabile e mobile come una fonte carsica,
il ritmo che serpeggia in cerca di una forma adatta
alle sue intenzionali volute; oppure quello che
seguendo il disegno prestabilito dell'ottava cerca
nuove uscite negli scatti tronchi dei neologismi
e dei contorti rinfrescamene verbali. E un ritmo
invece alquanto anacronistico, completamente
estraneo allo svolgimento complessivo del 600
lettei ario.
Ecco una quartina pei" esempio che lo dimostra
nella più spensierata facilità. Si parla di un pittore.
Boschini è estasiato al pensiero dei suoi meriti
e tutto ardente d'ammirazione parte in giostra
per questo caracollante giretto in rima:
Lu xe in la diligenza el diligente
Lu xe l'osservator de l'osservanza
L'è un puro estrato de vera sustanza
L'è un vaso pien de balsamo ecelente.
Dove la maniera secentesca non si riconosce più
che per quel tanto che n'entra in ciascun canto
popolare di qualunque tempo esso sia. Nel primo
verso il compiacimento semplice dell'omofonia
accompagnato ancora alla coscienza del concetto
affermato; alla fine del secondo, sparizione d'ogni
altro elemento che non sia l'allegiezza per il rag-
giunto allargamento dell'assonanza; negli altri
due versi, ripercussione del culmine sonoro e chiu-
sili a degnamente vellutata del periodo.
Non si potrebbe commentare con un criterio
diverso da questo, una quartina cosiffatta, a meno
di non prendere una chitarra, e pizzicando, can-
tarla su una delle tante arie popolari che le si adat-
tano e che abbiamo sentito ripetere anche ieri da
un qualche verseggiatore stradaiolo di avveni-
menti forti.
Altre quartine si potrebbero citare in cui re-
spira completa una bella frase musicale, e a volte
anche, come ho detto, una immagine smagliante.
Perchè il canto boschiniano, e in parte anche il
pensiero, va innanzi per quartine rinsaldando anello
ad anello nel modo tradizionalmente popolare.
Una quartina deve essere compita da sola e deve
bastare ad un disegno intero di ritmo e di idea. Ma
gioverà meglio all'esame sintetico del Nostro ri-
prendere l'osservazione letteraria insieme a quella
artistica: giacché la forma poetica è unitamente
stretta nel significato estetico dell'opera, all'es-
senza mentale e alla visione critica che dobbiamo
rintracciare.
Basti per ora l'aver tolto il bizzarro poema ve-
neziano a uno sprezzo tradizionale non meritato
e che pur lo avvolgeva nei rispetti della valu-
tazione letteraria; e aver lievemente accennato
all'errore che generalmente si commette classifi-
candolo tra le composizioni più prettamente secen-
tesche di gusto e di carattere. I.a Carta è un feno-
meno di poesia popolare, nulla più; e letteraria-
mente non appartiene ad alcun tempo determinato.
Il 600 non conta per lei come legame di asservi-
mento culturale, ma, se mai, come ambiente atto
ad essere facilmente dominato da elementi forte-
mente spontanei e mobili; talché 1? materiale
esistenza dell'opera così come è stata, non pensata,
ma scritta, si deve certamente all'esserci stato al
mondo una buona pasta di secolo come il deci-
mosettimo.
* * *
Un esempio della maniera con cui procede la
tessitura del pensiero boschiniano: il 1" » Vento »
della Carta.
LUCIA LOPRESTI
havegàr pittoresco, lungo poema in veneto idioma,
diviso in otto canti rimati per quartina.
Le qualità letterarie di Boscbini si esplicano
particolarmente in quest'ultima opera.
Ho detto che le espressioni boschiniane, im-
prontate in linea generale alla maniera secentesca,
hanno tuttavia un carattere di pura originalità;
e infatti chi le consideri e le ripeta un po' lunga-
mente e astrattamente, non può a meno di pensare:
E il 600 che rifulge nella grazia del dialetto con
maggior vivacità o è Boschini che trasforma e
interpreta il pensiero secentesco con particolare
freschezza e primitività di sentimento?
E certo che due sono i pregi migliori del verso
boschiniano: la sintetica velocità dell'immagine
c il ben pausato disegno del ritmo: pregi che coin-
cidono a volte in felici momenti di vera perfe-
zione stilistica. Potremmo citare subito qualche
passo in cui tali coincidenze appaiono colla mag-
giore evidenza, ma poiché l'esame del meccanismo
della immagine boschiniana si sovrappone in
gran parte all'esame delia posizione specificamente
artistica del Nostro, vogliamo adesso soltanto os
servare tra i versi della Carta le caratteristiche
del ritmo.
Noi conosciamo le aspirazioni musicali della,
poesia secentesca: aspirazioni che perfettamente
raggiunte in qualche verso, hanno poi a lotlare
per il resto d'intere composizioni con le sovrapposte
superstizioni di molte altre tendenze: sicché la
forma metrica stessa e il concetto uccidono le
uniche possibilità artistiche. Nel Boschini questi
contrasti intellettuali non avvengono. Il ritmo
nasce spontaneamente nella maggior parte dei
casi, come conseguenza di un ottenuto stato di
grazia; e quando non nasce — chè per quartine
e quartine a volte la monotonia dell'esposizione
addormenta autore e lettore — nessuno stridore
culturale viene a turbare lo stato di placida noia
in cui si è sdraiati. Oltre a ciò deve pur notarsi
che il ritmo facilmente ritrovabile in Boschini
non è quello più proprio del 600: l'irrequieto ritmo
impressionabile e mobile come una fonte carsica,
il ritmo che serpeggia in cerca di una forma adatta
alle sue intenzionali volute; oppure quello che
seguendo il disegno prestabilito dell'ottava cerca
nuove uscite negli scatti tronchi dei neologismi
e dei contorti rinfrescamene verbali. E un ritmo
invece alquanto anacronistico, completamente
estraneo allo svolgimento complessivo del 600
lettei ario.
Ecco una quartina pei" esempio che lo dimostra
nella più spensierata facilità. Si parla di un pittore.
Boschini è estasiato al pensiero dei suoi meriti
e tutto ardente d'ammirazione parte in giostra
per questo caracollante giretto in rima:
Lu xe in la diligenza el diligente
Lu xe l'osservator de l'osservanza
L'è un puro estrato de vera sustanza
L'è un vaso pien de balsamo ecelente.
Dove la maniera secentesca non si riconosce più
che per quel tanto che n'entra in ciascun canto
popolare di qualunque tempo esso sia. Nel primo
verso il compiacimento semplice dell'omofonia
accompagnato ancora alla coscienza del concetto
affermato; alla fine del secondo, sparizione d'ogni
altro elemento che non sia l'allegiezza per il rag-
giunto allargamento dell'assonanza; negli altri
due versi, ripercussione del culmine sonoro e chiu-
sili a degnamente vellutata del periodo.
Non si potrebbe commentare con un criterio
diverso da questo, una quartina cosiffatta, a meno
di non prendere una chitarra, e pizzicando, can-
tarla su una delle tante arie popolari che le si adat-
tano e che abbiamo sentito ripetere anche ieri da
un qualche verseggiatore stradaiolo di avveni-
menti forti.
Altre quartine si potrebbero citare in cui re-
spira completa una bella frase musicale, e a volte
anche, come ho detto, una immagine smagliante.
Perchè il canto boschiniano, e in parte anche il
pensiero, va innanzi per quartine rinsaldando anello
ad anello nel modo tradizionalmente popolare.
Una quartina deve essere compita da sola e deve
bastare ad un disegno intero di ritmo e di idea. Ma
gioverà meglio all'esame sintetico del Nostro ri-
prendere l'osservazione letteraria insieme a quella
artistica: giacché la forma poetica è unitamente
stretta nel significato estetico dell'opera, all'es-
senza mentale e alla visione critica che dobbiamo
rintracciare.
Basti per ora l'aver tolto il bizzarro poema ve-
neziano a uno sprezzo tradizionale non meritato
e che pur lo avvolgeva nei rispetti della valu-
tazione letteraria; e aver lievemente accennato
all'errore che generalmente si commette classifi-
candolo tra le composizioni più prettamente secen-
tesche di gusto e di carattere. I.a Carta è un feno-
meno di poesia popolare, nulla più; e letteraria-
mente non appartiene ad alcun tempo determinato.
Il 600 non conta per lei come legame di asservi-
mento culturale, ma, se mai, come ambiente atto
ad essere facilmente dominato da elementi forte-
mente spontanei e mobili; talché 1? materiale
esistenza dell'opera così come è stata, non pensata,
ma scritta, si deve certamente all'esserci stato al
mondo una buona pasta di secolo come il deci-
mosettimo.
* * *
Un esempio della maniera con cui procede la
tessitura del pensiero boschiniano: il 1" » Vento »
della Carta.