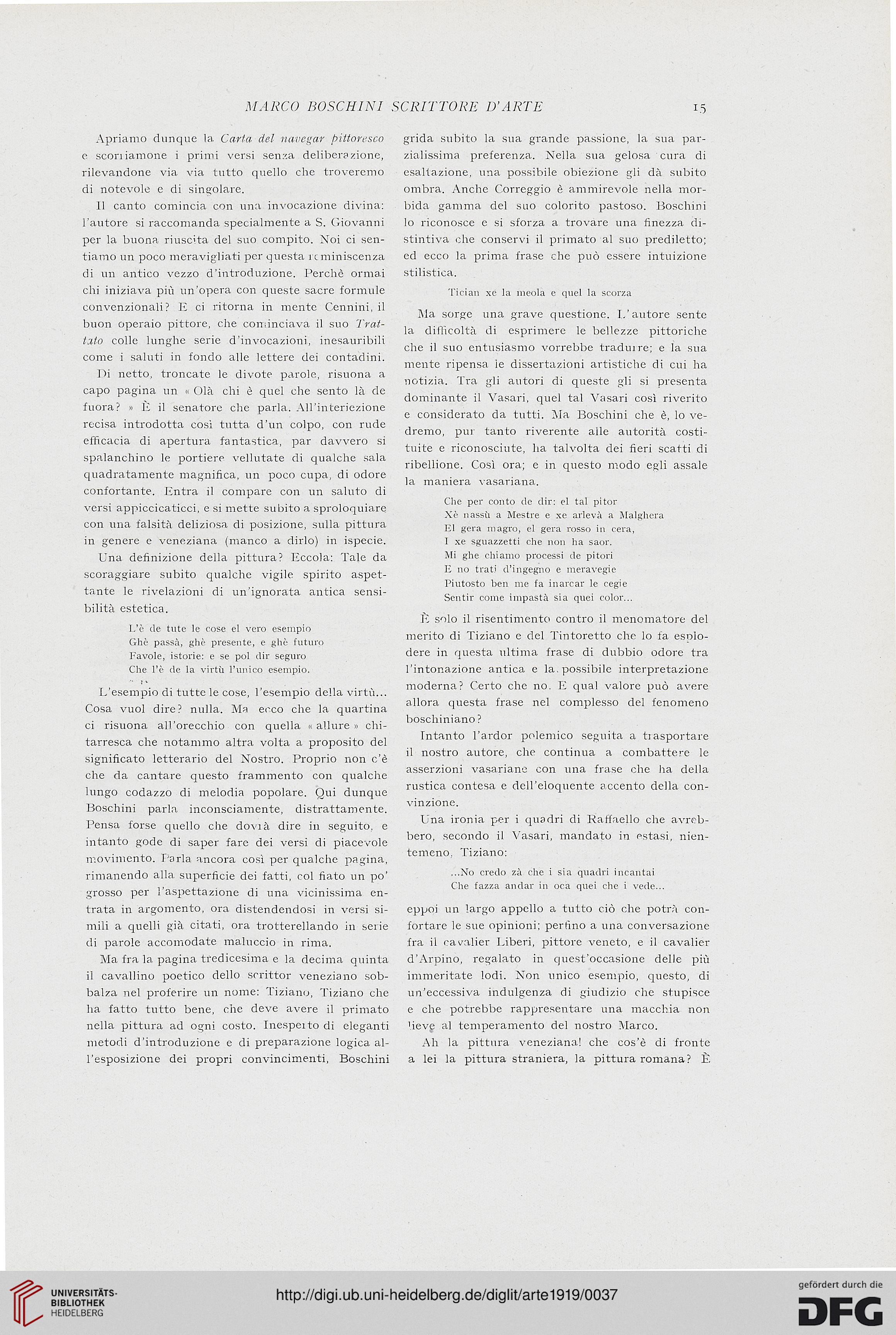MARCO BOSCHINI SCRITTORE D'ARTE
15
Apriamo dunque la Carta del navegar pittoresco
e scoriiamone i primi versi senza deliberazione,
rilevandone via. via tutto quello che troveremo
di notevole e di singolare.
11 canto comincia con una invocazione divina:
l'autore si raccomanda specialmente a S. Giovanni
per la buona riuscita del suo compito. Noi ci sen-
tiamo un poco meravigliati per questa reminiscenza
di un antico vezzo d'introduzione. Perchè orma.i
chi iniziava più un'opera con queste sacre formule
convenzionali? 1-2 ci ritorna in mente Cennini.il
buon operaio pittore, che cominciava il suo Trat-
tato colle lunghe serie d'invocazioni, inesauribili
come i saluti in fondo alle lettere dei contadini.
Hi netto, troncate le divote parole, risuona a
capo pagina un « Olà chi è quel che sento là de
fuora? » È il senatore che parla. All'interiezione
recisa introdotta così tutta d'un colpo, con rude
efficacia di apertura fantastica, par davvero si
spalanchino le portiere vellutate di qualche sala
quadratamente magnifica, un poco cupa, di odore
confortante. Entra il compare con un saluto di
versi appiccicaticci, e si mette subito a sproloquiare
con una falsità deliziosa di posizione, sulla pittura
in genere e veneziana (manco a dirlo) in ispecie.
Una definizione della pittura? Eccola: Tale da
scoraggiare subito qualche vigile spirito aspet-
tante le rivelazioni di un'ignorata antica sensi-
bilità estetica.
L'è de tute le cose el vero esempio
Ghè passa, ghè presente, e ghè futuro
Favole, istorie: e se poi dir seguro
Che l'è de la virtù l'unico esempio.
L'esempio di tutte le cose, l'esempio della virtù...
Cosa vuol dire? nulla. Ma ecco che la quartina
ci risuona all'orecchio con quella « allure » chi-
tarresca che notammo altra volta a proposito del
significato letterario del Nostro. Proprio non c'è
che da cantare questo frammento con qualche
lungo codazzo di melodia popolare. Qui dunque
Boschini parla inconsciamente, distrattamente.
Pensa forse quello che dovià dire in seguito, e
intanto gode di saper fare dei versi di piacevole
movimento. Parla ancora cosi per qualche pagina,
rimanendo alla superficie dei fatti, col fiato un po'
grosso per l'aspettazione di una vicinissima en-
trata in argomento, ora distendendosi in versi si-
mili a quelli già citati, ora trotterellando in serie
di parole accomodate maluccio in rima.
Ma fra la pagina tredicesima e la decima quinta
il cavallino poetico dello scrittoi- veneziano sob-
balza nel proferire un nome: Tiziano, Tiziano che
ha fatto tutto bene, che deve avere il primato
nella pittura ad ogni costo. Inespeito di eleganti
metodi d'introduzione e di preparazione logica al-
l'esposizione dei propri convincimenti, Boschini
grida subito la sua grande passione, la sua par-
zialissima preferenza. Nella sua gelosa cura di
esaltazione, una possibile obiezione gli dà subito
ombra. Anche Correggio è ammirevole nella mor-
bida gamma del suo colorito pastoso. Boschini
10 riconosce e si sforza a trovare una finezza di-
stintiva, che conservi il primato al suo prediletto;
ed ecco la prima frase che può essere intuizione
stilistica.
Ti clan xé la meola e quel la scorza
Ma sorge una grave questione. L'autore sente
la difficoltà di esprimere le bellezze pittoriche
che il suo entusiasmo vorrebbe tradurre; e la sua
mente ripensa le dissertazioni artistiche di cui ha
notizia. Tra gli autori di queste gli si presenta
dominante il Vasari, quel tal Vasari così riverito
e considerato da tutti. Ma Boschini che è, lo ve-
dremo, pur tanto riverente alle autorità costi-
tuite e riconosciute, ha talvolta dei fieri scatti di
ribellione. Così ora; e in questo modo egli assale
la maniera vasariana.
Che per conto de dir: el tal pitor
Xè nassù a Mestre e xe arlevà a Malghera
El gera magro, el gera rosso in cera,
I xe sguazzetti che non ha saor.
Mi ghe chiamo processi de pitòri
E no frati d'ingegno e meravegie
Piutosto ben me fa inarcar le cegie
Sentir come impasta sia quei color...
E solo il risentimento contro il menomatore del
merito di Tiziano c del Tintoretto che lo fa esplo-
dere in questa ultima frase di dubbio odore tra
l'intonazione antica e la. possibile interpretazione
moderna? Certo che no. E qual valore può avere
allora questa frase nel complesso del fenomeno
boschiniano ?
Intanto l'ardor polemico seguita a trasportare
11 nostro autore, che continua a combattere le
asserzioni vasariane con una frase che ha della
rustica contesa e dell'eloquente accento della con-
vinzione.
Lina ironia per i quadri di Raffaello che avreb-
bero, secondo il Vasari, mandato in estasi, nien-
temeno, Tiziano:
...No credo zà che i sia quadri incantai
Che tazza andar in oca quei che i vede...
eppoi un largo appello a tutto ciò che potrà con-
fortare le sue opinioni; perfino a una conversazione
fra il cavalier Liberi, pittore veneto, e il cavalier
d'Arpino, regalato in quest'occasione delle più
immeritate lodi. Non unico esempio, questo, di
un'eccessiva indulgenza di giudizio che stupisce
e che potrebbe rappresentare una macchia non
heve al temperamento del nostro Marco.
Ah la pittura veneziana! che cos'è di fronte
a lei la pittura straniera, la pittura romana? È
15
Apriamo dunque la Carta del navegar pittoresco
e scoriiamone i primi versi senza deliberazione,
rilevandone via. via tutto quello che troveremo
di notevole e di singolare.
11 canto comincia con una invocazione divina:
l'autore si raccomanda specialmente a S. Giovanni
per la buona riuscita del suo compito. Noi ci sen-
tiamo un poco meravigliati per questa reminiscenza
di un antico vezzo d'introduzione. Perchè orma.i
chi iniziava più un'opera con queste sacre formule
convenzionali? 1-2 ci ritorna in mente Cennini.il
buon operaio pittore, che cominciava il suo Trat-
tato colle lunghe serie d'invocazioni, inesauribili
come i saluti in fondo alle lettere dei contadini.
Hi netto, troncate le divote parole, risuona a
capo pagina un « Olà chi è quel che sento là de
fuora? » È il senatore che parla. All'interiezione
recisa introdotta così tutta d'un colpo, con rude
efficacia di apertura fantastica, par davvero si
spalanchino le portiere vellutate di qualche sala
quadratamente magnifica, un poco cupa, di odore
confortante. Entra il compare con un saluto di
versi appiccicaticci, e si mette subito a sproloquiare
con una falsità deliziosa di posizione, sulla pittura
in genere e veneziana (manco a dirlo) in ispecie.
Una definizione della pittura? Eccola: Tale da
scoraggiare subito qualche vigile spirito aspet-
tante le rivelazioni di un'ignorata antica sensi-
bilità estetica.
L'è de tute le cose el vero esempio
Ghè passa, ghè presente, e ghè futuro
Favole, istorie: e se poi dir seguro
Che l'è de la virtù l'unico esempio.
L'esempio di tutte le cose, l'esempio della virtù...
Cosa vuol dire? nulla. Ma ecco che la quartina
ci risuona all'orecchio con quella « allure » chi-
tarresca che notammo altra volta a proposito del
significato letterario del Nostro. Proprio non c'è
che da cantare questo frammento con qualche
lungo codazzo di melodia popolare. Qui dunque
Boschini parla inconsciamente, distrattamente.
Pensa forse quello che dovià dire in seguito, e
intanto gode di saper fare dei versi di piacevole
movimento. Parla ancora cosi per qualche pagina,
rimanendo alla superficie dei fatti, col fiato un po'
grosso per l'aspettazione di una vicinissima en-
trata in argomento, ora distendendosi in versi si-
mili a quelli già citati, ora trotterellando in serie
di parole accomodate maluccio in rima.
Ma fra la pagina tredicesima e la decima quinta
il cavallino poetico dello scrittoi- veneziano sob-
balza nel proferire un nome: Tiziano, Tiziano che
ha fatto tutto bene, che deve avere il primato
nella pittura ad ogni costo. Inespeito di eleganti
metodi d'introduzione e di preparazione logica al-
l'esposizione dei propri convincimenti, Boschini
grida subito la sua grande passione, la sua par-
zialissima preferenza. Nella sua gelosa cura di
esaltazione, una possibile obiezione gli dà subito
ombra. Anche Correggio è ammirevole nella mor-
bida gamma del suo colorito pastoso. Boschini
10 riconosce e si sforza a trovare una finezza di-
stintiva, che conservi il primato al suo prediletto;
ed ecco la prima frase che può essere intuizione
stilistica.
Ti clan xé la meola e quel la scorza
Ma sorge una grave questione. L'autore sente
la difficoltà di esprimere le bellezze pittoriche
che il suo entusiasmo vorrebbe tradurre; e la sua
mente ripensa le dissertazioni artistiche di cui ha
notizia. Tra gli autori di queste gli si presenta
dominante il Vasari, quel tal Vasari così riverito
e considerato da tutti. Ma Boschini che è, lo ve-
dremo, pur tanto riverente alle autorità costi-
tuite e riconosciute, ha talvolta dei fieri scatti di
ribellione. Così ora; e in questo modo egli assale
la maniera vasariana.
Che per conto de dir: el tal pitor
Xè nassù a Mestre e xe arlevà a Malghera
El gera magro, el gera rosso in cera,
I xe sguazzetti che non ha saor.
Mi ghe chiamo processi de pitòri
E no frati d'ingegno e meravegie
Piutosto ben me fa inarcar le cegie
Sentir come impasta sia quei color...
E solo il risentimento contro il menomatore del
merito di Tiziano c del Tintoretto che lo fa esplo-
dere in questa ultima frase di dubbio odore tra
l'intonazione antica e la. possibile interpretazione
moderna? Certo che no. E qual valore può avere
allora questa frase nel complesso del fenomeno
boschiniano ?
Intanto l'ardor polemico seguita a trasportare
11 nostro autore, che continua a combattere le
asserzioni vasariane con una frase che ha della
rustica contesa e dell'eloquente accento della con-
vinzione.
Lina ironia per i quadri di Raffaello che avreb-
bero, secondo il Vasari, mandato in estasi, nien-
temeno, Tiziano:
...No credo zà che i sia quadri incantai
Che tazza andar in oca quei che i vede...
eppoi un largo appello a tutto ciò che potrà con-
fortare le sue opinioni; perfino a una conversazione
fra il cavalier Liberi, pittore veneto, e il cavalier
d'Arpino, regalato in quest'occasione delle più
immeritate lodi. Non unico esempio, questo, di
un'eccessiva indulgenza di giudizio che stupisce
e che potrebbe rappresentare una macchia non
heve al temperamento del nostro Marco.
Ah la pittura veneziana! che cos'è di fronte
a lei la pittura straniera, la pittura romana? È