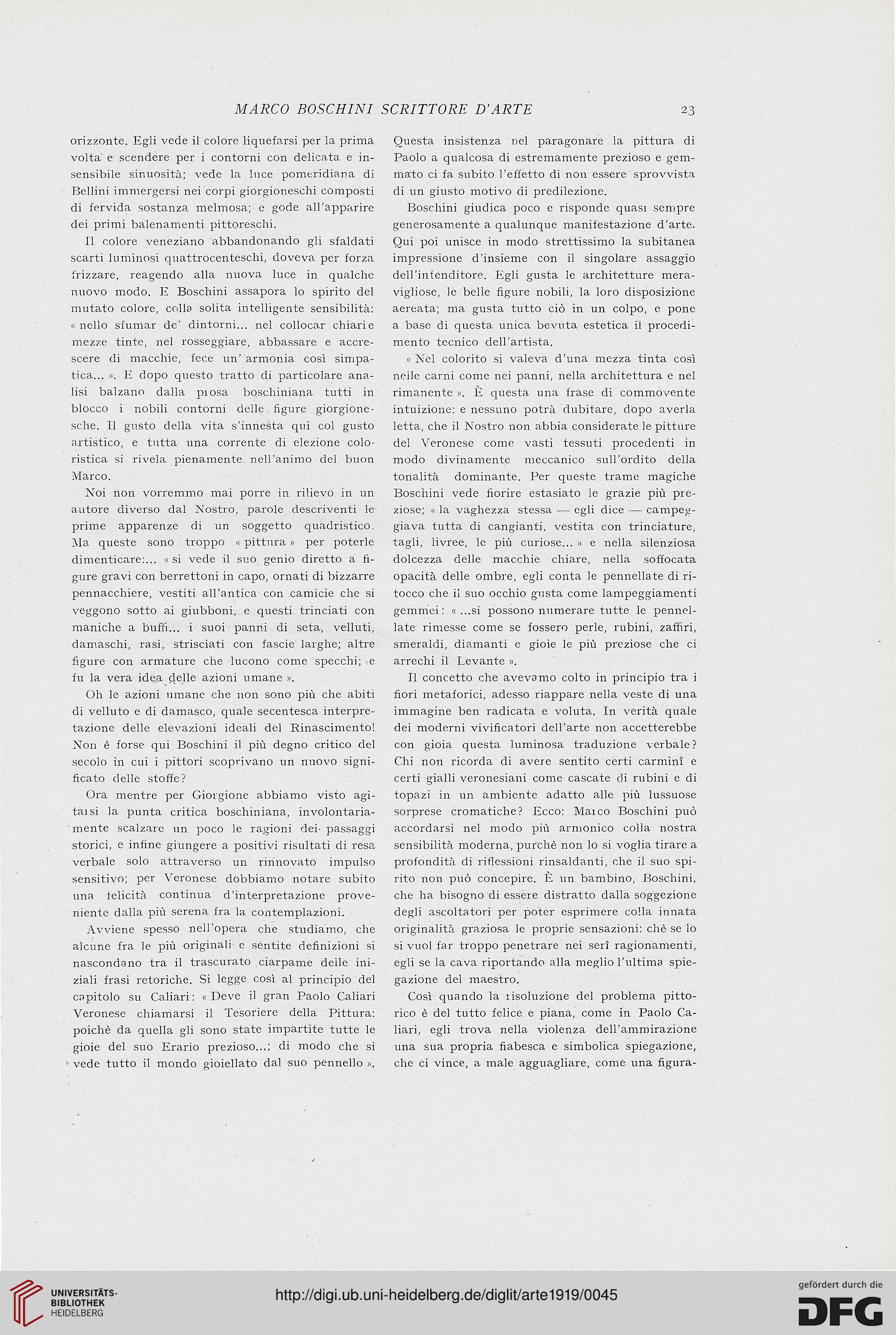MARCO BOSCHINI SCRITTORE D'ARTE
23
orizzonte. Egli vede il colore liquefarsi per la prima
volta e scendere per i contorni con delicata e in-
sensibile sinuosità; vede la luce pomeridiana di
Bellini immergersi nei corpi giorgioneschi composti
di fervida sostanza melmosa; e gode all'apparire
dei primi balenamenti pittoreschi.
E colore veneziano abbandonando gli sfaldati
scarti luminosi quattrocenteschi, doveva per forza
frizzare, reagendo alla nuova luce in qualche
nuovo modo. E Boschini assapora lo spirito del
mutato colore, colla solita intelligente sensibilità:
« nello sfumar de' dintorni... nel collocar chiarie
mezze tinte, nel rosseggiare, abbassare e accre-
scere di macchie, fece un' armonia così simpa-
tica... ». E dopo questo trattò di particolare ana-
lisi balzano dalla pi osa boschiniana tutti in
blocco i nobili contorni delle. figure giorgione-
sche. Il gusto della vita s'innesta qui col gusto
artistico, e tutta una corrente di elezione colo-
ristica si rivela pienamente nell'animo del buon
Marco.
Noi non vorremmo mai porre in rilievo in un
autore diverso dal Nostro, parole descriventi le
prime apparenze di un soggetto quadristico.
Ma queste sono troppo « pittura » per poterle
dimenticare:... « si vede il suo genio diretto a fi-
gure gravi con berrettoni in capo, ornati di bizzarre
pennacchiere, vestiti all'antica con camicie che si
veggono sotto ai giubboni, e questi trinciati con
maniche a buffi... i suoi panni di seta, velluti,
damaschi, rasi, strisciati con fascie larghe; altre
figure con armature che lucono come specchi; e
fu la vera idea delle azioni umane ».
Oh le azioni umane che non sono più che abiti
di velluto e di damasco, quale secentesca interpre-
tazione delle elevazioni ideali del Rinascimento!
Non è forse qui Boschini il più degno critico del
secolo in cui i pittori scoprivano un nuovo signi-
ficato delle stoffe?
Ora mentre per Giorgione abbiamo visto agi-
tarsi la punta critica boschiniana, involontaria-
mente scalzare un poco le ragioni dei- passaggi
storici, e infine giungere a positivi risultati di resa
verbale solo attraverso un rinnovato impulso
sensitivo; per Veronese dobbiamo notare subito
una felicità continua d'interpretazione prove-
niente dalla più serena fra la contemplazioni.
Avviene spesso nell'opera che studiamo, che
alcune fra le più originali e sentite definizioni si
nascondano tra il trascurato ciarpame delle ini-
ziali frasi retoriche. Si legge così al principio del
capitolo su Caliari: «Deve il gran Paolo Caliari
Veronese chiamarsi il Tesoriere della Pittura:
poiché da quella gli sono state impartite tutte le
gioie del suo Erario prezioso...; di modo che si
vede tutto il mondo gioiellato dal suo pennello ».
Questa insistenza nel paragonare la pittura di
Paolo a qualcosa di estremamente prezioso e gem-
mato ci fa subito l'effetto di non essere sprovvista
di un giusto motivo di predilezione.
Boschini giudica poco e risponde quasi sempre
generosamente a qualunque manifestazione d'arte.
Qui poi unisce in modo strettissimo la subitanea
impressione d'insieme con il singolare assaggio
dell'intenditore. Egli gusta le architetture mera-
vigliose, le belle figure nobili, la loro disposizione
aereata; ma gusta tutto ciò in un colpo, e pone
a base di questa unica bevuta estetica il procedi-
mento tecnico dell'artista.
« Nel colorito si valeva d'una mezza tinta così
neile carni come nei panni, nella architettura e nel
rimanente ». È questa una frase di commovente
intuizione: e nessuno potrà dubitare, dopo averla
letta, che il Nostro non abbia considerate le pitture
del Veronese come vasti tessuti procedenti in
modo divinamente meccanico sull'ordito della
tonalità dominante. Per queste trame magiche
Boschini vede fiorire estasiato le grazie più pre-
ziose; « la vaghezza stessa — egli dice — campeg-
giava tutta di cangianti, vestita con trinciature,
tagli, livree, le più curiose... » e nella silenziosa
dolcezza delle macchie chiare, nella soffocata
opacità delle ombre, egli conta le pennellate di ri-
tocco che il suo occhio gusta come lampeggiamenti
gemmei : « ...si possono numerare tutte le pennel-
late rimesse come se fossero perle, rubini, zaffiri,
smeraldi, diamanti e gioie le più preziose che ci
arrechi il Levante ».
Il concetto che avevamo colto in principio tra i
fiori metaforici, adesso riappare nella veste di una
immagine ben radicata e voluta. In verità quale
dei moderni vivificatori dell'arte non accetterebbe
con gioia questa luminosa traduzione verbale?
Chi non ricorda di avere sentito certi carmini e
certi gialli veronesiani come cascate eli rubini e di
topazi in un ambiente adatto alle più lussuose
sorprese cromatiche? Ecco: Mai co Boschini può
accordarsi nel modo più armonico colla nostra
sensibilità moderna, purché non lo si voglia tirare a
profondità di riflessioni rinsaldanti, che il suo spi-
rito non può concepire. E un bambino, Boschini,
che ha bisogno di essere distratto dalla soggezione
degli ascoltatori per poter esprimere colla innata
originalità graziosa le proprie sensazioni: chè se lo
si vuol far troppo penetrare nei seri ragionamenti,
egli se la cava riportando alla meglio l'ultima spie-
gazione del maestro.
Così quando la lisoluzione del problema pitto-
rico è del tutto felice e piana, come in Paolo Ca-
liari, egli trova nella violenza dell'ammirazione
una sua propria fiabesca e simbolica spiegazione,
che ci vince, a male agguagliare, come una figura-
23
orizzonte. Egli vede il colore liquefarsi per la prima
volta e scendere per i contorni con delicata e in-
sensibile sinuosità; vede la luce pomeridiana di
Bellini immergersi nei corpi giorgioneschi composti
di fervida sostanza melmosa; e gode all'apparire
dei primi balenamenti pittoreschi.
E colore veneziano abbandonando gli sfaldati
scarti luminosi quattrocenteschi, doveva per forza
frizzare, reagendo alla nuova luce in qualche
nuovo modo. E Boschini assapora lo spirito del
mutato colore, colla solita intelligente sensibilità:
« nello sfumar de' dintorni... nel collocar chiarie
mezze tinte, nel rosseggiare, abbassare e accre-
scere di macchie, fece un' armonia così simpa-
tica... ». E dopo questo trattò di particolare ana-
lisi balzano dalla pi osa boschiniana tutti in
blocco i nobili contorni delle. figure giorgione-
sche. Il gusto della vita s'innesta qui col gusto
artistico, e tutta una corrente di elezione colo-
ristica si rivela pienamente nell'animo del buon
Marco.
Noi non vorremmo mai porre in rilievo in un
autore diverso dal Nostro, parole descriventi le
prime apparenze di un soggetto quadristico.
Ma queste sono troppo « pittura » per poterle
dimenticare:... « si vede il suo genio diretto a fi-
gure gravi con berrettoni in capo, ornati di bizzarre
pennacchiere, vestiti all'antica con camicie che si
veggono sotto ai giubboni, e questi trinciati con
maniche a buffi... i suoi panni di seta, velluti,
damaschi, rasi, strisciati con fascie larghe; altre
figure con armature che lucono come specchi; e
fu la vera idea delle azioni umane ».
Oh le azioni umane che non sono più che abiti
di velluto e di damasco, quale secentesca interpre-
tazione delle elevazioni ideali del Rinascimento!
Non è forse qui Boschini il più degno critico del
secolo in cui i pittori scoprivano un nuovo signi-
ficato delle stoffe?
Ora mentre per Giorgione abbiamo visto agi-
tarsi la punta critica boschiniana, involontaria-
mente scalzare un poco le ragioni dei- passaggi
storici, e infine giungere a positivi risultati di resa
verbale solo attraverso un rinnovato impulso
sensitivo; per Veronese dobbiamo notare subito
una felicità continua d'interpretazione prove-
niente dalla più serena fra la contemplazioni.
Avviene spesso nell'opera che studiamo, che
alcune fra le più originali e sentite definizioni si
nascondano tra il trascurato ciarpame delle ini-
ziali frasi retoriche. Si legge così al principio del
capitolo su Caliari: «Deve il gran Paolo Caliari
Veronese chiamarsi il Tesoriere della Pittura:
poiché da quella gli sono state impartite tutte le
gioie del suo Erario prezioso...; di modo che si
vede tutto il mondo gioiellato dal suo pennello ».
Questa insistenza nel paragonare la pittura di
Paolo a qualcosa di estremamente prezioso e gem-
mato ci fa subito l'effetto di non essere sprovvista
di un giusto motivo di predilezione.
Boschini giudica poco e risponde quasi sempre
generosamente a qualunque manifestazione d'arte.
Qui poi unisce in modo strettissimo la subitanea
impressione d'insieme con il singolare assaggio
dell'intenditore. Egli gusta le architetture mera-
vigliose, le belle figure nobili, la loro disposizione
aereata; ma gusta tutto ciò in un colpo, e pone
a base di questa unica bevuta estetica il procedi-
mento tecnico dell'artista.
« Nel colorito si valeva d'una mezza tinta così
neile carni come nei panni, nella architettura e nel
rimanente ». È questa una frase di commovente
intuizione: e nessuno potrà dubitare, dopo averla
letta, che il Nostro non abbia considerate le pitture
del Veronese come vasti tessuti procedenti in
modo divinamente meccanico sull'ordito della
tonalità dominante. Per queste trame magiche
Boschini vede fiorire estasiato le grazie più pre-
ziose; « la vaghezza stessa — egli dice — campeg-
giava tutta di cangianti, vestita con trinciature,
tagli, livree, le più curiose... » e nella silenziosa
dolcezza delle macchie chiare, nella soffocata
opacità delle ombre, egli conta le pennellate di ri-
tocco che il suo occhio gusta come lampeggiamenti
gemmei : « ...si possono numerare tutte le pennel-
late rimesse come se fossero perle, rubini, zaffiri,
smeraldi, diamanti e gioie le più preziose che ci
arrechi il Levante ».
Il concetto che avevamo colto in principio tra i
fiori metaforici, adesso riappare nella veste di una
immagine ben radicata e voluta. In verità quale
dei moderni vivificatori dell'arte non accetterebbe
con gioia questa luminosa traduzione verbale?
Chi non ricorda di avere sentito certi carmini e
certi gialli veronesiani come cascate eli rubini e di
topazi in un ambiente adatto alle più lussuose
sorprese cromatiche? Ecco: Mai co Boschini può
accordarsi nel modo più armonico colla nostra
sensibilità moderna, purché non lo si voglia tirare a
profondità di riflessioni rinsaldanti, che il suo spi-
rito non può concepire. E un bambino, Boschini,
che ha bisogno di essere distratto dalla soggezione
degli ascoltatori per poter esprimere colla innata
originalità graziosa le proprie sensazioni: chè se lo
si vuol far troppo penetrare nei seri ragionamenti,
egli se la cava riportando alla meglio l'ultima spie-
gazione del maestro.
Così quando la lisoluzione del problema pitto-
rico è del tutto felice e piana, come in Paolo Ca-
liari, egli trova nella violenza dell'ammirazione
una sua propria fiabesca e simbolica spiegazione,
che ci vince, a male agguagliare, come una figura-