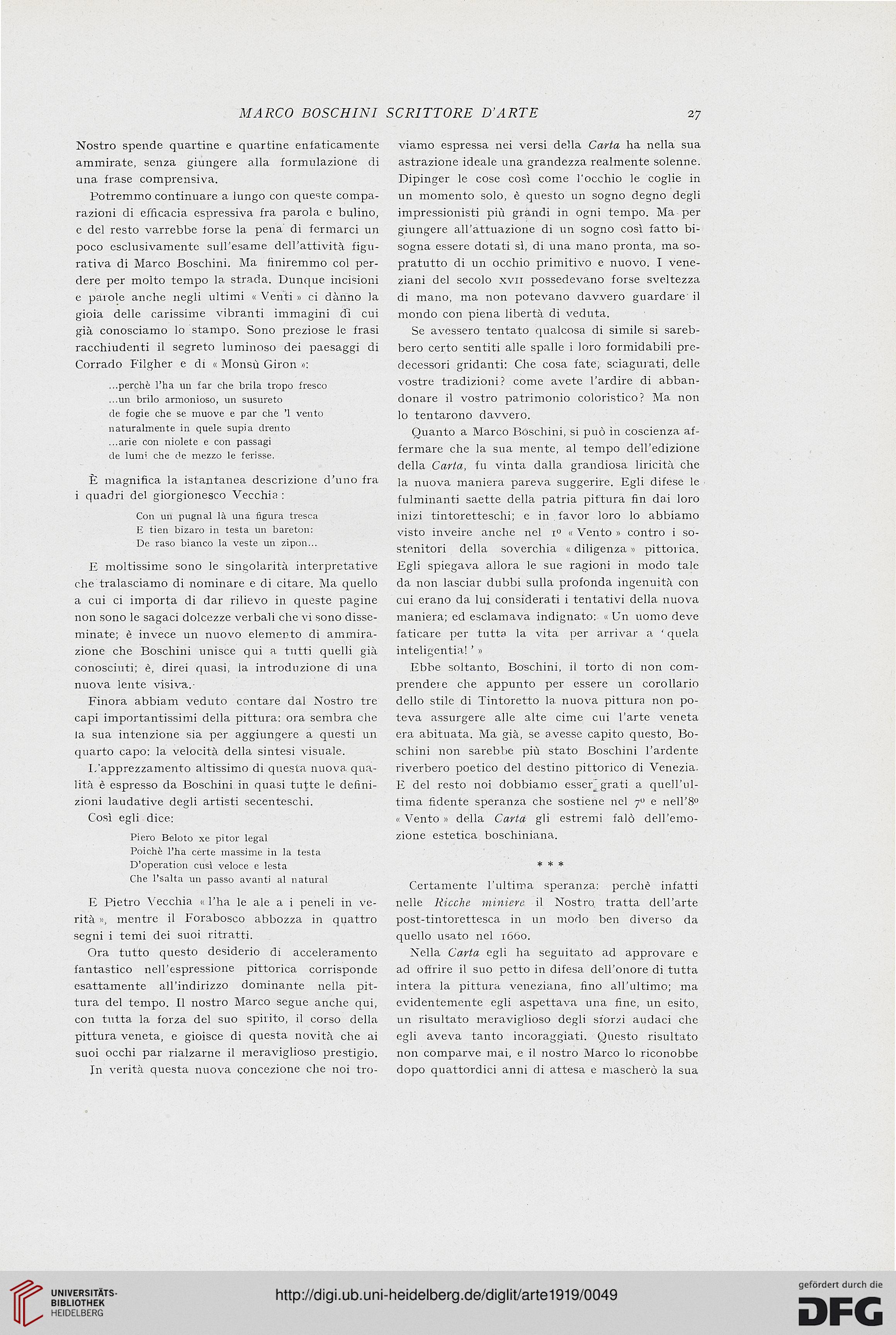MARCO BOSCHINI SCRITTORE D'ARTE
27
Nostro spende quartine e quartine enfaticamente
ammirate, senza giungere alla formulazione di
una frase comprensiva.
Potremmo continuare a lungo con queste compa-
razioni di efficacia espressiva fra parola e bulino,
e del resto varrebbe torse la pena di fermarci un
poco esclusivamente sull'esame dell'attività figu-
rativa di Marco Boschini. Ma finiremmo col per-
dere per molto tempo la strada. Dunque incisioni
e parole anche negli ultimi « Venti » ci danno la
gioia delle carissime vibranti immagini di cui
già conosciamo lo stampo. Sono preziose le frasi
racchiudenti il segreto luminoso dei paesaggi di
Corrado Filgher e di « Monsù Giron ■>:
...perchè l'ha un far che brila tropo fresco
...un brilo armonioso, un susureto
de fogie che se muove e par che '1 vento
naturalmente in quele supìa drento
...arie con niolete e con passagi
de lumi che de mezzo le ferisse.
È magnifica la istantanea descrizione d'uno fra
i quadri del giorgionesco Vecchia :
Con un pugnai là una figura tresca
E tien bizaro in testa un bareton:
De raso bianco la veste un zipoli...
E moltissime sono le singolarità interpretative
che tralasciamo di nominare e di citare. Ma quello
a cui ci importa di dar rilievo in queste pagine
non sono le sagaci dolcezze verbali che vi sono disse-
minate; è invece un nuovo elemento di ammira-
zione che Boschini unisce qui a tutti quelli già
conosciuti; è, direi quasi, la introduzione di una
nuova lente visiva.-
Finora abbiam veduto contare dal Nostro tre
capi importantissimi della pittura: ora sembra che
la sua intenzione sia per aggiungere a questi un
quarto capo: la velocità della sintesi visuale.
L'apprezzamento altissimo di questa nuova qua-
lità è espresso da Boschini in quasi tu^te le defini-
zioni laudative degli artisti secenteschi.
Così egli dice:
Piero Beloto xe pitor legai
Poiché l'ha certe massime in la testa
D'operation cusi veloce e lesta
Che l'salta un passo avanti al naturai
E Pietro Vecchia « l'ha le ale a i peneli in ve-
rità », mentre il Forabosco abbozza in quattro
segni i temi dei suoi ritratti.
Ora tutto questo desiderio di acceleramento
fantastico nell'espressione pittorica corrisponde
esattamente all'indirizzo dominante nella pit-
tura del tempo. Il nostro Marco segue anche qui,
con tutta la forza del suo spirito, il corso della
pittura veneta, e gioisce di questa novità che ai
suoi occhi par rialzarne il meraviglioso prestigio.
In verità questa nuova concezione che noi tro-
viamo espressa nei versi della Carta ha nella sua
astrazione ideale una grandezza realmente solenne.
Dipinger le cose così come l'occhio le coglie in
un momento solo, è questo un sogno degno degli
impressionisti più grandi in ogni tempo. Ma-per
giungere all'attuazione di un sogno così fatto bi-
sogna essere dotati sì, di una mano pronta, ma so-
pratutto di un occhio primitivo e nuovo. I vene-
ziani del secolo xvn possedevano forse sveltezza
di mano, ma non potevano davvero guardare' il
mondo con piena libertà di veduta.
Se avessero tentato qualcosa di simile si sareb-
bero certo sentiti alle spalle i loro formidabili pre-
decessori gridanti: Che cosa fate, sciagurati, delle
vostre tradizioni? come avete l'ardire di abban-
donare il vostro patrimonio coloristico? Ma non
lo tentarono davvero.
Quanto a Marco Boschini, si può in coscienza af-
fermare che la sua mente, al tempo dell'edizione
della Carta, fu vinta dalla grandiosa liricità che
la nuova maniera pareva suggerire. Egli difese le
fulminanti saette della patria pittura fin dai loro
inizi tintoretteschi; c in favor loro lo abbiamo
visto inveire anche nel i° « Vento » contro i so-
stenitori della soverchia « diligenza » pittorica.
Egli spiegava allora le sue ragioni in modo tale
da non lasciar dubbi sulla profonda ingenuità con
cui erano da lui considerati i tentativi della nuova
maniera; ed esclamava indignato: « Un uomo deve
faticare per tutta la vita per arrivar a ' quela
inteligentia! ' »
Ebbe soltanto, Boschini, il torto di non com-
prendere che appunto per essere un corollario
dello stile di Tintoretto la nuova pittura non po-
teva assurgere alle alte cime cui l'arte veneta
era abituata. Ma già, se avesse capito questo, Bo-
schini non sarebbe più stato Boschini l'ardente
riverbero poetico del destino pittorico di Venezia.
E del resto noi dobbiamo esser grati a quell'ul-
tima fidente speranza che sostiene nel 7" e nell'8°
«Vento» della Carta gli estremi falò dell'emo-
zione estetica boschiniana.
Certamente l'ultima speranza: perchè infatti
nelle Ricche miniere il Nostro, tratta dell'arte
post-tintorettesca in un modo ben diverso da
quello usato nel 1600.
Nella Carta egli ha seguitato ad approvare e
ad offrire il suo petto in difesa dell'onore di tutta
intera la pittura veneziana, fino all'ultimo; ma
evidentemente egli aspettava una fine, un esito,
un risultato meraviglioso degli sforzi audaci che
egli aveva tanto incoraggiati. Questo risultato
non comparve mai, e il nostro Marco lo riconobbe
dopo quattordici anni di attesa e mascherò la sua
27
Nostro spende quartine e quartine enfaticamente
ammirate, senza giungere alla formulazione di
una frase comprensiva.
Potremmo continuare a lungo con queste compa-
razioni di efficacia espressiva fra parola e bulino,
e del resto varrebbe torse la pena di fermarci un
poco esclusivamente sull'esame dell'attività figu-
rativa di Marco Boschini. Ma finiremmo col per-
dere per molto tempo la strada. Dunque incisioni
e parole anche negli ultimi « Venti » ci danno la
gioia delle carissime vibranti immagini di cui
già conosciamo lo stampo. Sono preziose le frasi
racchiudenti il segreto luminoso dei paesaggi di
Corrado Filgher e di « Monsù Giron ■>:
...perchè l'ha un far che brila tropo fresco
...un brilo armonioso, un susureto
de fogie che se muove e par che '1 vento
naturalmente in quele supìa drento
...arie con niolete e con passagi
de lumi che de mezzo le ferisse.
È magnifica la istantanea descrizione d'uno fra
i quadri del giorgionesco Vecchia :
Con un pugnai là una figura tresca
E tien bizaro in testa un bareton:
De raso bianco la veste un zipoli...
E moltissime sono le singolarità interpretative
che tralasciamo di nominare e di citare. Ma quello
a cui ci importa di dar rilievo in queste pagine
non sono le sagaci dolcezze verbali che vi sono disse-
minate; è invece un nuovo elemento di ammira-
zione che Boschini unisce qui a tutti quelli già
conosciuti; è, direi quasi, la introduzione di una
nuova lente visiva.-
Finora abbiam veduto contare dal Nostro tre
capi importantissimi della pittura: ora sembra che
la sua intenzione sia per aggiungere a questi un
quarto capo: la velocità della sintesi visuale.
L'apprezzamento altissimo di questa nuova qua-
lità è espresso da Boschini in quasi tu^te le defini-
zioni laudative degli artisti secenteschi.
Così egli dice:
Piero Beloto xe pitor legai
Poiché l'ha certe massime in la testa
D'operation cusi veloce e lesta
Che l'salta un passo avanti al naturai
E Pietro Vecchia « l'ha le ale a i peneli in ve-
rità », mentre il Forabosco abbozza in quattro
segni i temi dei suoi ritratti.
Ora tutto questo desiderio di acceleramento
fantastico nell'espressione pittorica corrisponde
esattamente all'indirizzo dominante nella pit-
tura del tempo. Il nostro Marco segue anche qui,
con tutta la forza del suo spirito, il corso della
pittura veneta, e gioisce di questa novità che ai
suoi occhi par rialzarne il meraviglioso prestigio.
In verità questa nuova concezione che noi tro-
viamo espressa nei versi della Carta ha nella sua
astrazione ideale una grandezza realmente solenne.
Dipinger le cose così come l'occhio le coglie in
un momento solo, è questo un sogno degno degli
impressionisti più grandi in ogni tempo. Ma-per
giungere all'attuazione di un sogno così fatto bi-
sogna essere dotati sì, di una mano pronta, ma so-
pratutto di un occhio primitivo e nuovo. I vene-
ziani del secolo xvn possedevano forse sveltezza
di mano, ma non potevano davvero guardare' il
mondo con piena libertà di veduta.
Se avessero tentato qualcosa di simile si sareb-
bero certo sentiti alle spalle i loro formidabili pre-
decessori gridanti: Che cosa fate, sciagurati, delle
vostre tradizioni? come avete l'ardire di abban-
donare il vostro patrimonio coloristico? Ma non
lo tentarono davvero.
Quanto a Marco Boschini, si può in coscienza af-
fermare che la sua mente, al tempo dell'edizione
della Carta, fu vinta dalla grandiosa liricità che
la nuova maniera pareva suggerire. Egli difese le
fulminanti saette della patria pittura fin dai loro
inizi tintoretteschi; c in favor loro lo abbiamo
visto inveire anche nel i° « Vento » contro i so-
stenitori della soverchia « diligenza » pittorica.
Egli spiegava allora le sue ragioni in modo tale
da non lasciar dubbi sulla profonda ingenuità con
cui erano da lui considerati i tentativi della nuova
maniera; ed esclamava indignato: « Un uomo deve
faticare per tutta la vita per arrivar a ' quela
inteligentia! ' »
Ebbe soltanto, Boschini, il torto di non com-
prendere che appunto per essere un corollario
dello stile di Tintoretto la nuova pittura non po-
teva assurgere alle alte cime cui l'arte veneta
era abituata. Ma già, se avesse capito questo, Bo-
schini non sarebbe più stato Boschini l'ardente
riverbero poetico del destino pittorico di Venezia.
E del resto noi dobbiamo esser grati a quell'ul-
tima fidente speranza che sostiene nel 7" e nell'8°
«Vento» della Carta gli estremi falò dell'emo-
zione estetica boschiniana.
Certamente l'ultima speranza: perchè infatti
nelle Ricche miniere il Nostro, tratta dell'arte
post-tintorettesca in un modo ben diverso da
quello usato nel 1600.
Nella Carta egli ha seguitato ad approvare e
ad offrire il suo petto in difesa dell'onore di tutta
intera la pittura veneziana, fino all'ultimo; ma
evidentemente egli aspettava una fine, un esito,
un risultato meraviglioso degli sforzi audaci che
egli aveva tanto incoraggiati. Questo risultato
non comparve mai, e il nostro Marco lo riconobbe
dopo quattordici anni di attesa e mascherò la sua