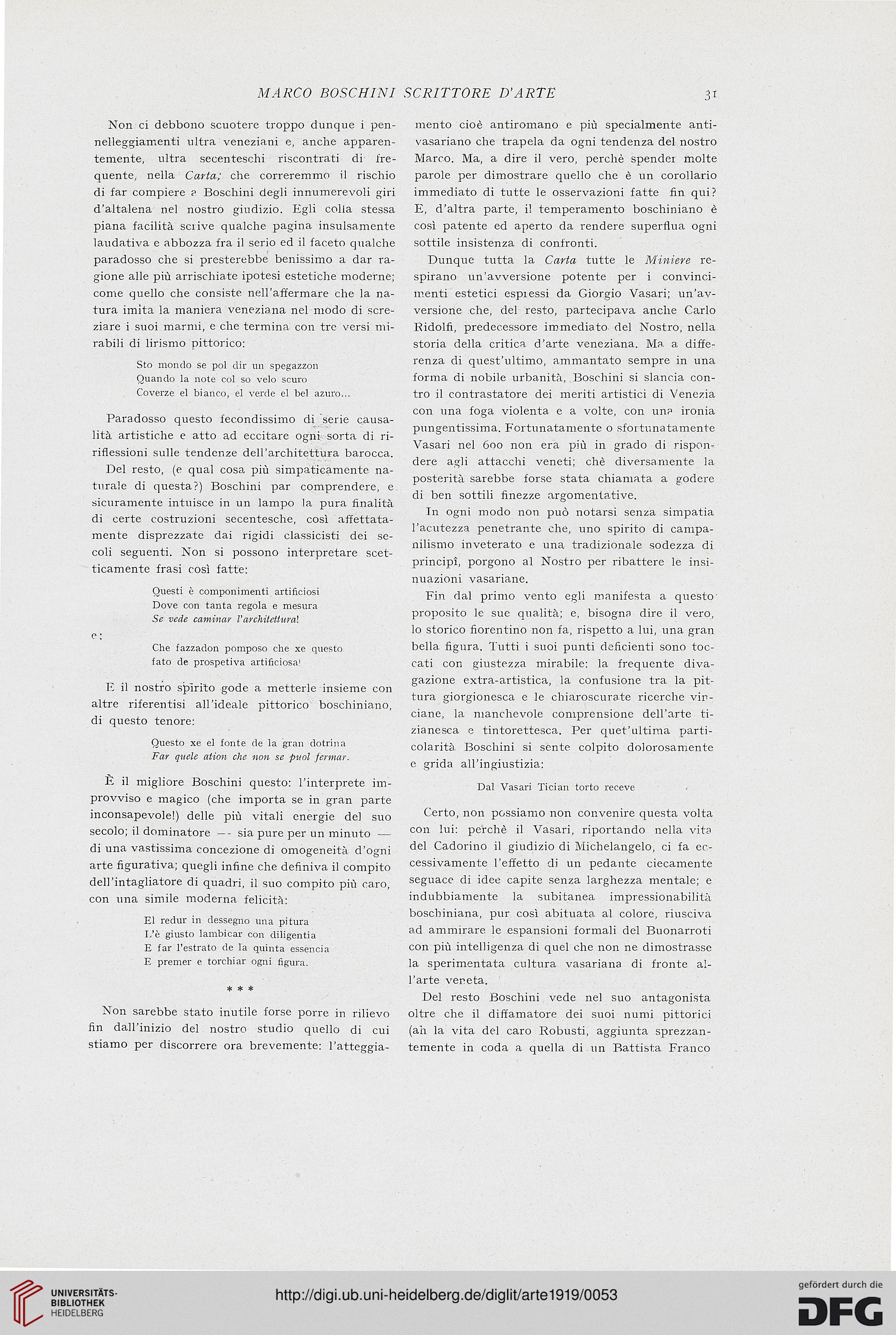MARCO BOSCHI NI SCRITTORE D'ARTE
3i
Non ci debbono scuotere troppo dunque i pen-
nelleggiamenti ultra veneziani e, anche apparen-
temente, ultra secenteschi riscontrati di i're-
qucnte, nella Carta; che correremmo il rischio
di far compiere ;> Boschini degli innumerevoli giri
d'altalena nel nostro giudizio. Egli colla stessa
piana facilità sciive qualche pagina insulsamente
laudativa e abbozza fra il serio ed il faceto qualche
paradosso che si presterebbe benissimo a dar ra-
gione alle più arrischiate ipotesi estetiche moderne;
come quello che consiste nell'affermare che la na-
tura imita la maniera veneziana nel modo di scre-
ziare i suoi marmi, e che termina con tre versi mi-
rabili di lirismo pittorico:
Sto mondo se poi dir un spegazzon
Quando la note col so velo scuro
Coverze el bianco, el verde el bel azuro...
Paradosso questo fecondissimo di "serie causa-
lità artistiche e atto ad eccitare ogni sorta di ri-
riflessioni sulle tendenze dell'architettura barocca.
Del resto, (e qual cosa più simpaticamente na-
turale di questa?) Boschini par comprendere, e
sicuramente intuisce in un lampo la pura finalità
di certe costruzioni secentesche, così affettata-
mente disprezzate dai rigidi classicisti dei se-
coli seguenti. Non si possono interpretare scet-
ticamente frasi così fatte:
Questi è componimenti artificiosi
Dove con tanta regola e mesura
Se vede caminar l'architettural
e :
Che fazzadon pomposo che xe questo
fato de prospetiva artificiosa1
E il nostro spìrito gode a metterle insieme con
altre riferentisi all'ideale pittorico boschiniano,
di questo tenore:
Questo xe el fonte de la gran dotrina
Far quele ation che non se puoi fermar.
È il migliore Boschini questo: l'interprete im-
provviso e magico (che importa se in gran parte
inconsapevole!) delle più vitali energie del suo
secolo; il dominatore -- sia pure per un minuto -
di una vastissima concezione di omogeneità d'ogni
arte figurativa; quegli infine che definiva il compito
dell'intagliatore di quadri, il suo compito più caro,
con una simile moderna felicità:
El redur in dessegno una pi tura
L'è giusto lambicar con diligentia
E far l'estrato de la quinta essencia
E premer e torchiar ogni figura.
* * *
Non sarebbe stato inutile forse porre in rilievo
fin dall'inizio del nostro studio quello di cui
stiamo per discorrere ora brevemente: l'atteggia-
mento cioè antiromano e più specialmente anti-
vasariano che trapela da ogni tendenza del nostro
Marco. Ma, a dire il vero, perchè spender molte
parole per dimostrare quello che è un corollario
immediato di tutte le osservazioni fatte fin qui?
E, d'altra parte, il temperamento boschiniano è
così patente ed aperto da rendere superflua ogni
sottile insistenza di confronti.
Dunque tutta la Carta tutte le Miniere re-
spirano un'avversione potente per i convinci-
menti estetici espiessi da Giorgio Vasari; un'av-
versione che, del resto, partecipava anche Carlo
Ridolfi, predecessore immediato del Nostro, nella
storia della critica d'arte veneziana. Ma a diffe-
renza di quest'ultimo, ammantato sempre in una
forma di nobile urbanità, Boschini si slancia con-
tro il contrastatore dei meriti artistici di Venezia
con una foga violenta e a volte, con una ironia
pungentissima. Fortunatamente o sfortunatamente
Vasari nel óoo non era più in grado di rispon-
dere agli attacchi veneti; chè diversamente la
posterità sarebbe forse stata chiamata a godere
di ben sottili finezze argomentative.
In ogni modo non può notarsi senza simpatia
l'acutezza penetrante che, uno spirito di campa-
nilismo inveterato e una tradizionale sodezza di
principi, porgono al Nostro per ribattere le insi-
nuazioni vasariane.
Fin dal primo vento egli manifesta a questo
proposito le sue qualità; e, bisogna dire il vero,
lo storico fiorentino non fa, rispetto a lui, una gran
bella figura. Tutti i suoi punti deficienti sono toc-
cati con giustezza mirabile: la frequente diva-
gazione extra-artistica, la confusione tra la pit-
tura giorgionesca e le chiaroscurate ricerche vip-
ciane, la manchevole comprensione dell'arte ti-
zianesca e tintorettesca. Per quet'ultima parti-
colarità Boschini si sente colpito dolorosamente
e grida all'ingiustizia:
Dal Vasari Tician torto reeeve
Certo, non possiamo non convenire questa volta
con lui: perchè il Vasari, riportando nella vita
del Cadorino il giudizio di Michelangelo, ci fa ec-
cessivamente l'effetto di un pedante ciecamente
seguace di idee capite senza larghezza mentale; e
indubbiamente la subitanea impressionabilità
boschiniana, pur così abituata al colore, riusciva
ad ammirare le espansioni formali del Buonarroti
con più intelligenza di quel che non ne dimostrasse
la sperimentata cultura vasariana di fronte al-
l'arte veneta.
Del resto Boschini vede nel suo antagonista
oltre che il diffamatore dei suoi numi pittorici
(ah la vita del caro Robusti, aggiunta sprezzan-
temente in coda a quella di un Battista Franco
3i
Non ci debbono scuotere troppo dunque i pen-
nelleggiamenti ultra veneziani e, anche apparen-
temente, ultra secenteschi riscontrati di i're-
qucnte, nella Carta; che correremmo il rischio
di far compiere ;> Boschini degli innumerevoli giri
d'altalena nel nostro giudizio. Egli colla stessa
piana facilità sciive qualche pagina insulsamente
laudativa e abbozza fra il serio ed il faceto qualche
paradosso che si presterebbe benissimo a dar ra-
gione alle più arrischiate ipotesi estetiche moderne;
come quello che consiste nell'affermare che la na-
tura imita la maniera veneziana nel modo di scre-
ziare i suoi marmi, e che termina con tre versi mi-
rabili di lirismo pittorico:
Sto mondo se poi dir un spegazzon
Quando la note col so velo scuro
Coverze el bianco, el verde el bel azuro...
Paradosso questo fecondissimo di "serie causa-
lità artistiche e atto ad eccitare ogni sorta di ri-
riflessioni sulle tendenze dell'architettura barocca.
Del resto, (e qual cosa più simpaticamente na-
turale di questa?) Boschini par comprendere, e
sicuramente intuisce in un lampo la pura finalità
di certe costruzioni secentesche, così affettata-
mente disprezzate dai rigidi classicisti dei se-
coli seguenti. Non si possono interpretare scet-
ticamente frasi così fatte:
Questi è componimenti artificiosi
Dove con tanta regola e mesura
Se vede caminar l'architettural
e :
Che fazzadon pomposo che xe questo
fato de prospetiva artificiosa1
E il nostro spìrito gode a metterle insieme con
altre riferentisi all'ideale pittorico boschiniano,
di questo tenore:
Questo xe el fonte de la gran dotrina
Far quele ation che non se puoi fermar.
È il migliore Boschini questo: l'interprete im-
provviso e magico (che importa se in gran parte
inconsapevole!) delle più vitali energie del suo
secolo; il dominatore -- sia pure per un minuto -
di una vastissima concezione di omogeneità d'ogni
arte figurativa; quegli infine che definiva il compito
dell'intagliatore di quadri, il suo compito più caro,
con una simile moderna felicità:
El redur in dessegno una pi tura
L'è giusto lambicar con diligentia
E far l'estrato de la quinta essencia
E premer e torchiar ogni figura.
* * *
Non sarebbe stato inutile forse porre in rilievo
fin dall'inizio del nostro studio quello di cui
stiamo per discorrere ora brevemente: l'atteggia-
mento cioè antiromano e più specialmente anti-
vasariano che trapela da ogni tendenza del nostro
Marco. Ma, a dire il vero, perchè spender molte
parole per dimostrare quello che è un corollario
immediato di tutte le osservazioni fatte fin qui?
E, d'altra parte, il temperamento boschiniano è
così patente ed aperto da rendere superflua ogni
sottile insistenza di confronti.
Dunque tutta la Carta tutte le Miniere re-
spirano un'avversione potente per i convinci-
menti estetici espiessi da Giorgio Vasari; un'av-
versione che, del resto, partecipava anche Carlo
Ridolfi, predecessore immediato del Nostro, nella
storia della critica d'arte veneziana. Ma a diffe-
renza di quest'ultimo, ammantato sempre in una
forma di nobile urbanità, Boschini si slancia con-
tro il contrastatore dei meriti artistici di Venezia
con una foga violenta e a volte, con una ironia
pungentissima. Fortunatamente o sfortunatamente
Vasari nel óoo non era più in grado di rispon-
dere agli attacchi veneti; chè diversamente la
posterità sarebbe forse stata chiamata a godere
di ben sottili finezze argomentative.
In ogni modo non può notarsi senza simpatia
l'acutezza penetrante che, uno spirito di campa-
nilismo inveterato e una tradizionale sodezza di
principi, porgono al Nostro per ribattere le insi-
nuazioni vasariane.
Fin dal primo vento egli manifesta a questo
proposito le sue qualità; e, bisogna dire il vero,
lo storico fiorentino non fa, rispetto a lui, una gran
bella figura. Tutti i suoi punti deficienti sono toc-
cati con giustezza mirabile: la frequente diva-
gazione extra-artistica, la confusione tra la pit-
tura giorgionesca e le chiaroscurate ricerche vip-
ciane, la manchevole comprensione dell'arte ti-
zianesca e tintorettesca. Per quet'ultima parti-
colarità Boschini si sente colpito dolorosamente
e grida all'ingiustizia:
Dal Vasari Tician torto reeeve
Certo, non possiamo non convenire questa volta
con lui: perchè il Vasari, riportando nella vita
del Cadorino il giudizio di Michelangelo, ci fa ec-
cessivamente l'effetto di un pedante ciecamente
seguace di idee capite senza larghezza mentale; e
indubbiamente la subitanea impressionabilità
boschiniana, pur così abituata al colore, riusciva
ad ammirare le espansioni formali del Buonarroti
con più intelligenza di quel che non ne dimostrasse
la sperimentata cultura vasariana di fronte al-
l'arte veneta.
Del resto Boschini vede nel suo antagonista
oltre che il diffamatore dei suoi numi pittorici
(ah la vita del caro Robusti, aggiunta sprezzan-
temente in coda a quella di un Battista Franco