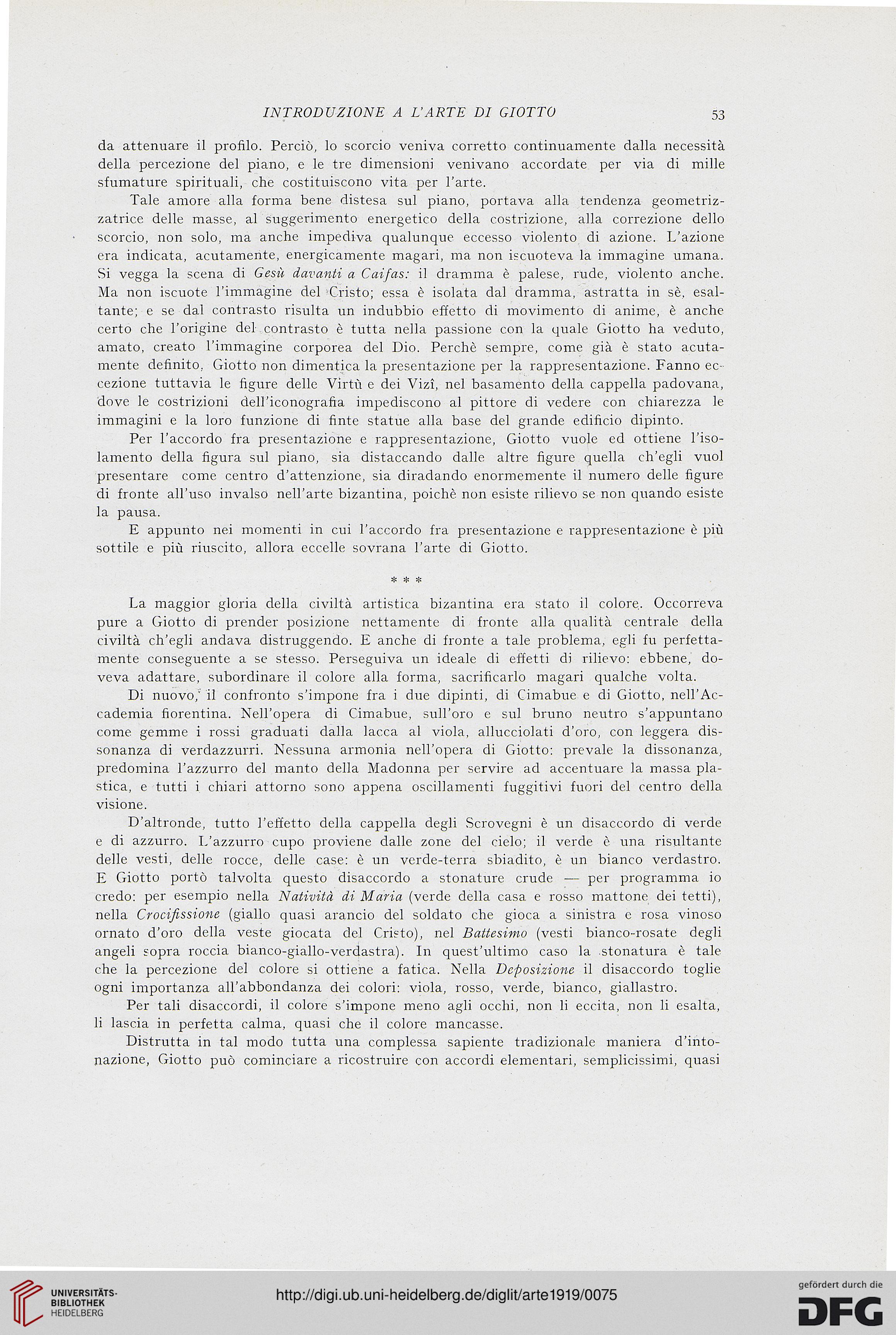INTRODUZIONE A L'ARTE DI GIOTTO
53
da attenuare il profilo. Perciò, lo scorcio veniva corretto continuamente dalla necessità
della percezione del piano, e le tre dimensioni venivano accordate per via di mille
sfumature spirituali, che costituiscono vita per l'arte.
Tale amore alla forma bene distesa sul piano, portava alla tendenza geometriz-
zatrice delle masse, al suggerimento energetico della costrizione, alla correzione dello
scorcio, non solo, ma anche impediva qualunque eccesso violento di azione. L'azione
era indicata, acutamente, energicamente magari, ma non iscuoteva la immagine umana.
Si vegga la scena di Gesù davanti a Caifas: il dramma è palese, rude, violento anche.
Ma non iscuote l'immagine del Cristo; essa è isolata dal dramma, astratta in sè, esal-
tante; e se dal contrasto risulta un indubbio effetto di movimento di anime, è anche
certo che l'origine del contrasto è tutta nella passione con la quale Giotto ha veduto,
amato, creato l'immagine corporea del Dio. Perchè sempre, come già è stato acuta-
mente definito, Giotto non dimentica la presentazione per la rappresentazione. Fanno ec-
cezione tuttavia le figure delle Virtù e dei Vizi, nel basamento della cappella padovana,
dove le costrizioni dell'iconografia impediscono al pittore di vedere con chiarezza le
immagini e la loro funzione di finte statue alla base del grande edificio dipinto.
Per l'accordo fra presentazione e rappresentazione, Giotto vuole ed ottiene l'iso-
lamento della figura sul piano, sia distaccando dalle altre figure quella ch'egli vuol
presentare come centro d'attenzione, sia diradando enormemente il numero delle figure
di fronte all'uso invalso nell'arte bizantina, poiché non esiste rilievo se non quando esiste
la pausa.
E appunto nei momenti in cui l'accordo fra presentazione e rappresentazione è più
sottile e più riuscito, allora eccelle sovrana l'arte di Giotto.
* * *
La maggior gloria della civiltà artistica bizantina era stato il colore. Occorreva
pure a Giotto di prender posizione nettamente di fronte alla qualità centrale della
civiltà ch'egli andava distruggendo. E anche di fronte a tale problema, egli fu perfetta-
mente conseguente a se stesso. Perseguiva un ideale di effetti di rilievo: ebbene, do-
veva adattare, subordinare il colore alla forma, sacrificarlo magari qualche volta.
Di nuovo; il confronto s'impone fra i due dipinti, di Cimabue e di Giotto, nell'Ac-
cademia fiorentina. Nell'opera di Cimabue, sull'oro e sul bruno neutro s'appuntano
come gemme i rossi graduati dalla lacca al viola, allucciolati d'oro, con leggera dis-
sonanza di verdazzurri. Nessuna armonia nell'opera di Giotto: prevale la dissonanza,
predomina l'azzurro del manto della Madonna per servire ad accentuare la massa pla-
stica, e tutti i chiari attorno sono appena oscillamenti fuggitivi fuori del centro della
visione.
D'altronde, tutto l'effetto della cappella degli Scrovegni è un disaccordo di verde
e di azzurro. L'azzurro cupo proviene dalle zone del cielo; il verde è una risultante
delle vesti, delle rocce, delle case: è un verde-terra sbiadito, è un bianco verdastro.
E Giotto portò talvolta questo disaccordo a stonature crude — per programma io
credo: per esempio nella Natività di Maria (verde della casa e rosso mattone dei tetti),
nella Crocifissione (giallo quasi arancio del soldato che gioca a sinistra e rosa vinoso
ornato d'oro della veste giocata del Cristo), nel Battesimo (vesti bianco-rosate degli
angeli sopra roccia bianco-giallo-verdastra). In quest'ultimo caso la stonatura è tale
che la percezione del colore si ottiene a fatica. Nella Deposizione il disaccordo toglie
ogni importanza all'abbondanza dei colori: viola, rosso, verde, bianco, giallastro.
Per tali disaccordi, il colore s'impone meno agli occhi, non li eccita, non li esalta,
li lascia in perfetta calma, quasi che il colore mancasse.
Distrutta in tal modo tutta una complessa sapiente tradizionale maniera d'into-
nazione, Giotto può cominciare a ricostruire con accordi elementari, semplicissimi, quasi
53
da attenuare il profilo. Perciò, lo scorcio veniva corretto continuamente dalla necessità
della percezione del piano, e le tre dimensioni venivano accordate per via di mille
sfumature spirituali, che costituiscono vita per l'arte.
Tale amore alla forma bene distesa sul piano, portava alla tendenza geometriz-
zatrice delle masse, al suggerimento energetico della costrizione, alla correzione dello
scorcio, non solo, ma anche impediva qualunque eccesso violento di azione. L'azione
era indicata, acutamente, energicamente magari, ma non iscuoteva la immagine umana.
Si vegga la scena di Gesù davanti a Caifas: il dramma è palese, rude, violento anche.
Ma non iscuote l'immagine del Cristo; essa è isolata dal dramma, astratta in sè, esal-
tante; e se dal contrasto risulta un indubbio effetto di movimento di anime, è anche
certo che l'origine del contrasto è tutta nella passione con la quale Giotto ha veduto,
amato, creato l'immagine corporea del Dio. Perchè sempre, come già è stato acuta-
mente definito, Giotto non dimentica la presentazione per la rappresentazione. Fanno ec-
cezione tuttavia le figure delle Virtù e dei Vizi, nel basamento della cappella padovana,
dove le costrizioni dell'iconografia impediscono al pittore di vedere con chiarezza le
immagini e la loro funzione di finte statue alla base del grande edificio dipinto.
Per l'accordo fra presentazione e rappresentazione, Giotto vuole ed ottiene l'iso-
lamento della figura sul piano, sia distaccando dalle altre figure quella ch'egli vuol
presentare come centro d'attenzione, sia diradando enormemente il numero delle figure
di fronte all'uso invalso nell'arte bizantina, poiché non esiste rilievo se non quando esiste
la pausa.
E appunto nei momenti in cui l'accordo fra presentazione e rappresentazione è più
sottile e più riuscito, allora eccelle sovrana l'arte di Giotto.
* * *
La maggior gloria della civiltà artistica bizantina era stato il colore. Occorreva
pure a Giotto di prender posizione nettamente di fronte alla qualità centrale della
civiltà ch'egli andava distruggendo. E anche di fronte a tale problema, egli fu perfetta-
mente conseguente a se stesso. Perseguiva un ideale di effetti di rilievo: ebbene, do-
veva adattare, subordinare il colore alla forma, sacrificarlo magari qualche volta.
Di nuovo; il confronto s'impone fra i due dipinti, di Cimabue e di Giotto, nell'Ac-
cademia fiorentina. Nell'opera di Cimabue, sull'oro e sul bruno neutro s'appuntano
come gemme i rossi graduati dalla lacca al viola, allucciolati d'oro, con leggera dis-
sonanza di verdazzurri. Nessuna armonia nell'opera di Giotto: prevale la dissonanza,
predomina l'azzurro del manto della Madonna per servire ad accentuare la massa pla-
stica, e tutti i chiari attorno sono appena oscillamenti fuggitivi fuori del centro della
visione.
D'altronde, tutto l'effetto della cappella degli Scrovegni è un disaccordo di verde
e di azzurro. L'azzurro cupo proviene dalle zone del cielo; il verde è una risultante
delle vesti, delle rocce, delle case: è un verde-terra sbiadito, è un bianco verdastro.
E Giotto portò talvolta questo disaccordo a stonature crude — per programma io
credo: per esempio nella Natività di Maria (verde della casa e rosso mattone dei tetti),
nella Crocifissione (giallo quasi arancio del soldato che gioca a sinistra e rosa vinoso
ornato d'oro della veste giocata del Cristo), nel Battesimo (vesti bianco-rosate degli
angeli sopra roccia bianco-giallo-verdastra). In quest'ultimo caso la stonatura è tale
che la percezione del colore si ottiene a fatica. Nella Deposizione il disaccordo toglie
ogni importanza all'abbondanza dei colori: viola, rosso, verde, bianco, giallastro.
Per tali disaccordi, il colore s'impone meno agli occhi, non li eccita, non li esalta,
li lascia in perfetta calma, quasi che il colore mancasse.
Distrutta in tal modo tutta una complessa sapiente tradizionale maniera d'into-
nazione, Giotto può cominciare a ricostruire con accordi elementari, semplicissimi, quasi