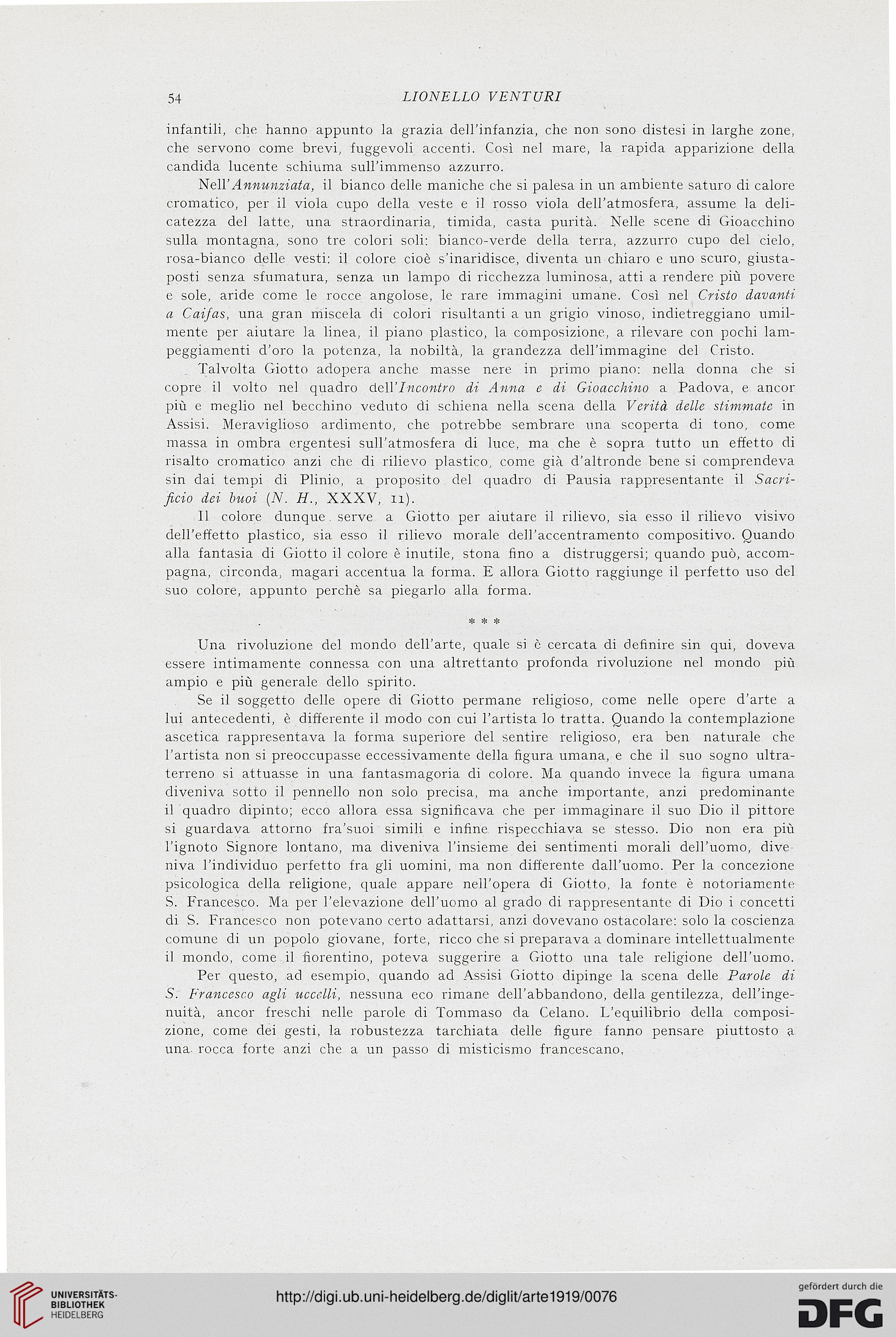54
LIONELLO VENTURI
infantili, che hanno appunto la grazia dell'infanzia, che non sono distesi in larghe zone,
che servono come brevi, fuggevoli accenti. Così nel mare, la rapida apparizione della
candida lucente schiuma sull'immenso azzurro.
Neil'Annunziata, il bianco delle maniche che si palesa in un ambiente saturo di calore
cromatico, per il viola cupo della veste e il rosso viola dell'atmosfera, assume la deli-
catezza del latte, una straordinaria, timida, casta purità. Nelle scene di Gioacchino
sulla montagna, sono tre colori soli: bianco-verde della terra, azzurro cupo del cielo,
rosa-bianco delle vesti: il colore cioè s'inaridisce, diventa un chiaro e uno scuro, giusta-
posti senza sfumatura, senza un lampo di ricchezza luminosa, atti a rendere più povere
e sole, aride come le rocce angolose, le rare immagini umane. Così nel Cristo davanti
a Caifas, una gran miscela di colori risultanti a un grigio vinoso, indietreggiano umil-
mente per aiutare la linea, il piano plastico, la composizione, a rilevare con pochi lam-
peggiamenti d'oro la potenza, la nobiltà, la grandezza dell'immagine del Cristo.
Talvolta Giotto adopera anche masse nere in primo piano: nella donna che si
copre il volto nel quadro dell'Incontro di Anna e di Gioacchino a Padova, e ancor
più e meglio nel becchino veduto di schiena nella scena della Verità delle stimmate in
Assisi. Meraviglioso ardimento, che potrebbe sembrare una scoperta di tono, come
massa in ombra ergentesi sull'atmosfera di luce, ma che è sopra tutto un effetto di
risalto cromatico anzi clic di rilievo plastico, come già d'altronde bene si comprendeva
sin dai tempi di Plinio, a proposito del quadro di Pausia rappresentante il Sacri-
ficio dei buoi (A7. H., XXXV, n).
Il colore dunque . serve a Giotto per aiutare il rilievo, sia esso il rilievo visivo
dell'effetto plastico, sia esso il rilievo morale dell'accentramento compositivo. Quando
alla fantasia di Giotto il colore è inutile, stona fino a distruggersi; quando può, accom-
pagna, circonda, magari accentua la forma. E allora Giotto raggiunge il perfetto uso del
suo colore, appunto perchè sa piegarlo alla forma.
* * *
Una rivoluzione del mondo dell'arte, quale si è cercata di definire sin qui, doveva
essere intimamente connessa con una altrettanto profonda rivoluzione nel mondo più
ampio e più generale dello spirito.
Se il soggetto delle opere di Giotto permane religioso, come nelle opere d'arte a
lui antecedenti, è differente il modo con cui l'artista lo tratta. Quando la contemplazione
ascetica rappresentava la forma superiore del sentire religioso, era ben naturale che
l'artista non si preoccupasse eccessivamente della figura umana, e che il suo sogno ultra-
terreno si attuasse in una fantasmagoria di colore. Ma quando invece la figura umana
diveniva sotto il pennello non solo precisa, ma anche importante, anzi predominante
il quadro dipinto; ecco allora essa significava che per immaginare il suo Dio il pittore
si guardava attorno fra'suoi simili e infine rispecchiava se stesso. Dio non era più
l'ignoto Signore lontano, ma diveniva l'insieme dei sentimenti morali dell'uomo, dive
niva l'individuo perfetto fra gli uomini, ma non differente dall'uomo. Per la concezione
psicologica della religione, quale appare nell'opera di Giotto, la fonte è notoriamente
S. Francesco. Ma per l'elevazione dell'uomo al grado di rappresentante1 di Dio i concetti
di S. Francesco non potevano certo adattarsi, anzi dovevano ostacolare: solo la coscienza
comune di un popolo giovane, forte, ricco che si preparava a dominare intellettualmente
il mondo, come il fiorentino, poteva suggerire a Giotto una tale religione dell'uomo.
Per questo, ad esempio, quando ad Assisi (dotto dipinge la scena delle Parole di
S. Francesco agli uccelli, nessuna eco rimane dell'abbandono, della gentilezza, dell'inge-
nuità, ancor freschi nelle parole di Tommaso da Celano. L'equilibrio della composi-
zione, come dei gesti, la robustezza tarchiata delle figure fanno pensare piuttosto a
una rocca forte anzi che a un passo di misticismo francescano,
LIONELLO VENTURI
infantili, che hanno appunto la grazia dell'infanzia, che non sono distesi in larghe zone,
che servono come brevi, fuggevoli accenti. Così nel mare, la rapida apparizione della
candida lucente schiuma sull'immenso azzurro.
Neil'Annunziata, il bianco delle maniche che si palesa in un ambiente saturo di calore
cromatico, per il viola cupo della veste e il rosso viola dell'atmosfera, assume la deli-
catezza del latte, una straordinaria, timida, casta purità. Nelle scene di Gioacchino
sulla montagna, sono tre colori soli: bianco-verde della terra, azzurro cupo del cielo,
rosa-bianco delle vesti: il colore cioè s'inaridisce, diventa un chiaro e uno scuro, giusta-
posti senza sfumatura, senza un lampo di ricchezza luminosa, atti a rendere più povere
e sole, aride come le rocce angolose, le rare immagini umane. Così nel Cristo davanti
a Caifas, una gran miscela di colori risultanti a un grigio vinoso, indietreggiano umil-
mente per aiutare la linea, il piano plastico, la composizione, a rilevare con pochi lam-
peggiamenti d'oro la potenza, la nobiltà, la grandezza dell'immagine del Cristo.
Talvolta Giotto adopera anche masse nere in primo piano: nella donna che si
copre il volto nel quadro dell'Incontro di Anna e di Gioacchino a Padova, e ancor
più e meglio nel becchino veduto di schiena nella scena della Verità delle stimmate in
Assisi. Meraviglioso ardimento, che potrebbe sembrare una scoperta di tono, come
massa in ombra ergentesi sull'atmosfera di luce, ma che è sopra tutto un effetto di
risalto cromatico anzi clic di rilievo plastico, come già d'altronde bene si comprendeva
sin dai tempi di Plinio, a proposito del quadro di Pausia rappresentante il Sacri-
ficio dei buoi (A7. H., XXXV, n).
Il colore dunque . serve a Giotto per aiutare il rilievo, sia esso il rilievo visivo
dell'effetto plastico, sia esso il rilievo morale dell'accentramento compositivo. Quando
alla fantasia di Giotto il colore è inutile, stona fino a distruggersi; quando può, accom-
pagna, circonda, magari accentua la forma. E allora Giotto raggiunge il perfetto uso del
suo colore, appunto perchè sa piegarlo alla forma.
* * *
Una rivoluzione del mondo dell'arte, quale si è cercata di definire sin qui, doveva
essere intimamente connessa con una altrettanto profonda rivoluzione nel mondo più
ampio e più generale dello spirito.
Se il soggetto delle opere di Giotto permane religioso, come nelle opere d'arte a
lui antecedenti, è differente il modo con cui l'artista lo tratta. Quando la contemplazione
ascetica rappresentava la forma superiore del sentire religioso, era ben naturale che
l'artista non si preoccupasse eccessivamente della figura umana, e che il suo sogno ultra-
terreno si attuasse in una fantasmagoria di colore. Ma quando invece la figura umana
diveniva sotto il pennello non solo precisa, ma anche importante, anzi predominante
il quadro dipinto; ecco allora essa significava che per immaginare il suo Dio il pittore
si guardava attorno fra'suoi simili e infine rispecchiava se stesso. Dio non era più
l'ignoto Signore lontano, ma diveniva l'insieme dei sentimenti morali dell'uomo, dive
niva l'individuo perfetto fra gli uomini, ma non differente dall'uomo. Per la concezione
psicologica della religione, quale appare nell'opera di Giotto, la fonte è notoriamente
S. Francesco. Ma per l'elevazione dell'uomo al grado di rappresentante1 di Dio i concetti
di S. Francesco non potevano certo adattarsi, anzi dovevano ostacolare: solo la coscienza
comune di un popolo giovane, forte, ricco che si preparava a dominare intellettualmente
il mondo, come il fiorentino, poteva suggerire a Giotto una tale religione dell'uomo.
Per questo, ad esempio, quando ad Assisi (dotto dipinge la scena delle Parole di
S. Francesco agli uccelli, nessuna eco rimane dell'abbandono, della gentilezza, dell'inge-
nuità, ancor freschi nelle parole di Tommaso da Celano. L'equilibrio della composi-
zione, come dei gesti, la robustezza tarchiata delle figure fanno pensare piuttosto a
una rocca forte anzi che a un passo di misticismo francescano,