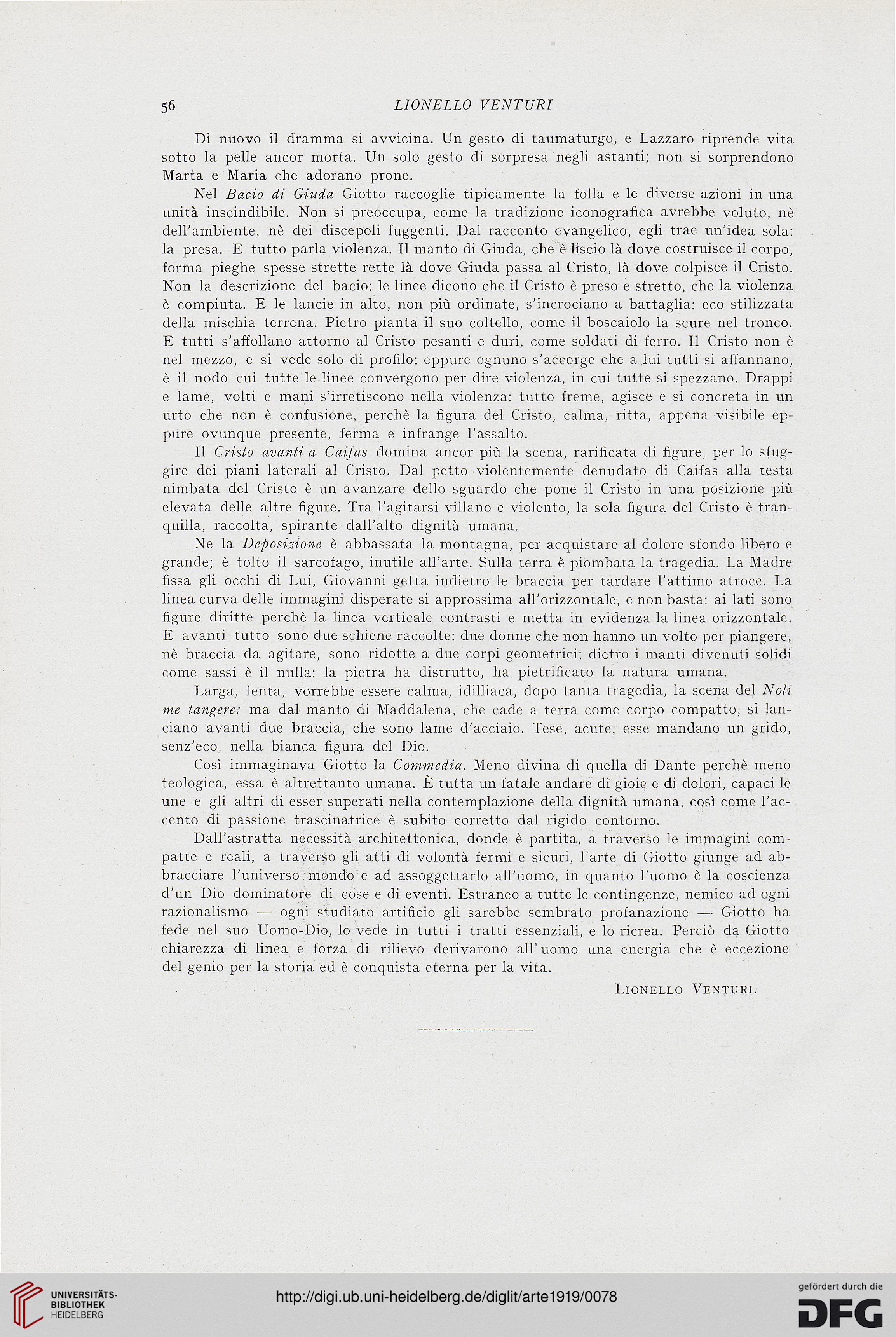56
LIONELLO VENTURI
Di nuovo il dramma si avvicina. Un gesto di taumaturgo, e Lazzaro riprende vita
sotto la pelle ancor morta. Un solo gesto di sorpresa negli astanti; non si sorprendono
Marta e Maria che adorano prone.
Nel Bacio di Giuda Giotto raccoglie tipicamente la folla e le diverse azioni in una
unità inscindibile. Non si preoccupa, come la tradizione iconografica avrebbe voluto, nè
dell'ambiente, nè dei discepoli fuggenti. Dal racconto evangelico, egli trae un'idea sola:
la presa. E tutto parla violenza. Il manto di Giuda, che è liscio là dove costruisce il corpo,
forma pieghe spesse strette rette là dove Giuda passa al Cristo, là dove colpisce il Cristo.
Non la descrizione del bacio: le linee dicono che il Cristo è preso e stretto, che la violenza
è compiuta. E le lancie in alto, non più ordinate, s'incrociano a battaglia: eco stilizzata
della mischia terrena. Pietro pianta il suo coltello, come il boscaiolo la scure nel tronco.
E tutti s'affollano attorno al Cristo pesanti e duri, come soldati di ferro. Il Cristo non è
nel mezzo, e si vede solo di profilo: eppure ognuno s'accorge che a lui tutti si affannano,
è il nodo cui tutte le linee convergono per dire violenza, in cui tutte si spezzano. Drappi
e lame, volti e mani s'irretiscono nella violenza: tutto freme, agisce e si concreta in un
urto che non è confusione, perchè la figura del Cristo, calma, ritta, appena visibile ep-
pure ovunque presente, ferma e infrange l'assalto.
Il Cristo avanti a Cai/as domina ancor più la scena, rarificata di figure, per lo sfug-
gire dei piani laterali al Cristo. Dal petto violentemente denudato di Caifas alla testa
nimbata del Cristo è un avanzare dello sguardo che pone il Cristo in una posizione più
elevata delle altre figure. Tra l'agitarsi villano e violento, la sola figura del Cristo è tran-
quilla, raccolta, spirante dall'alto dignità umana.
Ne la Deposizione è abbassata la montagna, per acquistare al dolore sfondo libero e
grande; è tolto il sarcofago, inutile all'arte. Sulla terra è piombata la tragedia. La Madre
fissa gli occhi di Lui, Giovanni getta indietro le braccia per tardare l'attimo atroce. La
linea curva delle immagini disperate si approssima all'orizzontale, e non basta: ai lati sono
figure diritte perchè la linea verticale contrasti e metta in evidenza la linea orizzontale.
E avanti tutto sono due schiene raccolte: due donne che non hanno un volto per piangere,
nè braccia da agitare, sono ridotte a due corpi geometrici; dietro i manti divenuti solidi
come sassi è il nulla: la pietra ha distrutto, ha pietrificato la natura umana.
Larga, lenta, vorrebbe essere calma, idilliaca, dopo tanta tragedia, la scena del Nolt
me tangere: ma dal manto di Maddalena, che cade a terra come corpo compatto, si lan-
ciano avanti due braccia, che sono lame d'acciaio. Tese, acute, esse mandano un grido,
senz'eco, nella bianca figura del Dio.
Così immaginava Giotto la Commedia. Meno divina di quella di Dante perchè meno
teologica, essa è altrettanto umana. È tutta un fatale andare di gioie e di dolori, capaci le
une e gli altri di esser superati nella contemplazione della dignità umana, così come l'ac-
cento di passione trascinatrice è subito corretto dal rigido contorno.
Dall'astratta necessità architettonica, donde è partita, a traverso le immagini com-
patte e reali, a traverso gli atti di volontà fermi e sicuri, l'arte di Giotto giunge ad ab-
bracciare l'universo mondo e ad assoggettarlo all'uomo, in quanto l'uomo è la coscienza
d'un Dio dominatore di cose e di eventi. Estraneo a tutte le contingenze, nemico ad ogni
razionalismo — ogni studiato artificio gli sarebbe sembrato profanazione — Giotto ha
fede nel suo Uomo-Dio, lo vede in tutti i tratti essenziali, e lo ricrea. Perciò da Giotto
chiarezza di linea e forza di rilievo derivarono all' uomo una energia che è eccezione
del genio per la storia ed è conquista eterna per la vita.
Lionello Venturi.
LIONELLO VENTURI
Di nuovo il dramma si avvicina. Un gesto di taumaturgo, e Lazzaro riprende vita
sotto la pelle ancor morta. Un solo gesto di sorpresa negli astanti; non si sorprendono
Marta e Maria che adorano prone.
Nel Bacio di Giuda Giotto raccoglie tipicamente la folla e le diverse azioni in una
unità inscindibile. Non si preoccupa, come la tradizione iconografica avrebbe voluto, nè
dell'ambiente, nè dei discepoli fuggenti. Dal racconto evangelico, egli trae un'idea sola:
la presa. E tutto parla violenza. Il manto di Giuda, che è liscio là dove costruisce il corpo,
forma pieghe spesse strette rette là dove Giuda passa al Cristo, là dove colpisce il Cristo.
Non la descrizione del bacio: le linee dicono che il Cristo è preso e stretto, che la violenza
è compiuta. E le lancie in alto, non più ordinate, s'incrociano a battaglia: eco stilizzata
della mischia terrena. Pietro pianta il suo coltello, come il boscaiolo la scure nel tronco.
E tutti s'affollano attorno al Cristo pesanti e duri, come soldati di ferro. Il Cristo non è
nel mezzo, e si vede solo di profilo: eppure ognuno s'accorge che a lui tutti si affannano,
è il nodo cui tutte le linee convergono per dire violenza, in cui tutte si spezzano. Drappi
e lame, volti e mani s'irretiscono nella violenza: tutto freme, agisce e si concreta in un
urto che non è confusione, perchè la figura del Cristo, calma, ritta, appena visibile ep-
pure ovunque presente, ferma e infrange l'assalto.
Il Cristo avanti a Cai/as domina ancor più la scena, rarificata di figure, per lo sfug-
gire dei piani laterali al Cristo. Dal petto violentemente denudato di Caifas alla testa
nimbata del Cristo è un avanzare dello sguardo che pone il Cristo in una posizione più
elevata delle altre figure. Tra l'agitarsi villano e violento, la sola figura del Cristo è tran-
quilla, raccolta, spirante dall'alto dignità umana.
Ne la Deposizione è abbassata la montagna, per acquistare al dolore sfondo libero e
grande; è tolto il sarcofago, inutile all'arte. Sulla terra è piombata la tragedia. La Madre
fissa gli occhi di Lui, Giovanni getta indietro le braccia per tardare l'attimo atroce. La
linea curva delle immagini disperate si approssima all'orizzontale, e non basta: ai lati sono
figure diritte perchè la linea verticale contrasti e metta in evidenza la linea orizzontale.
E avanti tutto sono due schiene raccolte: due donne che non hanno un volto per piangere,
nè braccia da agitare, sono ridotte a due corpi geometrici; dietro i manti divenuti solidi
come sassi è il nulla: la pietra ha distrutto, ha pietrificato la natura umana.
Larga, lenta, vorrebbe essere calma, idilliaca, dopo tanta tragedia, la scena del Nolt
me tangere: ma dal manto di Maddalena, che cade a terra come corpo compatto, si lan-
ciano avanti due braccia, che sono lame d'acciaio. Tese, acute, esse mandano un grido,
senz'eco, nella bianca figura del Dio.
Così immaginava Giotto la Commedia. Meno divina di quella di Dante perchè meno
teologica, essa è altrettanto umana. È tutta un fatale andare di gioie e di dolori, capaci le
une e gli altri di esser superati nella contemplazione della dignità umana, così come l'ac-
cento di passione trascinatrice è subito corretto dal rigido contorno.
Dall'astratta necessità architettonica, donde è partita, a traverso le immagini com-
patte e reali, a traverso gli atti di volontà fermi e sicuri, l'arte di Giotto giunge ad ab-
bracciare l'universo mondo e ad assoggettarlo all'uomo, in quanto l'uomo è la coscienza
d'un Dio dominatore di cose e di eventi. Estraneo a tutte le contingenze, nemico ad ogni
razionalismo — ogni studiato artificio gli sarebbe sembrato profanazione — Giotto ha
fede nel suo Uomo-Dio, lo vede in tutti i tratti essenziali, e lo ricrea. Perciò da Giotto
chiarezza di linea e forza di rilievo derivarono all' uomo una energia che è eccezione
del genio per la storia ed è conquista eterna per la vita.
Lionello Venturi.