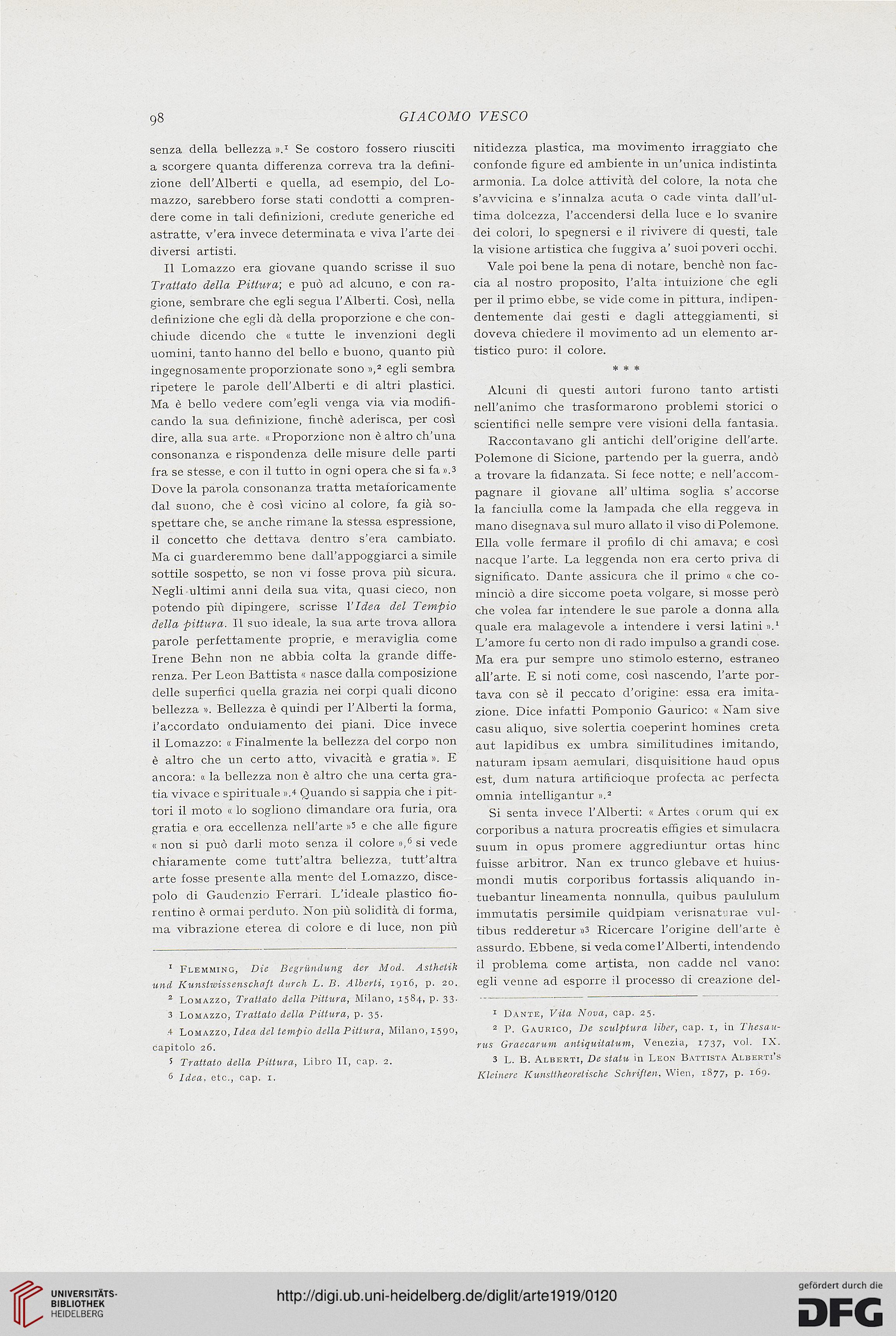98
GIACOMO VESCO
senza della bellezza d.1 Se costoro fossero riusciti
a scorgere quanta differenza correva tra la defini-
zione dell'Alberti e quella, ad esempio, del Lo-
mazzo, sarebbero forse stati condotti a compren-
dere come in tali definizioni, credute generiche ed
astratte, v'era invece determinata e viva l'arte dei
diversi artisti.
Il Lomazzo era giovane quando scrisse il suo
Trattato della Pittura; e può ad alcuno, e con ra-
gione, sembrare che egli segua l'Alberti. Cosi, nella
definizione che egli dà della proporzione e che con-
chiude dicendo che « tutte le invenzioni degli
uomini, tanto hanno del bello e buono, quanto più
ingegnosamente proporzionate sono »,2 egli sembra
ripetere le parole dell'Alberti e di altri plastici.
Ma è bello vedere com'egli venga via via modifi-
cando la sua definizione, finché aderisca, per così
dire, alla sua arte. «Proporzione non è altro ch'una
consonanza e rispondenza delle misure delle parti
fra se stesse, e con il tutto in ogni opera che si fa ».3
Dove la parola consonanza, tratta metaforicamente
dal suono, che è cosi vicino al colore, fa già so-
spettare che, se anche rimane la stessa espressione,
il concetto che dettava dentro s'era cambiato.
Ma ci guarderemmo bene dall'appoggiarci a simile
sottile sospetto, se non vi fosse prova più sicura.
Negli ultimi anni della sua vita, quasi cieco, non
potendo più dipingere, scrisse Videa del Tempio
della pittura. Il suo ideale, la sua arte trova allora
parole perfettamente proprie, e meraviglia come
Irene Behn non ne abbia colta la grande diffe-
renza. Per Leon Battista « nasce dalla composizione
delle superfici quella grazia nei corpi quali dicono
bellezza ». Bellezza è quindi per l'Alberti la forma,
l'accordato ondulamento dei piani. Dice invece
il Lomazzo: « Finalmente la bellezza del corpo non
è altro che un certo atto, vivacità e grafia ». E
ancora: « la bellezza non è altro che una certa gra-
fia vivace e spirituale ».+ Quando si sappia che i pit-
tori il moto « lo sogliono dimandare ora furia, ora
gratta, e ora eccellenza nell'arte »3 e che alle figure
« non si può darli moto senza il colore »,6 si vede
chiaramente come tutt'altra bellezza, tutt'altra
arte fosse presente alla mente del Lomazzo, disce-
polo di Gaudenzio Ferrari. L'ideale plastico fio-
rentino è ormai perduto. Non più solidità di forma,
ma vibrazione eterea di colore e di luce, non più
1 Flemming, Die Begrilndung der Mod. Asthetik
und Kunslwissenschajt durch L. B. Alberti, 1916, p. 20.
2 Lomazzo, Trattato della Pittura, Milano, 1584, p. 33.
3 Lomazzo, Trattato della Pittura, p. 35.
A Lomazzo, Idea del tempio della Pittura, Milano, 1590,
capitolo 26.
' Trattato della Pittura, Libro II, cap. 2.
6 Idea, etc, cap. 1.
nitidezza plastica, ma movimento irraggiato che
confonde figure ed ambiente in un'unica indistinta
armonia. La dolce attività del colore, la nota che
s'avvicina e s'innalza acuta o cade vinta dall'ul-
tima dolcezza, l'accendersi della luce e lo svanire
dei colori, lo spegnersi e il rivivere di questi, tale
la visione artistica che fuggiva a' suoi poveri occhi.
Vale poi bene la pena di notare, benché non fac-
cia al nostro proposito, l'alta intuizione che egli
per il primo ebbe, se vide come in pittura, indipen-
dentemente dai gesti e dagli atteggiamenti, si
doveva chiedere il movimento ad un elemento ar-
tistico puro: il colore.
* * *
Alcuni di questi autori furono tanto artisti
nell'animo che trasformarono problemi storici o
scientifici nelle sempre vere visioni della fantasia.
Raccontavano gli antichi dell'origine dell'arte.
Polemonc di Sicione, partendo per la guerra, andò
a trovare la fidanzata. Si fece notte; e nell'accom-
pagnare il giovane all'ultima soglia s'accorse
la fanciulla come la lampada che ella reggeva in
mano disegnava sul muro allato il viso diPolemone.
Ella volle fermare il profilo di chi amava; e così
nacque l'arte. La leggenda non era certo priva di
significato. Dante assicura che il primo « che co-
minciò a dire siccome poeta volgare, si mosse però
che volca far intendere le sue parole a donna alla
quale era malagevole a intendere i versi latini ».'
L'amore fu certo non di rado impulso a grandi cose.
Ma era pur sempre uno stimolo esterno, estraneo
all'arte. E si noti come, cosi nascendo, l'arte por-
tava con sè il peccato d'origine: essa era imita-
zione. Dice infatti Pomponio Gaurico: « Nam sive
casu aliquo, sive solertia coeperint homines creta
aut lapidibus ex umbra similitudines imitando,
naturam ipsam aemulari, disquisitione haud opus
est, dum natura artiiìciociue profecta ac perfecta
omnia intelligantur ».2
Si senta invece l'Alberti: « Artes ( orum qui ex
corporibus a natura procreatis effigies et simulacra
suum in opus promere aggrediuntur ortas hinc
fuisse arbitror. Nan ex trunco glebave et huius-
mondi mutis corporibus fortassis aliquando in-
tuebantur lineamenta nonnulla, quibus paululum
immutatis persimile quidpiam verisnat'jrae vul-
tibus redderetur »3 Ricercare l'origine dell'arte è
assurdo. Ebbene, si veda come l'Alberti, intendendo
il problema come artista, non cadde nel vano:
egli venne ad esporre il processo di creazione del-
1 Dante, Vita Nova, cap. 25.
2 P. Gaurico, De sculptura liber, cap. 1, in Thesau-
rus Graecarum antiquitatum, Venezia, 1737, voi. IX.
3 L. B. Alberti, De statu in Leon Battista Alberti's
Kleinere Kunsttheoretische Schriflen, Wien, 1877, p. 169.
GIACOMO VESCO
senza della bellezza d.1 Se costoro fossero riusciti
a scorgere quanta differenza correva tra la defini-
zione dell'Alberti e quella, ad esempio, del Lo-
mazzo, sarebbero forse stati condotti a compren-
dere come in tali definizioni, credute generiche ed
astratte, v'era invece determinata e viva l'arte dei
diversi artisti.
Il Lomazzo era giovane quando scrisse il suo
Trattato della Pittura; e può ad alcuno, e con ra-
gione, sembrare che egli segua l'Alberti. Cosi, nella
definizione che egli dà della proporzione e che con-
chiude dicendo che « tutte le invenzioni degli
uomini, tanto hanno del bello e buono, quanto più
ingegnosamente proporzionate sono »,2 egli sembra
ripetere le parole dell'Alberti e di altri plastici.
Ma è bello vedere com'egli venga via via modifi-
cando la sua definizione, finché aderisca, per così
dire, alla sua arte. «Proporzione non è altro ch'una
consonanza e rispondenza delle misure delle parti
fra se stesse, e con il tutto in ogni opera che si fa ».3
Dove la parola consonanza, tratta metaforicamente
dal suono, che è cosi vicino al colore, fa già so-
spettare che, se anche rimane la stessa espressione,
il concetto che dettava dentro s'era cambiato.
Ma ci guarderemmo bene dall'appoggiarci a simile
sottile sospetto, se non vi fosse prova più sicura.
Negli ultimi anni della sua vita, quasi cieco, non
potendo più dipingere, scrisse Videa del Tempio
della pittura. Il suo ideale, la sua arte trova allora
parole perfettamente proprie, e meraviglia come
Irene Behn non ne abbia colta la grande diffe-
renza. Per Leon Battista « nasce dalla composizione
delle superfici quella grazia nei corpi quali dicono
bellezza ». Bellezza è quindi per l'Alberti la forma,
l'accordato ondulamento dei piani. Dice invece
il Lomazzo: « Finalmente la bellezza del corpo non
è altro che un certo atto, vivacità e grafia ». E
ancora: « la bellezza non è altro che una certa gra-
fia vivace e spirituale ».+ Quando si sappia che i pit-
tori il moto « lo sogliono dimandare ora furia, ora
gratta, e ora eccellenza nell'arte »3 e che alle figure
« non si può darli moto senza il colore »,6 si vede
chiaramente come tutt'altra bellezza, tutt'altra
arte fosse presente alla mente del Lomazzo, disce-
polo di Gaudenzio Ferrari. L'ideale plastico fio-
rentino è ormai perduto. Non più solidità di forma,
ma vibrazione eterea di colore e di luce, non più
1 Flemming, Die Begrilndung der Mod. Asthetik
und Kunslwissenschajt durch L. B. Alberti, 1916, p. 20.
2 Lomazzo, Trattato della Pittura, Milano, 1584, p. 33.
3 Lomazzo, Trattato della Pittura, p. 35.
A Lomazzo, Idea del tempio della Pittura, Milano, 1590,
capitolo 26.
' Trattato della Pittura, Libro II, cap. 2.
6 Idea, etc, cap. 1.
nitidezza plastica, ma movimento irraggiato che
confonde figure ed ambiente in un'unica indistinta
armonia. La dolce attività del colore, la nota che
s'avvicina e s'innalza acuta o cade vinta dall'ul-
tima dolcezza, l'accendersi della luce e lo svanire
dei colori, lo spegnersi e il rivivere di questi, tale
la visione artistica che fuggiva a' suoi poveri occhi.
Vale poi bene la pena di notare, benché non fac-
cia al nostro proposito, l'alta intuizione che egli
per il primo ebbe, se vide come in pittura, indipen-
dentemente dai gesti e dagli atteggiamenti, si
doveva chiedere il movimento ad un elemento ar-
tistico puro: il colore.
* * *
Alcuni di questi autori furono tanto artisti
nell'animo che trasformarono problemi storici o
scientifici nelle sempre vere visioni della fantasia.
Raccontavano gli antichi dell'origine dell'arte.
Polemonc di Sicione, partendo per la guerra, andò
a trovare la fidanzata. Si fece notte; e nell'accom-
pagnare il giovane all'ultima soglia s'accorse
la fanciulla come la lampada che ella reggeva in
mano disegnava sul muro allato il viso diPolemone.
Ella volle fermare il profilo di chi amava; e così
nacque l'arte. La leggenda non era certo priva di
significato. Dante assicura che il primo « che co-
minciò a dire siccome poeta volgare, si mosse però
che volca far intendere le sue parole a donna alla
quale era malagevole a intendere i versi latini ».'
L'amore fu certo non di rado impulso a grandi cose.
Ma era pur sempre uno stimolo esterno, estraneo
all'arte. E si noti come, cosi nascendo, l'arte por-
tava con sè il peccato d'origine: essa era imita-
zione. Dice infatti Pomponio Gaurico: « Nam sive
casu aliquo, sive solertia coeperint homines creta
aut lapidibus ex umbra similitudines imitando,
naturam ipsam aemulari, disquisitione haud opus
est, dum natura artiiìciociue profecta ac perfecta
omnia intelligantur ».2
Si senta invece l'Alberti: « Artes ( orum qui ex
corporibus a natura procreatis effigies et simulacra
suum in opus promere aggrediuntur ortas hinc
fuisse arbitror. Nan ex trunco glebave et huius-
mondi mutis corporibus fortassis aliquando in-
tuebantur lineamenta nonnulla, quibus paululum
immutatis persimile quidpiam verisnat'jrae vul-
tibus redderetur »3 Ricercare l'origine dell'arte è
assurdo. Ebbene, si veda come l'Alberti, intendendo
il problema come artista, non cadde nel vano:
egli venne ad esporre il processo di creazione del-
1 Dante, Vita Nova, cap. 25.
2 P. Gaurico, De sculptura liber, cap. 1, in Thesau-
rus Graecarum antiquitatum, Venezia, 1737, voi. IX.
3 L. B. Alberti, De statu in Leon Battista Alberti's
Kleinere Kunsttheoretische Schriflen, Wien, 1877, p. 169.