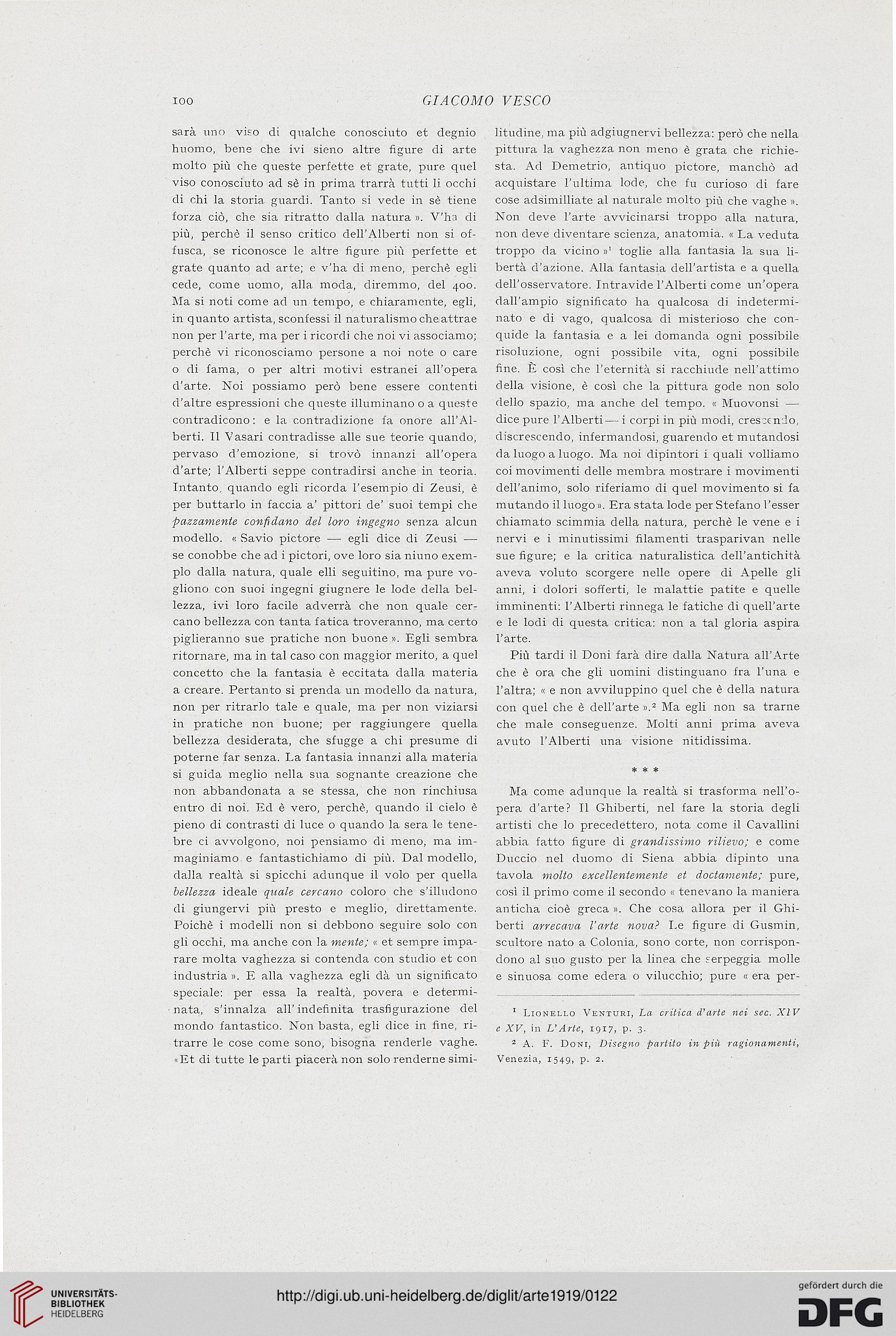100
GIACOMO VE SCO
sarà uno viso di qualche conosciuto et degnio
huomo, bene che ivi sieno altre figure di arte
molto phì che queste perfette et grate, pure quel
viso conosciuto ad sè in prima trarrà tutti li occhi
di chi la storia guardi. Tanto si vede in sè tiene
forza ciò, che sia ritratto dalla natura ». V'ha di
più, perchè il senso critico dell'Alberti non si of-
fusca, se riconosce le altre figure più perfette et
grate quanto ad arte; e v'ha di meno, perchè egli
cede, come uomo, alla moda, diremmo, del 400.
Ma si noti come ad un tempo, e chiaramente, egli,
in quanto artista, sconfessi il naturalismo che attrae
non per l'arte, ma per i ricordi che noi vi associamo;
perchè vi riconosciamo persone a noi note o care
o di fama, o per altri motivi estranei all'opera
d'arte. Noi possiamo però bene essere contenti
d'altre espressioni che queste illuminano o a queste
contradicono : e la contradizione fa onore all'Al-
berti. Il Vasari contradisse alle sue teorie quando,
pervaso d'emozione, si trovò innanzi all'opera
d'arte; l'Alberti seppe contradirsi anche in teoria.
Intanto, quando egli ricorda l'esempio di Zeusi, è
per buttarlo in faccia a' pittori de' suoi tempi che
pazzamente confidano del loro ingegno senza alcun
modello. « Savio pictore — egli dice di Zeusi —
se conobbe che ad i pictori, ove loro sia niuno exem-
plo dalla natura, quale elli seguitino, ma pure vo-
gliono con suoi ingegni giugnere le lode della bel-
lezza, ivi loro facile adverrà che non quale cer-
cano bellezza con tanta fatica troveranno, ma certo
piglieranno sue pratiche non buone ». Egli sembra
ritornare, ma in tal caso con maggior merito, a quel
concetto che la fantasia è eccitata dalla materia
a creare. Pertanto si prenda un modello da natura,
non per ritrarlo tale e quale, ma per non viziarsi
in pratiche non buone; per raggiungere quella
bellezza desiderata, che sfugge a chi presume di
poterne far senza. La fantasia innanzi alla materia
si guida meglio nella sua sognante creazione che
non abbandonata a se stessa, che non rinchiusa
entro di noi. Ed è vero, perchè, quando il cielo è
pieno di contrasti di luce o quando la sera le tene-
bre ci avvolgono, noi pensiamo di meno, ma im-
maginiamo e fantastichiamo di più. Dal modello,
dalla realtà si spicchi adunque il volo per quella
bellezza ideale quale cercano coloro che s'illudono
di giungervi più presto e meglio, direttamente.
Poiché i modelli non si debbono seguire solo con
gli occhi, ma anche con la mente; « et sempre impa-
rare molta vaghezza si contenda con studio et con
industria ». E alla vaghezza egli dà un significato
speciale: per essa la realtà, povera e determi-
nata, s'innalza all'indefinita trasfigurazione del
mondo fantastico. Non basta, egli dice in fine, ri-
trarre le cose come sono, bisogna renderle vaghe.
«Et di tutte le parti piacerà non solo renderne simi-
litudine: ma più adgiugnervi bellezza: però che nella
pittura la vaghezza non meno è grata che richie-
sta. Ad Demetrio, antiquo pictore, manchò ad
acquistare l'ultima lode, che fu curioso di fare
cose adsimilliate al naturale molto più che vaghe ».
Non deve l'arte avvicinarsi troppo alla natura,
non deve diventare scienza, anatomia. « La veduta
troppo da vicino »' toglie alla fantasia la sua li-
bertà d'azione. Alla fantasia dell'artista e a quella
dell'osservatore. Intravide l'Alberti come un'opera
dall'ampio significato ha qualcosa di indetermi-
nato e di vago, qualcosa di misterioso che con-
quide la fantasia e a lei domanda ogni possibile
risoluzione, ogni possibile vita, ogni possibile
fine. È così che l'eternità si racchiude nell'attimo
della visione, è così che la pittura gode non solo
dello spazio, ma anche del tempo. « Muovonsi —
dice pure l'Alberti— i corpi in più modi, crescendo,
discrescendo, infermandosi, guarendo et mutandosi
da luogo a luogo. Ma noi dipintori i quali volliamo
coi movimenti delle membra mostrare i movimenti
dell'animo, solo riferiamo di quel movimento si fa
mutando il luogo ». Era stata lode per Stefano l'esser
chiamato scimmia della natura, perchè le vene e i
nervi e i minutissimi filamenti trasparivan nelle
sue figure; e la critica naturalistica dell'antichità
aveva voluto scorgere nelle opere di Apelle gli
anni, i dolori sofferti, le malattie patite e quelle
imminenti: l'Alberti rinnega le fatiche di quell'arte
e le lodi di questa critica: non a tal gloria aspira
l'arte.
Più tardi il Doni farà dire dalla Natura all'Arte
che è ora che gli uomini distinguano fra l'una e
l'altra; « e non avviluppino quel che è della natura
con quel che è dell'arte ».2 Ma egli non sa trarne
che male conseguenze. Molti anni prima aveva
avuto l'Alberti una visione nitidissima.
* * *
Ma come adunque la realtà si trasforma nell'o-
pera d'arte? Il Ghiberti, nel fare la storia degli
artisti che lo precedettero, nota come il Cavallini
abbia fatto figure di grandissimo rilievo; e come
Duccio nel duomo di Siena abbia dipinto una
tavola molto excellentemenie et doctamente; pure,
così il primo come il secondo « tenevano la maniera
anticha cioè greca ». Che cosa allora per il Ghi-
berti arrecava l'arte nova? Le figure di Gusmin,
scultore nato a Colonia, sono corte, non corrispon-
dono al suo gusto per la linea che serpeggia molle
e sinuosa come edera o vilucchio; pure « era per-
1 Lionello Venturi, La critica d'arte nei sec. XIV
e XV, in L'Arte, 1917, p. 3.
2 A. F. Doni, Disegno partito in più ragionamenti,
Venezia, 1549, p. 2.
GIACOMO VE SCO
sarà uno viso di qualche conosciuto et degnio
huomo, bene che ivi sieno altre figure di arte
molto phì che queste perfette et grate, pure quel
viso conosciuto ad sè in prima trarrà tutti li occhi
di chi la storia guardi. Tanto si vede in sè tiene
forza ciò, che sia ritratto dalla natura ». V'ha di
più, perchè il senso critico dell'Alberti non si of-
fusca, se riconosce le altre figure più perfette et
grate quanto ad arte; e v'ha di meno, perchè egli
cede, come uomo, alla moda, diremmo, del 400.
Ma si noti come ad un tempo, e chiaramente, egli,
in quanto artista, sconfessi il naturalismo che attrae
non per l'arte, ma per i ricordi che noi vi associamo;
perchè vi riconosciamo persone a noi note o care
o di fama, o per altri motivi estranei all'opera
d'arte. Noi possiamo però bene essere contenti
d'altre espressioni che queste illuminano o a queste
contradicono : e la contradizione fa onore all'Al-
berti. Il Vasari contradisse alle sue teorie quando,
pervaso d'emozione, si trovò innanzi all'opera
d'arte; l'Alberti seppe contradirsi anche in teoria.
Intanto, quando egli ricorda l'esempio di Zeusi, è
per buttarlo in faccia a' pittori de' suoi tempi che
pazzamente confidano del loro ingegno senza alcun
modello. « Savio pictore — egli dice di Zeusi —
se conobbe che ad i pictori, ove loro sia niuno exem-
plo dalla natura, quale elli seguitino, ma pure vo-
gliono con suoi ingegni giugnere le lode della bel-
lezza, ivi loro facile adverrà che non quale cer-
cano bellezza con tanta fatica troveranno, ma certo
piglieranno sue pratiche non buone ». Egli sembra
ritornare, ma in tal caso con maggior merito, a quel
concetto che la fantasia è eccitata dalla materia
a creare. Pertanto si prenda un modello da natura,
non per ritrarlo tale e quale, ma per non viziarsi
in pratiche non buone; per raggiungere quella
bellezza desiderata, che sfugge a chi presume di
poterne far senza. La fantasia innanzi alla materia
si guida meglio nella sua sognante creazione che
non abbandonata a se stessa, che non rinchiusa
entro di noi. Ed è vero, perchè, quando il cielo è
pieno di contrasti di luce o quando la sera le tene-
bre ci avvolgono, noi pensiamo di meno, ma im-
maginiamo e fantastichiamo di più. Dal modello,
dalla realtà si spicchi adunque il volo per quella
bellezza ideale quale cercano coloro che s'illudono
di giungervi più presto e meglio, direttamente.
Poiché i modelli non si debbono seguire solo con
gli occhi, ma anche con la mente; « et sempre impa-
rare molta vaghezza si contenda con studio et con
industria ». E alla vaghezza egli dà un significato
speciale: per essa la realtà, povera e determi-
nata, s'innalza all'indefinita trasfigurazione del
mondo fantastico. Non basta, egli dice in fine, ri-
trarre le cose come sono, bisogna renderle vaghe.
«Et di tutte le parti piacerà non solo renderne simi-
litudine: ma più adgiugnervi bellezza: però che nella
pittura la vaghezza non meno è grata che richie-
sta. Ad Demetrio, antiquo pictore, manchò ad
acquistare l'ultima lode, che fu curioso di fare
cose adsimilliate al naturale molto più che vaghe ».
Non deve l'arte avvicinarsi troppo alla natura,
non deve diventare scienza, anatomia. « La veduta
troppo da vicino »' toglie alla fantasia la sua li-
bertà d'azione. Alla fantasia dell'artista e a quella
dell'osservatore. Intravide l'Alberti come un'opera
dall'ampio significato ha qualcosa di indetermi-
nato e di vago, qualcosa di misterioso che con-
quide la fantasia e a lei domanda ogni possibile
risoluzione, ogni possibile vita, ogni possibile
fine. È così che l'eternità si racchiude nell'attimo
della visione, è così che la pittura gode non solo
dello spazio, ma anche del tempo. « Muovonsi —
dice pure l'Alberti— i corpi in più modi, crescendo,
discrescendo, infermandosi, guarendo et mutandosi
da luogo a luogo. Ma noi dipintori i quali volliamo
coi movimenti delle membra mostrare i movimenti
dell'animo, solo riferiamo di quel movimento si fa
mutando il luogo ». Era stata lode per Stefano l'esser
chiamato scimmia della natura, perchè le vene e i
nervi e i minutissimi filamenti trasparivan nelle
sue figure; e la critica naturalistica dell'antichità
aveva voluto scorgere nelle opere di Apelle gli
anni, i dolori sofferti, le malattie patite e quelle
imminenti: l'Alberti rinnega le fatiche di quell'arte
e le lodi di questa critica: non a tal gloria aspira
l'arte.
Più tardi il Doni farà dire dalla Natura all'Arte
che è ora che gli uomini distinguano fra l'una e
l'altra; « e non avviluppino quel che è della natura
con quel che è dell'arte ».2 Ma egli non sa trarne
che male conseguenze. Molti anni prima aveva
avuto l'Alberti una visione nitidissima.
* * *
Ma come adunque la realtà si trasforma nell'o-
pera d'arte? Il Ghiberti, nel fare la storia degli
artisti che lo precedettero, nota come il Cavallini
abbia fatto figure di grandissimo rilievo; e come
Duccio nel duomo di Siena abbia dipinto una
tavola molto excellentemenie et doctamente; pure,
così il primo come il secondo « tenevano la maniera
anticha cioè greca ». Che cosa allora per il Ghi-
berti arrecava l'arte nova? Le figure di Gusmin,
scultore nato a Colonia, sono corte, non corrispon-
dono al suo gusto per la linea che serpeggia molle
e sinuosa come edera o vilucchio; pure « era per-
1 Lionello Venturi, La critica d'arte nei sec. XIV
e XV, in L'Arte, 1917, p. 3.
2 A. F. Doni, Disegno partito in più ragionamenti,
Venezia, 1549, p. 2.