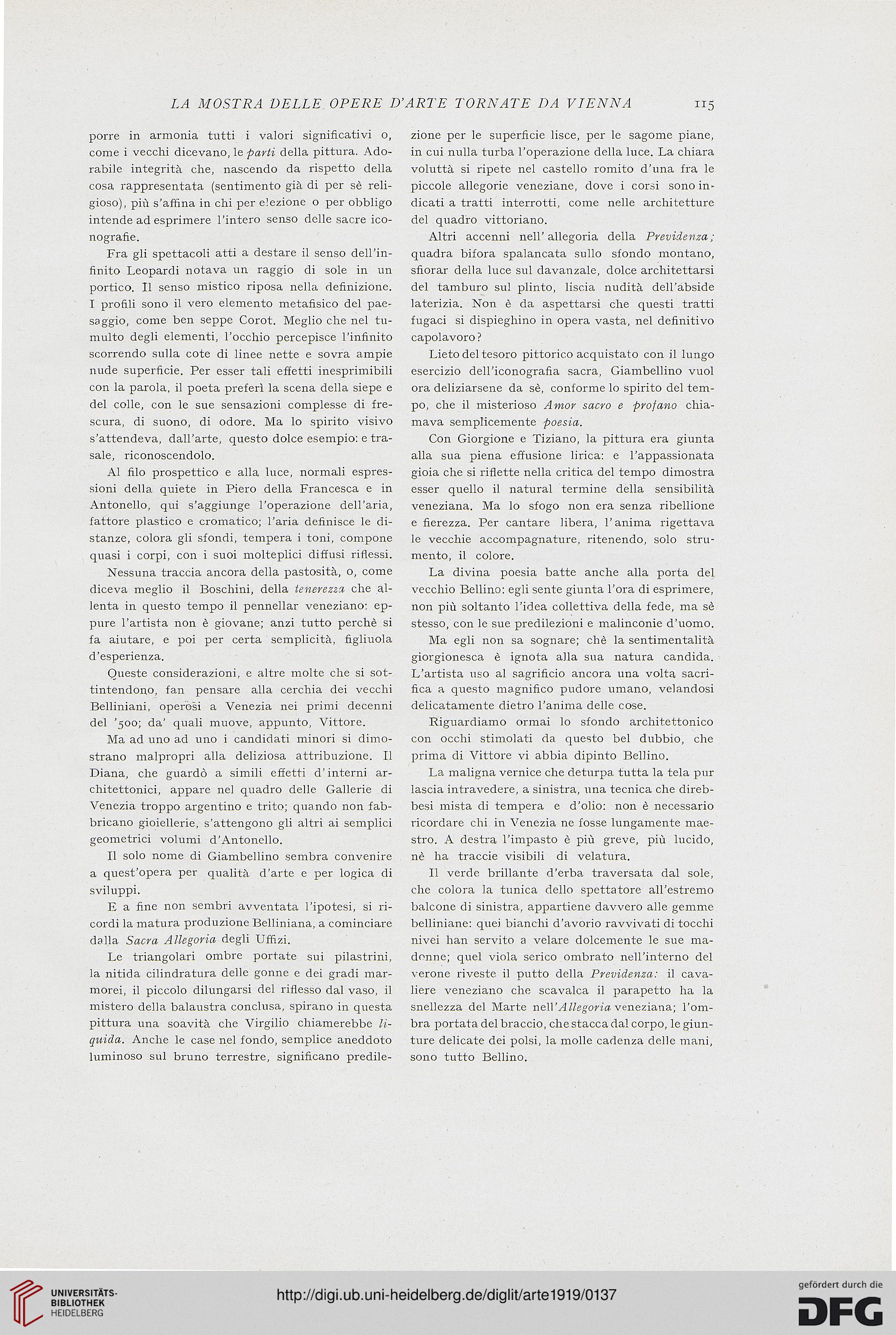LA MOSTRA DELLE OPERE D'ARTE TORNATE DA VIENNA
"5
porre in armonia tutti i valori significativi o,
come i vecchi dicevano, le parti della pittura. Ado-
rabile integrità che, nascendo da rispetto della
cosa rappresentata (sentimento già di per sè reli-
gioso), più s'affina in chi per c'czione o per obbligo
intende ad esprimere l'intero senso delle sacre ico-
nografìe.
Fra gli spettacoli atti a destare il senso dell'in-
finito Leopardi notava un raggio di sole in un
portico. Il senso mistico riposa nella definizione.
I profili sono il vero elemento metafisico del pae-
saggio, come ben seppe Corot. Meglio che nel tu-
multo degli elementi, l'occhio percepisce l'infinito
scorrendo sulla cote di linee nette e sovra ampie
nude superficie. Per esser tali effetti inesprimibili
con la parola, il poeta preferì la scena della siepe e
del colle, con le sue sensazioni complesse di fre-
scura, di suono, di odore. Ma lo spirito visivo
s'attendeva, dall'arte, questo dolce esempio: e tra-
sale, riconoscendolo.
Al filo prospettico c alla luce, normali espres-
sioni della quiete in Piero della Francesca e in
Antonello, qui s'aggiunge l'operazione dell'aria,
fattore plastico c cromatico; l'aria definisce le di-
stanze, colora gli sfondi, tempera i toni, compone
quasi i corpi, con i suoi molteplici diffusi riflessi.
Nessuna traccia ancora della pastosità, o, come
diceva meglio il Boschini, della tenerezza che al-
lenta in questo tempo il pennellar veneziano: ep-
pure l'artista non è giovane; anzi tutto perchè si
fa aiutare, e poi per certa semplicità, figliuola
d'esperienza.
Queste considerazioni, e altre molte che si sot-
tintendono, fan pensare alla cerchia dei vecchi
Belliniani, operosi a Venezia nei primi decenni
del '500; da' quali muove, appunto, Vittore.
Ma ad uno ad uno i candidati minori si dimo-
strano malpropri alla deliziosa attribuzione. Il
Diana, che guardò a simili effetti d'interni ar-
chitettonici, appare nel quadro delle Gallerie di
Venezia troppo argentino e trito; quando non fab-
bricano gioiellerie, s'attengono gli altri ai semplici
geometrici volumi d'Antonello.
Il solo nome di Giambellino sembra convenire
a quest'opera per qualità d'arte e per logica di
sviluppi.
E a fine non sembri avventata l'ipotesi, si ri-
cordi la matura produzione Belliniana, a cominciare
dalla Sacra Allegoria degli Uffizi.
Le triangolari ombre portate sui pilastrini,
la nitida cilindratura delle gonne e dei gradi mar-
morei, il piccolo dilungarsi del riflesso dal vaso, il
mistero della balaustra conclusa, spirano in questa
pittura una soavità che Virgilio chiamerebbe li-
quida. Anche le case nel fondo, semplice aneddoto
luminoso sul bruno terrestre, significano predile-
zione per le superfìcie lisce, per le sagome piane,
in cui nulla turba l'operazione della luce. La chiara
voluttà si ripete nel castello romito d'una fra le
piccole allegorie veneziane, dove i corsi sono in-
dicati a tratti interrotti, come nelle architetture
del quadro vittoriano.
Altri accenni neh' allegoria della Previdenza ;
quadra bifora spalancata sullo sfondo montano,
sfiorar della luce sul davanzale, dolce architettarsi
del tamburo su! plinto, liscia nudità dell'abside
laterizia. Non è da aspettarsi che questi tratti
fugaci si dispieghino in opera vasta, nel definitivo
capolavoro?
Lieto del tesoro pittorico acquistato con il lungo
esercizio dell'iconografìa sacra, Giambellino vuol
ora deliziarsene da sè, conforme lo spirito del tem-
po, che il misterioso Amor sacro e profano chia-
mava semplicemente poesia.
Con Giorgione e Tiziano, la pittura era giunta
alla sua piena effusione lirica: e l'appassionata
gioia che si riflette nella critica del tempo dimostra
esser quello il naturai termine della sensibilità
veneziana. Ma lo sfogo non era senza ribellione
e fierezza. Per cantare libera, l'anima rigettava
le vecchie accompagnature, ritenendo, solo stru-
mento, il colore.
La divina poesia batte anche alla porta del
vecchio Bellino: egli sente giunta l'ora di esprimere,
non più soltanto l'idea collettiva della fede, ma sè
stesso, con le sue predilezioni e malinconie d'uomo.
Ma egli non sa sognare; chè la sentimentalità
giorgionesca è ignota alla sua natura candida.
L'artista uso al sagrificio ancora una volta sacri-
fica a questo magnifico pudore umano, velandosi
delicatamente dietro l'anima delle cose.
Riguardiamo ormai lo sfondo architettonico
con occhi stimolati da questo bel dubbio, che
prima di Vittore vi abbia dipinto Bellino.
La maligna vernice che deturpa tutta la tela pur
lascia intravedere, a sinistra, una tecnica che direb-
besi mista di tempera e d'olio: non è necessario
ricordare chi in Venezia ne fosse lungamente mae-
stro. A destra l'impasto è più greve, più lucido,
nè ha traccie visibili di velatura.
II verde brillante d'erba traversata dal sole,
che colora la tunica dello spettatore all'estremo
balcone di sinistra, appartiene davvero alle gemme
belliniane: quei bianchi d'avorio ravvivati di tocchi
nivei han servito a velare dolcemente le sue ma-
donne; quel viola serico ombrato nell'interno del
verone riveste il putto della Previdenza: il cava-
liere veneziano che scavalca il parapetto ha la
snellezza del Marte nell 'A Uegoria veneziana; l'om-
bra portata del braccio, che stacca dal corpo, le giun-
ture delicate dei polsi, la molle cadenza delle mani,
sono tutto Bellino.
"5
porre in armonia tutti i valori significativi o,
come i vecchi dicevano, le parti della pittura. Ado-
rabile integrità che, nascendo da rispetto della
cosa rappresentata (sentimento già di per sè reli-
gioso), più s'affina in chi per c'czione o per obbligo
intende ad esprimere l'intero senso delle sacre ico-
nografìe.
Fra gli spettacoli atti a destare il senso dell'in-
finito Leopardi notava un raggio di sole in un
portico. Il senso mistico riposa nella definizione.
I profili sono il vero elemento metafisico del pae-
saggio, come ben seppe Corot. Meglio che nel tu-
multo degli elementi, l'occhio percepisce l'infinito
scorrendo sulla cote di linee nette e sovra ampie
nude superficie. Per esser tali effetti inesprimibili
con la parola, il poeta preferì la scena della siepe e
del colle, con le sue sensazioni complesse di fre-
scura, di suono, di odore. Ma lo spirito visivo
s'attendeva, dall'arte, questo dolce esempio: e tra-
sale, riconoscendolo.
Al filo prospettico c alla luce, normali espres-
sioni della quiete in Piero della Francesca e in
Antonello, qui s'aggiunge l'operazione dell'aria,
fattore plastico c cromatico; l'aria definisce le di-
stanze, colora gli sfondi, tempera i toni, compone
quasi i corpi, con i suoi molteplici diffusi riflessi.
Nessuna traccia ancora della pastosità, o, come
diceva meglio il Boschini, della tenerezza che al-
lenta in questo tempo il pennellar veneziano: ep-
pure l'artista non è giovane; anzi tutto perchè si
fa aiutare, e poi per certa semplicità, figliuola
d'esperienza.
Queste considerazioni, e altre molte che si sot-
tintendono, fan pensare alla cerchia dei vecchi
Belliniani, operosi a Venezia nei primi decenni
del '500; da' quali muove, appunto, Vittore.
Ma ad uno ad uno i candidati minori si dimo-
strano malpropri alla deliziosa attribuzione. Il
Diana, che guardò a simili effetti d'interni ar-
chitettonici, appare nel quadro delle Gallerie di
Venezia troppo argentino e trito; quando non fab-
bricano gioiellerie, s'attengono gli altri ai semplici
geometrici volumi d'Antonello.
Il solo nome di Giambellino sembra convenire
a quest'opera per qualità d'arte e per logica di
sviluppi.
E a fine non sembri avventata l'ipotesi, si ri-
cordi la matura produzione Belliniana, a cominciare
dalla Sacra Allegoria degli Uffizi.
Le triangolari ombre portate sui pilastrini,
la nitida cilindratura delle gonne e dei gradi mar-
morei, il piccolo dilungarsi del riflesso dal vaso, il
mistero della balaustra conclusa, spirano in questa
pittura una soavità che Virgilio chiamerebbe li-
quida. Anche le case nel fondo, semplice aneddoto
luminoso sul bruno terrestre, significano predile-
zione per le superfìcie lisce, per le sagome piane,
in cui nulla turba l'operazione della luce. La chiara
voluttà si ripete nel castello romito d'una fra le
piccole allegorie veneziane, dove i corsi sono in-
dicati a tratti interrotti, come nelle architetture
del quadro vittoriano.
Altri accenni neh' allegoria della Previdenza ;
quadra bifora spalancata sullo sfondo montano,
sfiorar della luce sul davanzale, dolce architettarsi
del tamburo su! plinto, liscia nudità dell'abside
laterizia. Non è da aspettarsi che questi tratti
fugaci si dispieghino in opera vasta, nel definitivo
capolavoro?
Lieto del tesoro pittorico acquistato con il lungo
esercizio dell'iconografìa sacra, Giambellino vuol
ora deliziarsene da sè, conforme lo spirito del tem-
po, che il misterioso Amor sacro e profano chia-
mava semplicemente poesia.
Con Giorgione e Tiziano, la pittura era giunta
alla sua piena effusione lirica: e l'appassionata
gioia che si riflette nella critica del tempo dimostra
esser quello il naturai termine della sensibilità
veneziana. Ma lo sfogo non era senza ribellione
e fierezza. Per cantare libera, l'anima rigettava
le vecchie accompagnature, ritenendo, solo stru-
mento, il colore.
La divina poesia batte anche alla porta del
vecchio Bellino: egli sente giunta l'ora di esprimere,
non più soltanto l'idea collettiva della fede, ma sè
stesso, con le sue predilezioni e malinconie d'uomo.
Ma egli non sa sognare; chè la sentimentalità
giorgionesca è ignota alla sua natura candida.
L'artista uso al sagrificio ancora una volta sacri-
fica a questo magnifico pudore umano, velandosi
delicatamente dietro l'anima delle cose.
Riguardiamo ormai lo sfondo architettonico
con occhi stimolati da questo bel dubbio, che
prima di Vittore vi abbia dipinto Bellino.
La maligna vernice che deturpa tutta la tela pur
lascia intravedere, a sinistra, una tecnica che direb-
besi mista di tempera e d'olio: non è necessario
ricordare chi in Venezia ne fosse lungamente mae-
stro. A destra l'impasto è più greve, più lucido,
nè ha traccie visibili di velatura.
II verde brillante d'erba traversata dal sole,
che colora la tunica dello spettatore all'estremo
balcone di sinistra, appartiene davvero alle gemme
belliniane: quei bianchi d'avorio ravvivati di tocchi
nivei han servito a velare dolcemente le sue ma-
donne; quel viola serico ombrato nell'interno del
verone riveste il putto della Previdenza: il cava-
liere veneziano che scavalca il parapetto ha la
snellezza del Marte nell 'A Uegoria veneziana; l'om-
bra portata del braccio, che stacca dal corpo, le giun-
ture delicate dei polsi, la molle cadenza delle mani,
sono tutto Bellino.