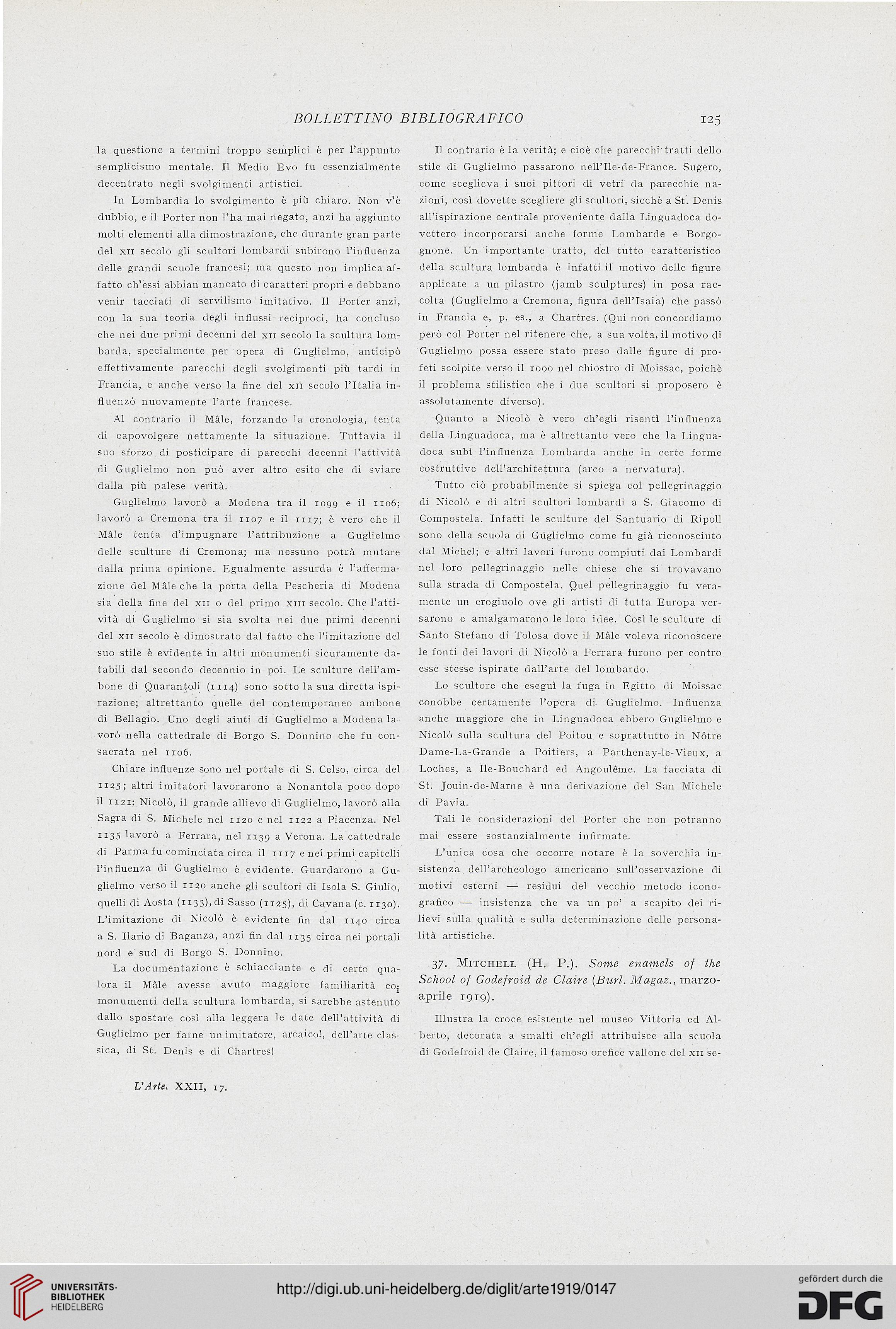BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
125
la questione a termini troppo semplici è per l'appunto
semplicismo mentale. Il Medio Evo fu essenzialmente
decentrato negli svolgimenti artistici.
In Lombardia lo svolgimento è più chiaro. Non v'è
dubbio, e il Porter non l'ha mai negato, anzi ha aggiunto
molti elementi alla dimostrazione, che durante gran parte
del xii secolo gli scultori lombardi subirono l'influenza
delle grandi scuole francesi; ma questo non implica af-
fatto ch'essi abbiari mancato di caratteri propri e debbano
venir tacciati di servilismo imitativo. Il Porter anzi,
con la sua teoria degli influssi reciproci, ha concluso
che nei due primi decenni del xii secolo la scultura lom-
barda, specialmente per opera di Guglielmo, anticipò
effettivamente parecchi degli svolgimenti più tardi in
Francia, e anche verso la fine del xii secolo l'Italia in-
fluenzò nuovamente l'arte francese.
Al contrario il Male, forzando la cronologia, tenta
di capovolgere nettamente la situazione. Tuttavia il
suo sforzo di posticipare di parecchi decenni l'attività
di Guglielmo non può aver altro esito che di sviare
dalla più palese verità.
Guglielmo lavorò a Modena tra il 1099 e il 1106;
lavorò a Cremona tra il 1107 e il 1117; è vero che il
Male tenta d'impugnare l'attribuzione a Guglielmo
delle sculture di Cremona; ma nessuno potrà mutare
dalla prima opinione. Egualmente assurda è l'afferma-
zione del Male che la porta della Pescheria di Modena
sia della fine del xii o del primo xm secolo. Che l'atti-
vità di Guglielmo si sia svolta nei due primi decenni
del xii secolo è dimostrato dal fatto che l'imitazione del
suo stile è evidente in altri monumenti sicuramente da-
tabili dal secondo decennio in poi. Le sculture dell'am-
bone di Quarantoli (1114) sono sotto la sua diretta ispi-
razione; altrettanto quelle del contemporaneo ambone
di Bellagio. Uno degli aiuti di Guglielmo a Modena la-
vorò nella cattedrale di Borgo S. Donnino che fu con-
sacrata nel 1106.
Chiare influenze sono nel portale di S. Celso, circa del
1125; altri imitatori lavorarono a Nonantola poco dopo
il iÌ2i; Nicolò, il grande allievo di Guglielmo, lavorò alla
Sagra di S. Michele nel 1120 e nel 1122 a Piacenza. Nel
1135 lavorò a Ferrara, nel 1139 a Verona. La cattedrale
di Parma fu cominciata circa il 1117 e nei primi capitelli
l'influenza di Guglielmo è evidente. Guardarono a Gu-
glielmo verso il 1120 anche gli scultori di Isola S. Giulio,
quelli di Aosta (ii33),di Sasso (1125), di Cavana (c. 1130).
L'imitazione di Nicolò è evidente fin dal 1140 circa
a S. Ilario di Baganza, anzi fin dal 1135 circa nei portali
nord e sud di Borgo S. Donnino.
La documentazione è schiacciante e di certo qua-
lora il Male avesse avuto maggiore familiarità co;
monumenti della scultura lombarda, si sarebbe astenuto
dallo spostare cosi alla leggera le date dell'attività di
Guglielmo per farne un imitatore, arcaico!, dell'arte clas-
sica, di St. Denis e di Chartres!
Il contrario è la verità; e cioè che parecchi tratti dello
stile di Guglielmo passarono nell'Ile-de-France. Sugero,
come sceglieva i suoi pittori di vetri da parecchie na-
zioni, cosi dovette scegliere gli scultori, sicché a St. Denis
all'ispirazione centrale proveniente dalla Linguadoca do-
vettero incorporarsi anche forme Lombarde e Borgo-
gnone. Un importante tratto, del tutto caratteristico
della scultura lombarda è infatti il motivo delle figure
applicate a un pilastro (jamb sculptures) in posa rac-
colta (Guglielmo a Cremona, figura dell'Isaia) che passò
in Francia e, p. es., a Chartres. (Qui non concordiamo
però col Porter nel ritenere che, a sua volta, il motivo di
Guglielmo possa essere stato preso dalle figure di pro-
feti scolpite verso il 1000 nel chiostro di Moissac, poiché
il problema stilistico che i due scultori si proposero è
assolutamente diverso).
Quanto a Nicolò è vero ch'egli risenti l'influenza
della Linguadoca, ma è altrettanto vero che la Lingua-
doca subì l'influenza Lombarda anche in certe forme
costruttive dell'architettura (arco a nervatura).
Tutto ciò probabilmente si spiega col pellegrinaggio
di Nicolò e di altri scultori lombardi a S. Giacomo di
Compostela. Infatti le sculture del Santuario di Ripoll
sono della scuola di Guglielmo come fu già riconosciuto
dal Michel; e altri lavori furono compiuti dai Lombardi
nel loro pellegrinaggio nelle chiese che si trovavano
sulla strada di Compostela. Quel pellegrinaggio fu vera-
mente un crogiuolo ove gli artisti di tutta Europa ver-
sarono e amalgamarono le loro idee. Cosi le sculture di
Santo Stefano di Tolosa dove il Male voleva riconoscere
le fonti dei lavori di Nicolò a Ferrara furono per contro
esse stesse ispirate dall'arte del lombardo.
Lo scultore che eseguì la fuga in Egitto di Moissac
conobbe certamente l'opera di. Guglielmo. Influenza
anche maggiore che in Linguadoca ebbero Guglielmo e
Nicolò sulla scultura del Poitou e soprattutto in Nótre
Dame-La-Grande a Poitiers, a Parthenay-le-Vieux, a
Loches, a Ile-Bouchard ed Angouléme. La facciata di
St. Jouin-de-Marne è una derivazione del San Michele
di Pavia.
Tali le considerazioni del Porter che non potranno
mai essere sostanzialmente infirmate.
L'unica cosa che occorre notare è la soverchia in-
sistenza dell'archeologo americano sull'osservazione di
motivi esterni — residui del vecchio metodo icono-
grafico — insistenza the va un po' a scapito dei ri-
lievi sulla qualità e sulla determinazione delle persona-
lità artistiche.
37. Mitcheli. (H. P.). Some enamels of the
School of Godefroid de Claire (Buri. Magaz., marzo-
aprile 1919).
Illustra la croce esìstente nel museo Vittoria ed Al-
berto, decorata a smalti ch'egli attribuisce alla scuola
di Godefroid de Claire, il famoso orefice vallone del xii se-
L'Arte. XXII, 17.
125
la questione a termini troppo semplici è per l'appunto
semplicismo mentale. Il Medio Evo fu essenzialmente
decentrato negli svolgimenti artistici.
In Lombardia lo svolgimento è più chiaro. Non v'è
dubbio, e il Porter non l'ha mai negato, anzi ha aggiunto
molti elementi alla dimostrazione, che durante gran parte
del xii secolo gli scultori lombardi subirono l'influenza
delle grandi scuole francesi; ma questo non implica af-
fatto ch'essi abbiari mancato di caratteri propri e debbano
venir tacciati di servilismo imitativo. Il Porter anzi,
con la sua teoria degli influssi reciproci, ha concluso
che nei due primi decenni del xii secolo la scultura lom-
barda, specialmente per opera di Guglielmo, anticipò
effettivamente parecchi degli svolgimenti più tardi in
Francia, e anche verso la fine del xii secolo l'Italia in-
fluenzò nuovamente l'arte francese.
Al contrario il Male, forzando la cronologia, tenta
di capovolgere nettamente la situazione. Tuttavia il
suo sforzo di posticipare di parecchi decenni l'attività
di Guglielmo non può aver altro esito che di sviare
dalla più palese verità.
Guglielmo lavorò a Modena tra il 1099 e il 1106;
lavorò a Cremona tra il 1107 e il 1117; è vero che il
Male tenta d'impugnare l'attribuzione a Guglielmo
delle sculture di Cremona; ma nessuno potrà mutare
dalla prima opinione. Egualmente assurda è l'afferma-
zione del Male che la porta della Pescheria di Modena
sia della fine del xii o del primo xm secolo. Che l'atti-
vità di Guglielmo si sia svolta nei due primi decenni
del xii secolo è dimostrato dal fatto che l'imitazione del
suo stile è evidente in altri monumenti sicuramente da-
tabili dal secondo decennio in poi. Le sculture dell'am-
bone di Quarantoli (1114) sono sotto la sua diretta ispi-
razione; altrettanto quelle del contemporaneo ambone
di Bellagio. Uno degli aiuti di Guglielmo a Modena la-
vorò nella cattedrale di Borgo S. Donnino che fu con-
sacrata nel 1106.
Chiare influenze sono nel portale di S. Celso, circa del
1125; altri imitatori lavorarono a Nonantola poco dopo
il iÌ2i; Nicolò, il grande allievo di Guglielmo, lavorò alla
Sagra di S. Michele nel 1120 e nel 1122 a Piacenza. Nel
1135 lavorò a Ferrara, nel 1139 a Verona. La cattedrale
di Parma fu cominciata circa il 1117 e nei primi capitelli
l'influenza di Guglielmo è evidente. Guardarono a Gu-
glielmo verso il 1120 anche gli scultori di Isola S. Giulio,
quelli di Aosta (ii33),di Sasso (1125), di Cavana (c. 1130).
L'imitazione di Nicolò è evidente fin dal 1140 circa
a S. Ilario di Baganza, anzi fin dal 1135 circa nei portali
nord e sud di Borgo S. Donnino.
La documentazione è schiacciante e di certo qua-
lora il Male avesse avuto maggiore familiarità co;
monumenti della scultura lombarda, si sarebbe astenuto
dallo spostare cosi alla leggera le date dell'attività di
Guglielmo per farne un imitatore, arcaico!, dell'arte clas-
sica, di St. Denis e di Chartres!
Il contrario è la verità; e cioè che parecchi tratti dello
stile di Guglielmo passarono nell'Ile-de-France. Sugero,
come sceglieva i suoi pittori di vetri da parecchie na-
zioni, cosi dovette scegliere gli scultori, sicché a St. Denis
all'ispirazione centrale proveniente dalla Linguadoca do-
vettero incorporarsi anche forme Lombarde e Borgo-
gnone. Un importante tratto, del tutto caratteristico
della scultura lombarda è infatti il motivo delle figure
applicate a un pilastro (jamb sculptures) in posa rac-
colta (Guglielmo a Cremona, figura dell'Isaia) che passò
in Francia e, p. es., a Chartres. (Qui non concordiamo
però col Porter nel ritenere che, a sua volta, il motivo di
Guglielmo possa essere stato preso dalle figure di pro-
feti scolpite verso il 1000 nel chiostro di Moissac, poiché
il problema stilistico che i due scultori si proposero è
assolutamente diverso).
Quanto a Nicolò è vero ch'egli risenti l'influenza
della Linguadoca, ma è altrettanto vero che la Lingua-
doca subì l'influenza Lombarda anche in certe forme
costruttive dell'architettura (arco a nervatura).
Tutto ciò probabilmente si spiega col pellegrinaggio
di Nicolò e di altri scultori lombardi a S. Giacomo di
Compostela. Infatti le sculture del Santuario di Ripoll
sono della scuola di Guglielmo come fu già riconosciuto
dal Michel; e altri lavori furono compiuti dai Lombardi
nel loro pellegrinaggio nelle chiese che si trovavano
sulla strada di Compostela. Quel pellegrinaggio fu vera-
mente un crogiuolo ove gli artisti di tutta Europa ver-
sarono e amalgamarono le loro idee. Cosi le sculture di
Santo Stefano di Tolosa dove il Male voleva riconoscere
le fonti dei lavori di Nicolò a Ferrara furono per contro
esse stesse ispirate dall'arte del lombardo.
Lo scultore che eseguì la fuga in Egitto di Moissac
conobbe certamente l'opera di. Guglielmo. Influenza
anche maggiore che in Linguadoca ebbero Guglielmo e
Nicolò sulla scultura del Poitou e soprattutto in Nótre
Dame-La-Grande a Poitiers, a Parthenay-le-Vieux, a
Loches, a Ile-Bouchard ed Angouléme. La facciata di
St. Jouin-de-Marne è una derivazione del San Michele
di Pavia.
Tali le considerazioni del Porter che non potranno
mai essere sostanzialmente infirmate.
L'unica cosa che occorre notare è la soverchia in-
sistenza dell'archeologo americano sull'osservazione di
motivi esterni — residui del vecchio metodo icono-
grafico — insistenza the va un po' a scapito dei ri-
lievi sulla qualità e sulla determinazione delle persona-
lità artistiche.
37. Mitcheli. (H. P.). Some enamels of the
School of Godefroid de Claire (Buri. Magaz., marzo-
aprile 1919).
Illustra la croce esìstente nel museo Vittoria ed Al-
berto, decorata a smalti ch'egli attribuisce alla scuola
di Godefroid de Claire, il famoso orefice vallone del xii se-
L'Arte. XXII, 17.