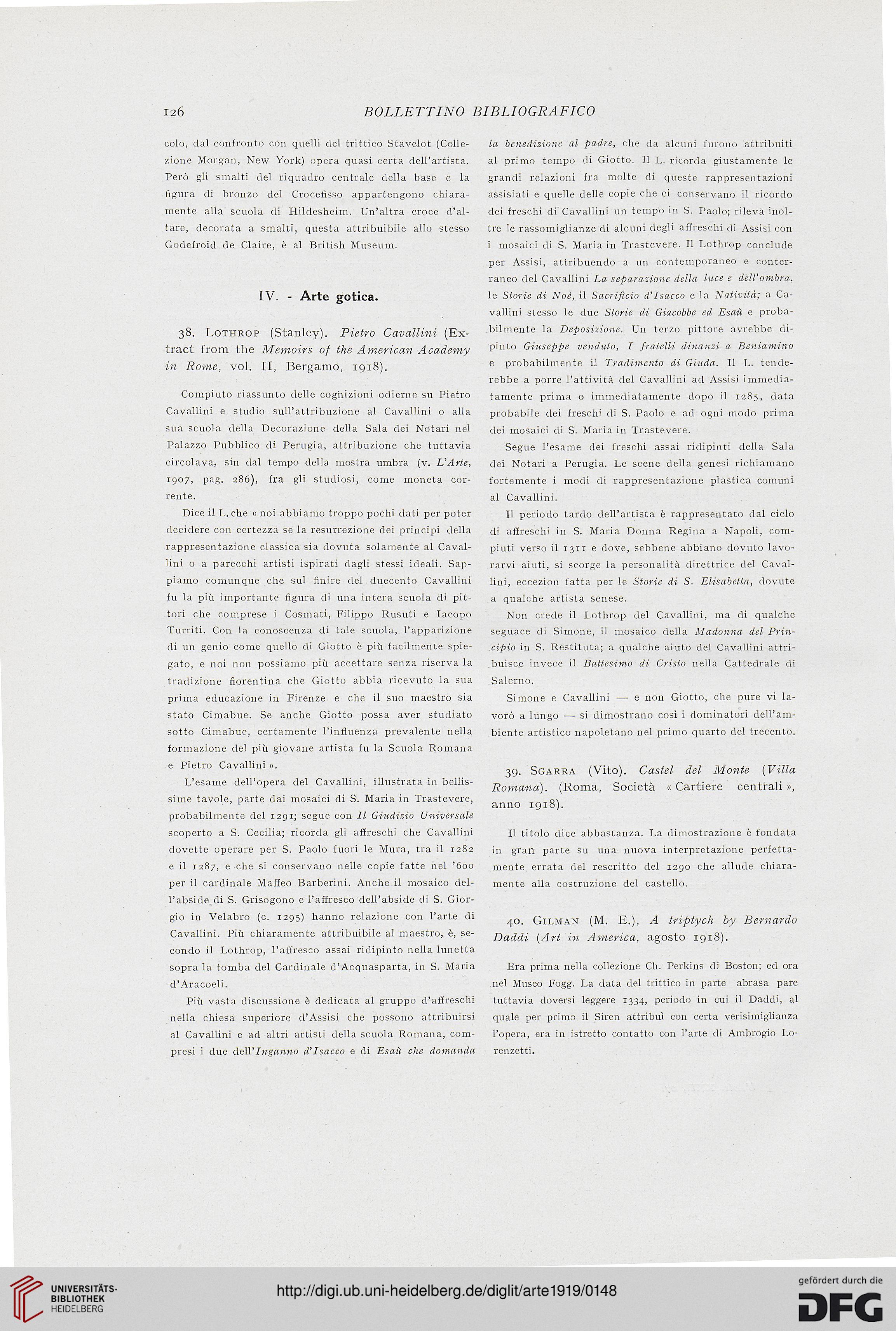126
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
colo, dal confronto con quelli del trittico Stavelot (Colle-
zione Morgan, New York) opera quasi certa dell'artista.
Però gli smalti del riquadro centrale della base e la
figura di bronzo del Crocefisso appartengono chiara-
mente alla scuola di Hildesheim. Un'altra croce d'al-
tare, decorata a smalti, questa attribuibile allo stesso
Godefroid de Claire, è al British Museum.
IV. - Arte gotica.
38. Lothrop (Stanley). Pietro Cavallini (Ex-
tract from the Memoirs of the American Academy
in Rome, voi. II, Bergamo, 1918).
Compiuto riassunto delle cognizioni odierne su Pietro
Cavallini e studio sull'attribuzione al Cavallini o alla
sua scuola della Decorazione della Sala dei Notari nel
Palazzo Pubblico di Perugia, attribuzione che tuttavia
circolava, sin dal tempo della mostra umbra (v. L'Arte,
1907, pag, 286), fra gli studiosi, come moneta cor-
rente.
Dice il L.che «noi abbiamo troppo pochi dati per poter
decidere con certezza se la resurrezione dei principi della
rappresentazione classica sia dovuta solamente al Caval-
lini o a parecchi artisti ispirati dagli stessi ideali. Sap-
piamo comunque che sul finire del duecento Cavallini
fu la più importante figura di una intera scuola di pit-
tori che comprese i Cosmati, Filippo Rusuti e Iacopo
Turriti. Con la conoscenza di tale scuola, l'apparizione
di un genio come quello di Giotto è più facilmente spie-
gato, e noi non possiamo più accettare senza riserva la
tradizione fiorentina che Giotto abbia ricevuto la sua
prima educazione in Firenze e che il suo maestro sia
stato Cimabue. Se anche Giotto possa aver studiato
sotto Cimabue, certamente l'influenza prevalente nella
formazione del più giovane artista fu la Scuola Romana
e Pietro Cavallini ».
L'esame dell'opera del Cavallini, illustrata in bellis-
sime tavole, parte dai mosaici di S. Maria in Trastevere,
probabilmente del 1291; segue con II Giudizio Universale
scoperto a S. Cecilia; ricorda gli affreschi che Cavallini
dovette operare per S. Paolo fuori le Mura, tra il 1282
e il 1287, e che si conservano nelle copie fatte nel '600
per il cardinale Maffeo Barberini. Anche il mosaico del-
l'abside di S. Grisogono e l'affresco dell'abside di S. Gior-
gio in Velabro (c. 1295) hanno relazione con l'arte di
Cavallini. Più chiaramente attribuibile al maestro, è, se-
condo il Lothrop, l'affresco assai ridipinto nella lunetta
sopra la tomba del Cardinale d'Acquasparta, in S. Maria
d'Aracoeli.
Più vasta discussione è dedicata al gruppo d'affreschi
nella chiesa superiore d'Assisi che possono attribuirsi
al Cavallini e ad altri artisti della scuola Romana, com-
presi i due delV Inganno d'Isacco e di Esaù che domanda
la benedizione, al padre, che da alcuni furono attribuiti
al primo tempo di Giotto. 11 L. ricorda giustamente le
grandi relazioni fra molte di queste rappresentazioni
assisiati e quelle delle copie che ci conservano il ricordo
dei freschi di Cavallini un tempo in S. Paolo; rileva inol-
tre le rassomiglianze di alcuni degli affreschi di Assisi con
i mosaici di S. Maria in Trastevere. Il Lothrop conclude
per Assisi, attribuendo a un contemporaneo e conter-
raneo del Cavallini La separazione della luce e dell'ombra,
le Storie di Noè, il Sacrificio d'Isacco e la Natività; a Ca-
vallini stesso le due Storie di Giacobbe ed Esaù e proba-
bilmente la Deposizione. Un terzo pittore avrebbe di-
pinto Giuseppe venduto, I fratelli dinanzi a Beniamino
e probabilmente il Tradimento di Giuda. Il L. tende-
rebbe a porre l'attività del Cavallini ad Assisi immedia-
tamente prima o immediatamente dopo il 1285, data
probabile dei freschi di S. Paolo e ad ogni modo prima
dei mosaici di S. Maria in Trastevere.
Segue l'esame dei freschi assai ridipinti della Sala
dei Notari a Perugia. Le scene della genesi richiamano
fortemente i modi di rappresentazione plastica comuni
al Cavallini.
Il periodo tardo dell'artista è rappresentato dal ciclo
di affreschi in S. Maria Donna Regina a Napoli, com-
piuti verso il 1311 e dove, sebbene abbiano dovuto lavo-
rarvi aiuti, si scorge la personalità direttrice del Caval-
lini, eccezion fatta per le Storie di S. Elisabetta, dovute
a qualche artista senese.
Non crede il Lothrop del Cavallini, ma di qualche
seguace di Simone, il mosaico della Madonna del Prin-
cipio in S. Restituta; a qualche aiuto del Cavallini attri-
buisce invece il Battesimo di Cristo nella Cattedrale di
Salerno.
Simone e Cavallini — e non Giotto, che pure vi la-
vorò a lungo — si dimostrano così i dominatori dell'am-
biente artistico napoletano nel primo quarto del trecento.
39. Sgarra (Vito). Castel del Monte {Villa
Romana). (Roma, Società « Cartiere centrali »,
anno 1918).
Il titolo dice abbastanza. La dimostrazione è fondata
in gran parte su una nuova interpretazione perfetta-
mente errata del rescritto del 1290 che allude chiara-
mente alla costruzione del castello.
40. Gilman (M. E.), A triptych by Bernardo
Daddi (Art in America, agosto 1918).
Era prima nella collezione Ch. Perkins di Boston; ed ora
.nel Museo Fogg. La data del trittico in parte abrasa pare
tuttavia doversi leggere 1334, periodo in cui il Daddi, al
quale per primo il Siren attribuì con certa verisimiglianza
l'opera, era in istretto contatto con l'arte di Ambrogio Lo-
renzetti.
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
colo, dal confronto con quelli del trittico Stavelot (Colle-
zione Morgan, New York) opera quasi certa dell'artista.
Però gli smalti del riquadro centrale della base e la
figura di bronzo del Crocefisso appartengono chiara-
mente alla scuola di Hildesheim. Un'altra croce d'al-
tare, decorata a smalti, questa attribuibile allo stesso
Godefroid de Claire, è al British Museum.
IV. - Arte gotica.
38. Lothrop (Stanley). Pietro Cavallini (Ex-
tract from the Memoirs of the American Academy
in Rome, voi. II, Bergamo, 1918).
Compiuto riassunto delle cognizioni odierne su Pietro
Cavallini e studio sull'attribuzione al Cavallini o alla
sua scuola della Decorazione della Sala dei Notari nel
Palazzo Pubblico di Perugia, attribuzione che tuttavia
circolava, sin dal tempo della mostra umbra (v. L'Arte,
1907, pag, 286), fra gli studiosi, come moneta cor-
rente.
Dice il L.che «noi abbiamo troppo pochi dati per poter
decidere con certezza se la resurrezione dei principi della
rappresentazione classica sia dovuta solamente al Caval-
lini o a parecchi artisti ispirati dagli stessi ideali. Sap-
piamo comunque che sul finire del duecento Cavallini
fu la più importante figura di una intera scuola di pit-
tori che comprese i Cosmati, Filippo Rusuti e Iacopo
Turriti. Con la conoscenza di tale scuola, l'apparizione
di un genio come quello di Giotto è più facilmente spie-
gato, e noi non possiamo più accettare senza riserva la
tradizione fiorentina che Giotto abbia ricevuto la sua
prima educazione in Firenze e che il suo maestro sia
stato Cimabue. Se anche Giotto possa aver studiato
sotto Cimabue, certamente l'influenza prevalente nella
formazione del più giovane artista fu la Scuola Romana
e Pietro Cavallini ».
L'esame dell'opera del Cavallini, illustrata in bellis-
sime tavole, parte dai mosaici di S. Maria in Trastevere,
probabilmente del 1291; segue con II Giudizio Universale
scoperto a S. Cecilia; ricorda gli affreschi che Cavallini
dovette operare per S. Paolo fuori le Mura, tra il 1282
e il 1287, e che si conservano nelle copie fatte nel '600
per il cardinale Maffeo Barberini. Anche il mosaico del-
l'abside di S. Grisogono e l'affresco dell'abside di S. Gior-
gio in Velabro (c. 1295) hanno relazione con l'arte di
Cavallini. Più chiaramente attribuibile al maestro, è, se-
condo il Lothrop, l'affresco assai ridipinto nella lunetta
sopra la tomba del Cardinale d'Acquasparta, in S. Maria
d'Aracoeli.
Più vasta discussione è dedicata al gruppo d'affreschi
nella chiesa superiore d'Assisi che possono attribuirsi
al Cavallini e ad altri artisti della scuola Romana, com-
presi i due delV Inganno d'Isacco e di Esaù che domanda
la benedizione, al padre, che da alcuni furono attribuiti
al primo tempo di Giotto. 11 L. ricorda giustamente le
grandi relazioni fra molte di queste rappresentazioni
assisiati e quelle delle copie che ci conservano il ricordo
dei freschi di Cavallini un tempo in S. Paolo; rileva inol-
tre le rassomiglianze di alcuni degli affreschi di Assisi con
i mosaici di S. Maria in Trastevere. Il Lothrop conclude
per Assisi, attribuendo a un contemporaneo e conter-
raneo del Cavallini La separazione della luce e dell'ombra,
le Storie di Noè, il Sacrificio d'Isacco e la Natività; a Ca-
vallini stesso le due Storie di Giacobbe ed Esaù e proba-
bilmente la Deposizione. Un terzo pittore avrebbe di-
pinto Giuseppe venduto, I fratelli dinanzi a Beniamino
e probabilmente il Tradimento di Giuda. Il L. tende-
rebbe a porre l'attività del Cavallini ad Assisi immedia-
tamente prima o immediatamente dopo il 1285, data
probabile dei freschi di S. Paolo e ad ogni modo prima
dei mosaici di S. Maria in Trastevere.
Segue l'esame dei freschi assai ridipinti della Sala
dei Notari a Perugia. Le scene della genesi richiamano
fortemente i modi di rappresentazione plastica comuni
al Cavallini.
Il periodo tardo dell'artista è rappresentato dal ciclo
di affreschi in S. Maria Donna Regina a Napoli, com-
piuti verso il 1311 e dove, sebbene abbiano dovuto lavo-
rarvi aiuti, si scorge la personalità direttrice del Caval-
lini, eccezion fatta per le Storie di S. Elisabetta, dovute
a qualche artista senese.
Non crede il Lothrop del Cavallini, ma di qualche
seguace di Simone, il mosaico della Madonna del Prin-
cipio in S. Restituta; a qualche aiuto del Cavallini attri-
buisce invece il Battesimo di Cristo nella Cattedrale di
Salerno.
Simone e Cavallini — e non Giotto, che pure vi la-
vorò a lungo — si dimostrano così i dominatori dell'am-
biente artistico napoletano nel primo quarto del trecento.
39. Sgarra (Vito). Castel del Monte {Villa
Romana). (Roma, Società « Cartiere centrali »,
anno 1918).
Il titolo dice abbastanza. La dimostrazione è fondata
in gran parte su una nuova interpretazione perfetta-
mente errata del rescritto del 1290 che allude chiara-
mente alla costruzione del castello.
40. Gilman (M. E.), A triptych by Bernardo
Daddi (Art in America, agosto 1918).
Era prima nella collezione Ch. Perkins di Boston; ed ora
.nel Museo Fogg. La data del trittico in parte abrasa pare
tuttavia doversi leggere 1334, periodo in cui il Daddi, al
quale per primo il Siren attribuì con certa verisimiglianza
l'opera, era in istretto contatto con l'arte di Ambrogio Lo-
renzetti.