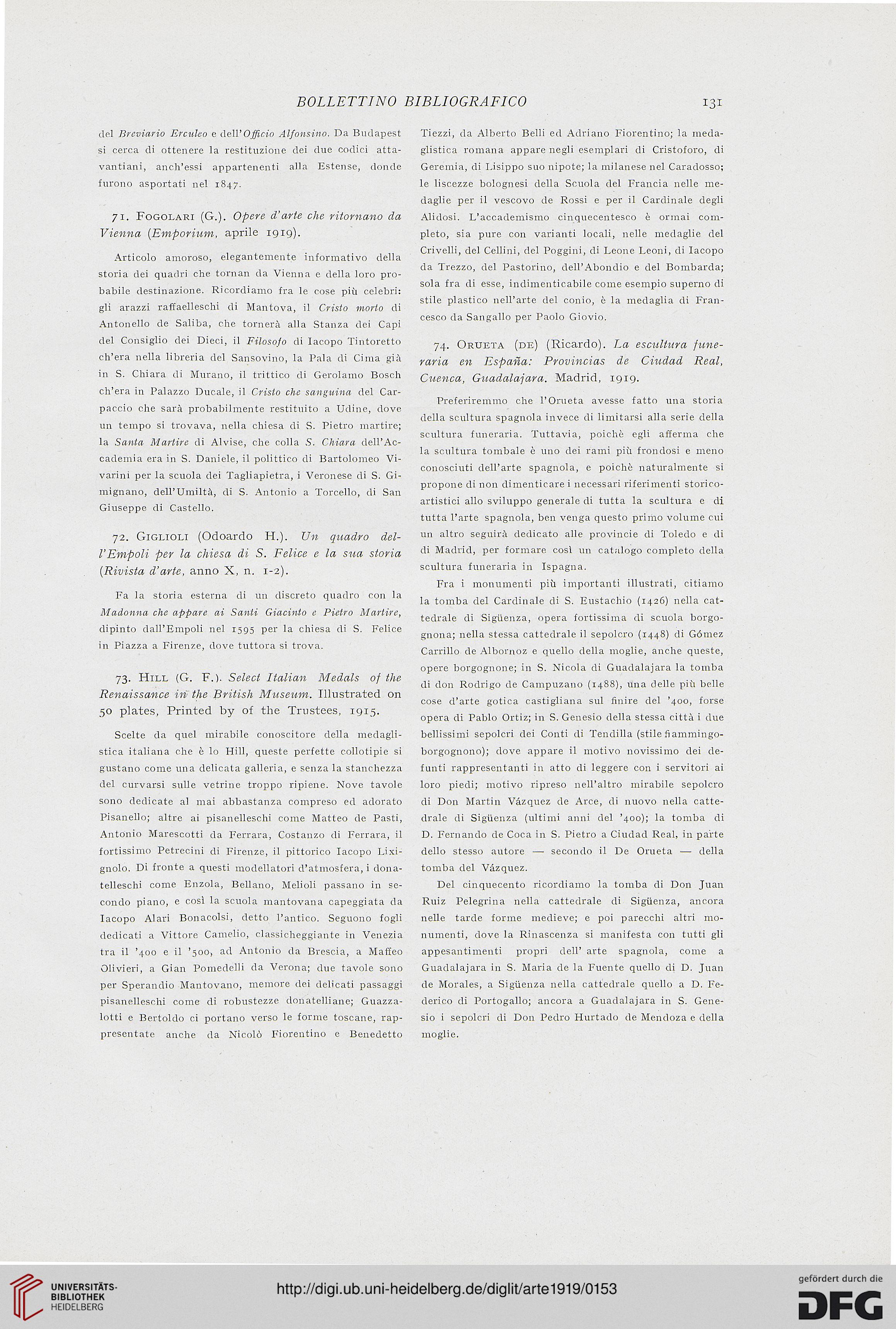BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
del Breviario Erculeo e dell'Officio Alfonsino. Da Budapest
si cerca di ottenere la restituzione dei due codici atta-
vantiani, anch'essi appartenenti alla Estense, donde
furono asportati nel 1847.
71. Fogolari (G.). Opere d'arte che ritornano da
Vienna (Emporium, aprile 1919).
Articolo amoroso, elegantemente informativo della
storia dei quadri che tornan da Vienna e della loro pro-
babile destinazione. Ricordiamo fra le cose più celebri:
gli arazzi raffaelleschi di Mantova, il Cristo morto di
Antonello de Saliba, che tornerà alla Stanza dei Capi
del Consiglio dei Dieci, il Filosofo di Iacopo Tintoretto
ch'era nella libreria del Sansovino, la Pala di Cima già
in S. Chiara di Murano, il trittico di Gerolamo Bosch
ch'era in Palazzo Ducale, il Cristo clic sanguina del Car-
paccio che sarà probabilmente restituito a Udine, dove
un tempo si trovava, nella chiesa di S. Pietro martire;
la Santa Martire di Alvise, che colla S. Chiara dell'Ac-
cademia era in S. Daniele, il polittico dì Bartolomeo Vi-
varini per la scuola dei Tagliapietra, i Veronese di S. Gi-
mignano, dell'Umiltà, di S. Antonio a Torcello, di San
Giuseppe di Castello.
72. Giglioli (Odoardo H.). Un quadro del-
l'Empoli per la chiesa di S. Felice e la sua storia
(Rivista d'arte, anno X, n. 1-2).
Fa la storia esterna di un discreto quadro con la
Madonna che appare ai Santi Giacinto e Pietro Martire,
dipinto dall'Empoli nel 1595 per la chiesa di S. Felice
in Piazza a Firenze, dove tuttora si trova.
73. Hill (G. F.). Select Italian Medals of the
Renaissance in the British Museum. Tllustrated on
50 plates, Printed by of the Trustees, 1915.
Scelte da quel mirabile conoscitore della medagli-
stica italiana che è lo Hill, queste perfette collotipie si
gustano come una delicata galleria, e senza la stanchezza
del curvarsi sulle vetrine troppo ripiene. Nove tavole
sono dedicate al mai abbastanza compreso ed adorato
Pisanello; altre ai pisanelleschi come Matteo de Pasti,
Antonio Marescotti da Ferrara, Costanzo di Ferrara, il
fortissimo Petrecini di Firenze, il pittorico Iacopo Lixi-
gnolo. Di fronte a questi modellatori d'atmosfera, i dona-
telleschi come Enzola, Bellano, Melioli passano in se-
condo piano, e cosi la scuola mantovana capeggiata da
Iacopo Alari Bonacolsi, detto l'antico. Seguono fogli
dedicati a Vittore Camelio, classicheggiante in Venezia
tra il '400 e il '500, ad Antonio da Brescia, a Maffeo
Olivieri, a Gian Pomedelli da Verona; due tavole sono
per Sperandio Mantovano, memore dei delicati passaggi
pisanelleschi come di robustezze donatelliane; Guazza-
lotti e Bertoldo ci portano verso le forme toscane, rap-
presentate anche da Nicolò Fiorentino e Benedetto
Tiezzi, da Alberto Belli ed Adriano Fiorentino; la meda-
glistica romana appare negli esemplari di Cristoforo, di
Geremia, di Lisippo suo nipote; la milanese nel Caradosso;
le liscezze bolognesi della Scuola del Francia nelle me-
daglie per il vescovo de Rossi e per il Cardinale degli
Alidosi. L'accademismo cinquecentesco è ormai com-
pleto, sia pure con varianti locali, nelle medaglie del
Crivelli, del Ccllini, del Poggini, di Leone Leoni, di Iacopo
da Trezzo, del Pastorino, dell'Abondio e del Bombarda;
sola fra di esse, indimenticabile come esempio superno di
stile plastico nell'arte del conio, è la medaglia di Fran-
cesco da San gallo per Paolo Giovio.
74. Orueta (de) (Ricardo). La escultura fune-
raria en Espana: Provincias de Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara. Madrid, 1919.
Preferiremmo che l'Orueta avesse fatto una storia
della scultura spagnola invece di limitarsi alla serie della
scultura funeraria. Tuttavia, poiché egli afferma che
la scultura tombale è uno dei rami più frondosi e meno
conosciuti dell'arte spagnola, e poiché naturalmente si
propone di non dimenticare i necessari riferimenti storico-
artistici allo sviluppo generale di tutta la scultura e di
tutta l'arte spagnola, ben venga questo primo volume cui
un altro seguirà dedicato alle Provincie di Toledo e di
di Madrid, per formare così un catalogo completo della
scultura funeraria in Ispagna.
Fra i monumenti più importanti illustrati, citiamo
la tomba del Cardinale di S. Eustachio (1426) nella cat-
tedrale di Siguenza, opera fortissima di scuola borgo-
gnona; nella stessa cattedrale il sepolcro {1448) di Gómez
Carrillo de Albornoz e quello della moglie, anche queste,
opere borgognone; in S. Nicola di Guadalajara la tomba
di don Rodrigo de Campuzano (1488), una delle più belle
cose d'arte gotica castigliana sul finire del '400, forse
opera di Pablo Ortiz; in S. Genesio della stessa città i due
bellissimi sepolcri dei Conti di Tendilla (stile fi ammingo-
borgognono); dove appare il motivo novissimo dei de-
funti rappresentanti in atto di leggere con i servitori ai
loro piedi; motivo ripreso nell'altro mirabile sepolcro
di Don Martin Vàzquez de Arce, di nuovo nella catte-
drale di Siguenza (ultimi anni del '400); la tomba di
D. Fernando de Coca in S. Pietro a Ciudad Real, in parte
dello stesso autore — secondo il De Orueta — della
tomba del Vàzquez.
Del cinquecento ricordiamo la tomba di Don Juan
Ruiz Pelegrina nella cattedrale di Siguenza, ancora
nelle tarde forme medieve; e poi parecchi altri mo-
numenti, dove la Rinascenza si manifesta con tutti gli
appesantimenti propri dell' arte spagnola, come a
Guadalajara in S. Maria de la Fuente quello di D. Juan
de Morales, a Siguenza nella cattedrale quello a D. Fe-
derico di Portogallo; ancora a Guadalajara in S. Gene-
sio i sepolcri di Don Pedro Hurtado de Mendoza e della
moglie.
del Breviario Erculeo e dell'Officio Alfonsino. Da Budapest
si cerca di ottenere la restituzione dei due codici atta-
vantiani, anch'essi appartenenti alla Estense, donde
furono asportati nel 1847.
71. Fogolari (G.). Opere d'arte che ritornano da
Vienna (Emporium, aprile 1919).
Articolo amoroso, elegantemente informativo della
storia dei quadri che tornan da Vienna e della loro pro-
babile destinazione. Ricordiamo fra le cose più celebri:
gli arazzi raffaelleschi di Mantova, il Cristo morto di
Antonello de Saliba, che tornerà alla Stanza dei Capi
del Consiglio dei Dieci, il Filosofo di Iacopo Tintoretto
ch'era nella libreria del Sansovino, la Pala di Cima già
in S. Chiara di Murano, il trittico di Gerolamo Bosch
ch'era in Palazzo Ducale, il Cristo clic sanguina del Car-
paccio che sarà probabilmente restituito a Udine, dove
un tempo si trovava, nella chiesa di S. Pietro martire;
la Santa Martire di Alvise, che colla S. Chiara dell'Ac-
cademia era in S. Daniele, il polittico dì Bartolomeo Vi-
varini per la scuola dei Tagliapietra, i Veronese di S. Gi-
mignano, dell'Umiltà, di S. Antonio a Torcello, di San
Giuseppe di Castello.
72. Giglioli (Odoardo H.). Un quadro del-
l'Empoli per la chiesa di S. Felice e la sua storia
(Rivista d'arte, anno X, n. 1-2).
Fa la storia esterna di un discreto quadro con la
Madonna che appare ai Santi Giacinto e Pietro Martire,
dipinto dall'Empoli nel 1595 per la chiesa di S. Felice
in Piazza a Firenze, dove tuttora si trova.
73. Hill (G. F.). Select Italian Medals of the
Renaissance in the British Museum. Tllustrated on
50 plates, Printed by of the Trustees, 1915.
Scelte da quel mirabile conoscitore della medagli-
stica italiana che è lo Hill, queste perfette collotipie si
gustano come una delicata galleria, e senza la stanchezza
del curvarsi sulle vetrine troppo ripiene. Nove tavole
sono dedicate al mai abbastanza compreso ed adorato
Pisanello; altre ai pisanelleschi come Matteo de Pasti,
Antonio Marescotti da Ferrara, Costanzo di Ferrara, il
fortissimo Petrecini di Firenze, il pittorico Iacopo Lixi-
gnolo. Di fronte a questi modellatori d'atmosfera, i dona-
telleschi come Enzola, Bellano, Melioli passano in se-
condo piano, e cosi la scuola mantovana capeggiata da
Iacopo Alari Bonacolsi, detto l'antico. Seguono fogli
dedicati a Vittore Camelio, classicheggiante in Venezia
tra il '400 e il '500, ad Antonio da Brescia, a Maffeo
Olivieri, a Gian Pomedelli da Verona; due tavole sono
per Sperandio Mantovano, memore dei delicati passaggi
pisanelleschi come di robustezze donatelliane; Guazza-
lotti e Bertoldo ci portano verso le forme toscane, rap-
presentate anche da Nicolò Fiorentino e Benedetto
Tiezzi, da Alberto Belli ed Adriano Fiorentino; la meda-
glistica romana appare negli esemplari di Cristoforo, di
Geremia, di Lisippo suo nipote; la milanese nel Caradosso;
le liscezze bolognesi della Scuola del Francia nelle me-
daglie per il vescovo de Rossi e per il Cardinale degli
Alidosi. L'accademismo cinquecentesco è ormai com-
pleto, sia pure con varianti locali, nelle medaglie del
Crivelli, del Ccllini, del Poggini, di Leone Leoni, di Iacopo
da Trezzo, del Pastorino, dell'Abondio e del Bombarda;
sola fra di esse, indimenticabile come esempio superno di
stile plastico nell'arte del conio, è la medaglia di Fran-
cesco da San gallo per Paolo Giovio.
74. Orueta (de) (Ricardo). La escultura fune-
raria en Espana: Provincias de Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara. Madrid, 1919.
Preferiremmo che l'Orueta avesse fatto una storia
della scultura spagnola invece di limitarsi alla serie della
scultura funeraria. Tuttavia, poiché egli afferma che
la scultura tombale è uno dei rami più frondosi e meno
conosciuti dell'arte spagnola, e poiché naturalmente si
propone di non dimenticare i necessari riferimenti storico-
artistici allo sviluppo generale di tutta la scultura e di
tutta l'arte spagnola, ben venga questo primo volume cui
un altro seguirà dedicato alle Provincie di Toledo e di
di Madrid, per formare così un catalogo completo della
scultura funeraria in Ispagna.
Fra i monumenti più importanti illustrati, citiamo
la tomba del Cardinale di S. Eustachio (1426) nella cat-
tedrale di Siguenza, opera fortissima di scuola borgo-
gnona; nella stessa cattedrale il sepolcro {1448) di Gómez
Carrillo de Albornoz e quello della moglie, anche queste,
opere borgognone; in S. Nicola di Guadalajara la tomba
di don Rodrigo de Campuzano (1488), una delle più belle
cose d'arte gotica castigliana sul finire del '400, forse
opera di Pablo Ortiz; in S. Genesio della stessa città i due
bellissimi sepolcri dei Conti di Tendilla (stile fi ammingo-
borgognono); dove appare il motivo novissimo dei de-
funti rappresentanti in atto di leggere con i servitori ai
loro piedi; motivo ripreso nell'altro mirabile sepolcro
di Don Martin Vàzquez de Arce, di nuovo nella catte-
drale di Siguenza (ultimi anni del '400); la tomba di
D. Fernando de Coca in S. Pietro a Ciudad Real, in parte
dello stesso autore — secondo il De Orueta — della
tomba del Vàzquez.
Del cinquecento ricordiamo la tomba di Don Juan
Ruiz Pelegrina nella cattedrale di Siguenza, ancora
nelle tarde forme medieve; e poi parecchi altri mo-
numenti, dove la Rinascenza si manifesta con tutti gli
appesantimenti propri dell' arte spagnola, come a
Guadalajara in S. Maria de la Fuente quello di D. Juan
de Morales, a Siguenza nella cattedrale quello a D. Fe-
derico di Portogallo; ancora a Guadalajara in S. Gene-
sio i sepolcri di Don Pedro Hurtado de Mendoza e della
moglie.