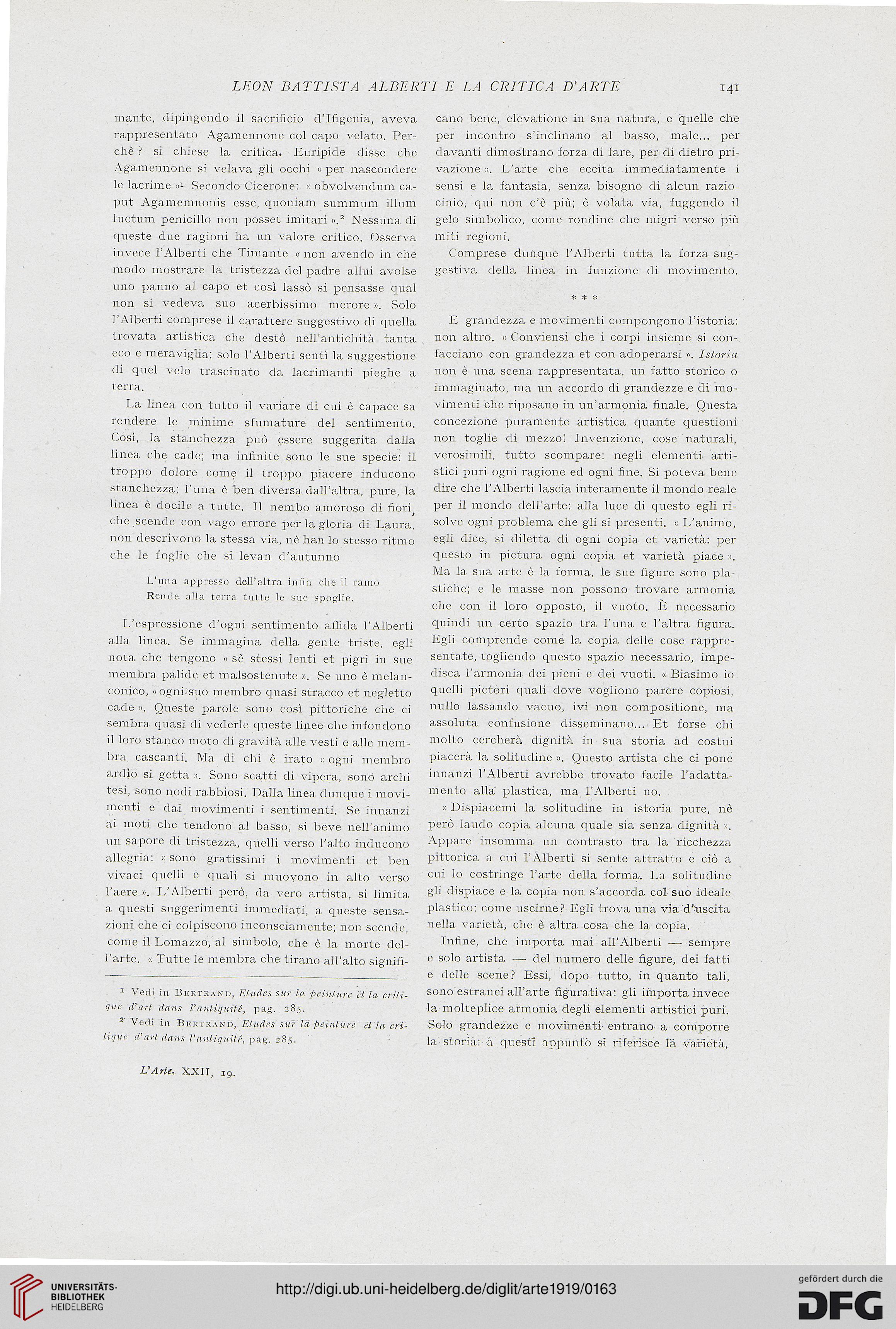LEON BATTISTA ALBERTI E LA CRITICA D'ARTE
mante, dipingendo il sacrificio d'Ifigenia, aveva
rappresentato Agamennone col capo velato. Per-
chè ? si chiese la critica. Euripide disse che
Agamennone si velava gli occhi « per nascondere
le lacrime »* Secondo Cicerone: « obvolvendum ca-
put Agamemnoriis esse, quoniam surhmum illuni
I net uni penicillo non posset imitari ».2 Nessuna di
queste due ragioni ha un valore critico. Osserva
invece l'Alberti che Timante « non avendo in che
modo mostrare la tristezza del padre allui avolse
uno panno al capo et così lassò si pensasse qual
non si vedeva suo acerbissimo merore ». Solo
l'Alberti comprese il carattere suggestivo di quella
trovata artistica che destò nell'antichità tanta
eco e meraviglia; solo l'Alberti sentì la suggestione
di quel velo trascinato dà lacrimanti pieghe a
terra.
La linea con tutto il variare di cui è capace sa
rendere le minime sfumature del sentimento.
Così, la stanchezza, può essere suggerita dalla
linea che cade; ma. infinite sono le sue specie: il
troppo dolore come il troppo piacere inducono
stanchezza; l'ima è ben diversa dall'altra, pure, la
linea è docile a tutte. 11 nembo amoroso di fiori
i
che scende con vago errore per la gloria di Laura,
non descrivono la stessa via, ne han lo stesso ritmo
che le foglie che si levan d'autunno
L'una appresso dell'altra infin che il ramo
Rende alla terra tutte le sue spoglie.
L'espressione d'ogni sentimento affida l'Alberti
alla linea. Se immagina della gente triste, egli
nota che tengono « sè stessi lenti et pigri in sue
membra palide et malsostehute ». Se uno è melan-
conico, «ogni'suo membro quasi stracco et negletto
cade ». Queste parole sono così pittoriche che ci
sembra quasi di vederle queste linee che infondono
il loro stanco moto di gravità alle vesti e alle mem-
bra cascanti. Ma di chi è irato « ogni membro
ardìo si getta ». Sono scatti di vipera, sono archi
tesi, sono nodi rabbiosi. Dalla linea dunque i movi-
menti e dai movimenti i sentimenti. Se innanzi
ai moti clie tendono al basso, si beve nell'animo
un sapore di tristezza, quelli versò l'alto inducono
allegrìa; « sono gratissimi i movimenti et ben
vivaci quelli e (piali si muovono in alto verso
l'aere ». L'Alberti però, da vero artista, si limita
a. questi suggerimenti immediati, a queste sensa-
zioni che ci colpiscono inconsciamente; non scende,
come il Lomazzo, al simbolo, che è la morte del-
l'arte. « Tutte le membra che tirano all'alto signifi-
1 Vedi in Bertrand, EHtdcs sur la pcìniure et la crìti-
que d'art dans l'antiquité, pag. 285.
3 Vedi in Bertrand, Elttdes sur la pelature' et la cri-
tique d'art dans l'antiquité, pag. 285.
cano bene, elevatione in sua natura, e quelle che
per incontro s'inclinano al basso, male... per
davanti dimostrano forza di fare, per di dietro pri-
vazione ». L'arte che eccita immediatamente i
sensi e la fantasia, senza bisogno di alcun razio-
cinio, qui non c'è più; è volata via, fuggendo il
gelo simbolico, come rondine che migri verso più
miti regioni.
Comprese dunque l'Alberti tutta la forza sug-
gestiva, della, linea, in funzione di movimento.
E grandezza e movimenti compongono l'istoria:
non altro. « Conviensi che i corpi insieme si con-
facciano con grandezza et con adoperarsi ». Istoria
non è una scena rappresentata, un fatto storico o
immaginato, ma un accordo di grandezze e di mo-
vimenti che riposano in un'armonia finale. Questa
concezione puramente artistica quante questioni
non toglie di mezzo! Invenzione, cose naturali,
verosimili, tutto scompare: negli elementi arti-
stici puri ogni ragione ed ogni fine. Si poteva bene
dire che l'Alberti lascia interamente il mondo reale
per il mondo dell'arte: alla luce di questo egli ri-
solve ogni problema che gli si presenti. « L'animo,
egli dice, si diletta di ogni copia et varietà: per
questo in pictura ogni copia et varietà piace ».
Ma la sua arte è la forma, le sue figure sono pla-
stiche; e le masse non possono trovare armonia
che con il loro opposto, il vuoto. E necessario
quindi un certo spazio tra, l'ima e l'altra figura.
Egli comprende come la copia, delle cose rappre-
sentate, togliendo questo spazio necessario, impe-
disca l'armonia dei pieni e dei vuoti. « Biasimo io
quelli pictori quali dove vogliono parere copiosi,
nullo lassando vacuo, ivi non compositione, ma
assoluta confusione disseminano... Et forse chi
molto cercherà dignità in sua storia ad costui
piacerà la solitudine ». Questo artista che ci pone
innanzi l'Alberti avrebbe trovato facile l'adatta-
mento alla' plastica, ma l'Alberti no.
« Dispiacemi la solitudine in istoria pure, nè
però laudo copia alcuna quale sia senza dignità ».
Appare insomma un contrasto tra la ricchezza
pittorica a cui l'Alberti si sente attratto e ciò a.
cui lo costringe l'arte della l'orma, f.a. solitudine
gli dispiace e la copia non s'accorda col suo ideale
plastico: come uscirne? Egli trova una via d'uscita
nella varietà; che è altra cosa che la copia.
Infine, che importa mai all'Alberti — sempre
e solo artista — del numero delle figure, dei fatti
e delle scene? Essi, dopo tutto, in quanto tali,
sono estranci all'arte figurativa: gli importa invece
la molteplice armonia degli elementi artistici puri.
Solo grandezze e movimenti entrano a comporre
la storia: a, questi appuntò si riferisce là varietà,
L'Arte. XXII, 19.
mante, dipingendo il sacrificio d'Ifigenia, aveva
rappresentato Agamennone col capo velato. Per-
chè ? si chiese la critica. Euripide disse che
Agamennone si velava gli occhi « per nascondere
le lacrime »* Secondo Cicerone: « obvolvendum ca-
put Agamemnoriis esse, quoniam surhmum illuni
I net uni penicillo non posset imitari ».2 Nessuna di
queste due ragioni ha un valore critico. Osserva
invece l'Alberti che Timante « non avendo in che
modo mostrare la tristezza del padre allui avolse
uno panno al capo et così lassò si pensasse qual
non si vedeva suo acerbissimo merore ». Solo
l'Alberti comprese il carattere suggestivo di quella
trovata artistica che destò nell'antichità tanta
eco e meraviglia; solo l'Alberti sentì la suggestione
di quel velo trascinato dà lacrimanti pieghe a
terra.
La linea con tutto il variare di cui è capace sa
rendere le minime sfumature del sentimento.
Così, la stanchezza, può essere suggerita dalla
linea che cade; ma. infinite sono le sue specie: il
troppo dolore come il troppo piacere inducono
stanchezza; l'ima è ben diversa dall'altra, pure, la
linea è docile a tutte. 11 nembo amoroso di fiori
i
che scende con vago errore per la gloria di Laura,
non descrivono la stessa via, ne han lo stesso ritmo
che le foglie che si levan d'autunno
L'una appresso dell'altra infin che il ramo
Rende alla terra tutte le sue spoglie.
L'espressione d'ogni sentimento affida l'Alberti
alla linea. Se immagina della gente triste, egli
nota che tengono « sè stessi lenti et pigri in sue
membra palide et malsostehute ». Se uno è melan-
conico, «ogni'suo membro quasi stracco et negletto
cade ». Queste parole sono così pittoriche che ci
sembra quasi di vederle queste linee che infondono
il loro stanco moto di gravità alle vesti e alle mem-
bra cascanti. Ma di chi è irato « ogni membro
ardìo si getta ». Sono scatti di vipera, sono archi
tesi, sono nodi rabbiosi. Dalla linea dunque i movi-
menti e dai movimenti i sentimenti. Se innanzi
ai moti clie tendono al basso, si beve nell'animo
un sapore di tristezza, quelli versò l'alto inducono
allegrìa; « sono gratissimi i movimenti et ben
vivaci quelli e (piali si muovono in alto verso
l'aere ». L'Alberti però, da vero artista, si limita
a. questi suggerimenti immediati, a queste sensa-
zioni che ci colpiscono inconsciamente; non scende,
come il Lomazzo, al simbolo, che è la morte del-
l'arte. « Tutte le membra che tirano all'alto signifi-
1 Vedi in Bertrand, EHtdcs sur la pcìniure et la crìti-
que d'art dans l'antiquité, pag. 285.
3 Vedi in Bertrand, Elttdes sur la pelature' et la cri-
tique d'art dans l'antiquité, pag. 285.
cano bene, elevatione in sua natura, e quelle che
per incontro s'inclinano al basso, male... per
davanti dimostrano forza di fare, per di dietro pri-
vazione ». L'arte che eccita immediatamente i
sensi e la fantasia, senza bisogno di alcun razio-
cinio, qui non c'è più; è volata via, fuggendo il
gelo simbolico, come rondine che migri verso più
miti regioni.
Comprese dunque l'Alberti tutta la forza sug-
gestiva, della, linea, in funzione di movimento.
E grandezza e movimenti compongono l'istoria:
non altro. « Conviensi che i corpi insieme si con-
facciano con grandezza et con adoperarsi ». Istoria
non è una scena rappresentata, un fatto storico o
immaginato, ma un accordo di grandezze e di mo-
vimenti che riposano in un'armonia finale. Questa
concezione puramente artistica quante questioni
non toglie di mezzo! Invenzione, cose naturali,
verosimili, tutto scompare: negli elementi arti-
stici puri ogni ragione ed ogni fine. Si poteva bene
dire che l'Alberti lascia interamente il mondo reale
per il mondo dell'arte: alla luce di questo egli ri-
solve ogni problema che gli si presenti. « L'animo,
egli dice, si diletta di ogni copia et varietà: per
questo in pictura ogni copia et varietà piace ».
Ma la sua arte è la forma, le sue figure sono pla-
stiche; e le masse non possono trovare armonia
che con il loro opposto, il vuoto. E necessario
quindi un certo spazio tra, l'ima e l'altra figura.
Egli comprende come la copia, delle cose rappre-
sentate, togliendo questo spazio necessario, impe-
disca l'armonia dei pieni e dei vuoti. « Biasimo io
quelli pictori quali dove vogliono parere copiosi,
nullo lassando vacuo, ivi non compositione, ma
assoluta confusione disseminano... Et forse chi
molto cercherà dignità in sua storia ad costui
piacerà la solitudine ». Questo artista che ci pone
innanzi l'Alberti avrebbe trovato facile l'adatta-
mento alla' plastica, ma l'Alberti no.
« Dispiacemi la solitudine in istoria pure, nè
però laudo copia alcuna quale sia senza dignità ».
Appare insomma un contrasto tra la ricchezza
pittorica a cui l'Alberti si sente attratto e ciò a.
cui lo costringe l'arte della l'orma, f.a. solitudine
gli dispiace e la copia non s'accorda col suo ideale
plastico: come uscirne? Egli trova una via d'uscita
nella varietà; che è altra cosa che la copia.
Infine, che importa mai all'Alberti — sempre
e solo artista — del numero delle figure, dei fatti
e delle scene? Essi, dopo tutto, in quanto tali,
sono estranci all'arte figurativa: gli importa invece
la molteplice armonia degli elementi artistici puri.
Solo grandezze e movimenti entrano a comporre
la storia: a, questi appuntò si riferisce là varietà,
L'Arte. XXII, 19.