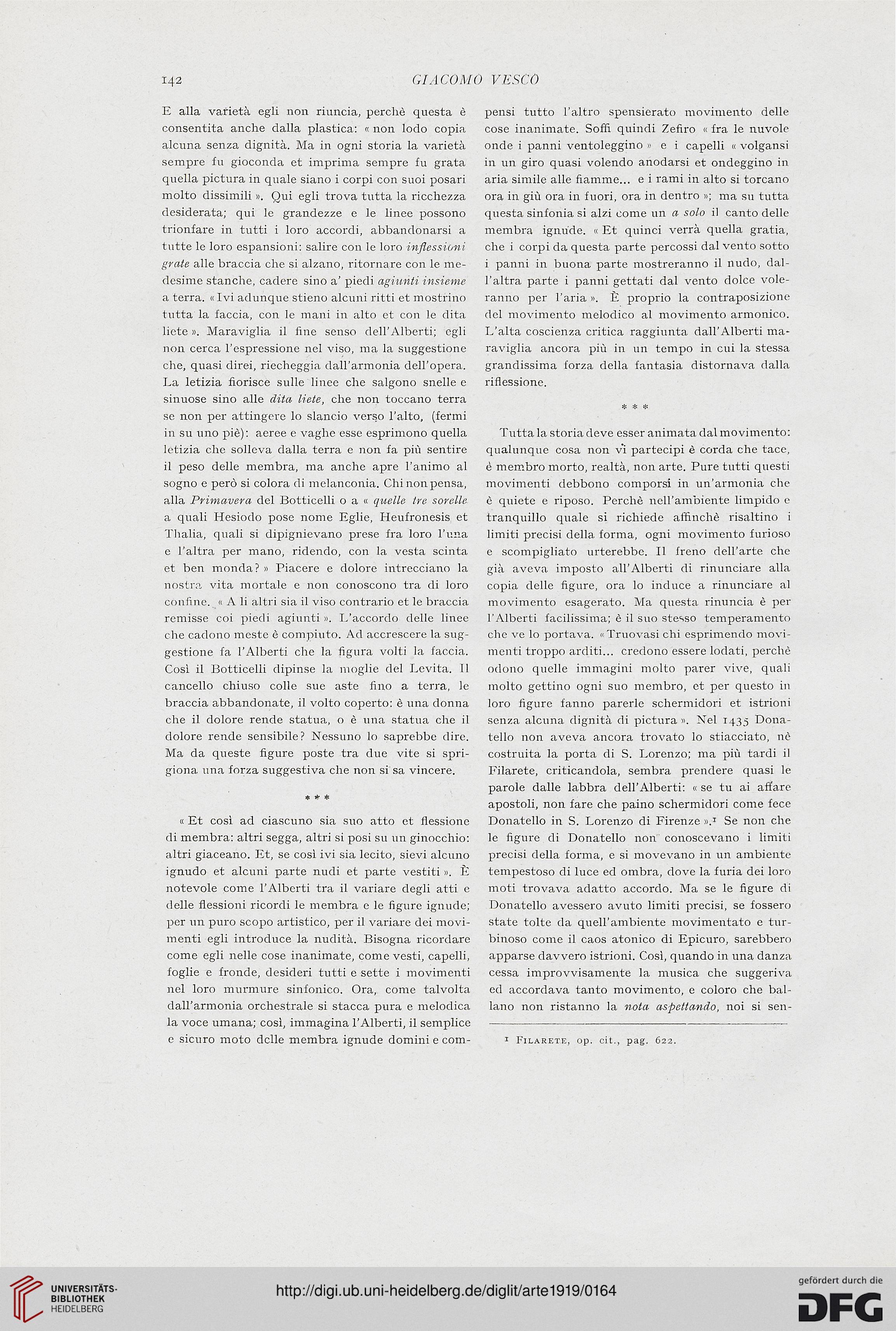142
GIACOMO VESCO
E alla varietà egli non riuncia, perchè questa è
consentita anche dalla plastica: « non lodo copia
alcuna senza dignità. Ma in ogni storia la varietà
sempre fu gioconda et imprima sempre fu grata
quella pictura in quale siano i corpi con suoi posari
molto dissimili ». Qui egli trova tutta la ricchezza
desiderata; qui le grandezze e le linee possono
trionfare in tutti i loro accordi, abbandonarsi a
tutte le loro espansioni: salire con le loro inflessioni
grate alle braccia che si alzano, ritornare con le me-
desime stanche, cadere sino a' piedi agiunti insieme
a terra. «Ivi adunque stieno alcuni ritti et mostrino
tutta la faccia, con le mani in alto et con le dita
liete ». Maraviglia il fine senso dell'Alberti; egli
non cerca l'espressione nel viso, ma la suggestione
che, quasi direi, riecheggia dall'armonia dell'opera.
La letizia fiorisce sulle linee che salgono snelle e
sinuose sino alle dita liete, che non toccano terra
se non per attingere lo slancio verso l'alto, (fermi
in su uno piè): aeree e vaghe esse esprimono quella
letizia che solleva dalla terra e non fa più sentire
il peso delle membra, ma anche apre l'animo al
sogno e però si colora di melanconia. Chi non pensa,
alla Primavera del Botticelli o a « quelle ire sorelle
a qiiali Hesiodo pose nome Eglie, Heufronesis, et
Thalia, quali si dipignievano prese fra loro l'uria
e l'altra per mano, ridendo, con la vesta scinta
et ben monda? » Piacere e dolore intrecciano la
nostra vita mortale e non conoscono tra di loro
confine. « A li altri sia il viso contrario et le braccia
remisse coi piedi agiunti ». L'accordo delle linee
che cadono meste è compiuto. Ad accrescere la sug-
gestione fa l'Alberti che la figura volti la faccia.
Così il Botticelli dipinse la moglie del Levita. 11
cancello chiuso colle sue aste fino a terra, le
braccia abbandonate, il volto coperto: è una donna
che il dolore rende statua, o è una statua che il
dolore rende sensibile? Nessuno lo saprebbe dire.
Ma da queste figure poste tra due vite si spri-
giona una forza suggestiva che non si sa vincere.
* * *
« Et cosi ad ciascuno sia suo atto et flessione
di membra: altri segga, altri si posi su un ginocchio:
altri giaceano. Et, se cosi ivi sia lecito, sievi alcuno
ignudo et alcuni parte nudi et parte vestiti ». È
notevole come l'Alberti tra il variare degli atti e
delle flessioni ricordi le membra e le figure ignude;
per un puro scopo artistico, per il variare dei movi-
menti egli introduce la nudità. Bisogna ricordare
come egli nelle cose inanimate, come vesti, capelli,
foglie e fronde, desideri tutti e sette i movimenti
nel loro murmure sinfonico. Ora, come talvolta
dall'armonia orchestrale si stacca pura e melodica
la voce umana; così, immagina l'Alberti, il semplice
e sicuro moto delle membra ignude domini e com-
pensi tutto l'altro spensierato movimento delle
cose inanimate. Soffi quindi Zefiro « fra le nuvole
onde i panni ventoleggino » e i capelli « volgansi
in un giro quasi volendo anodarsi et ondeggino in
aria simile alle fiamme... e i rami in alto si torcano
ora in giù ora in fuori, ora in dentro »; ma su tutta
questa sinfonia si alzi Come un a solo il canto delle
membra ignude. « Et quinci verrà quella grafia,
clic i corpi da questa parte percossi dal vento sotto
i panili in buona parte mostreranno il nudo, dal-
l'altra parte i panni gettati dal vento dolce vole-
ranno per l'aria». È proprio la contraposizione
del movimento melodico al movimento armonico.
L'alta coscienza critica raggiunta dall'Alberti ma-
raviglia ancora più in un tempo in cui la stessa
grandissima forza della fantasia distornava dalla
riflessione.
* * *
Tutta la storia deve esser animata dal movimento:
qualunque cosa non vi partecipi è corda che tace,
è membro morto, realtà, non arte. Pure tutti questi
movimenti debbono comporsi in un'armonia che
è quiete e riposo. Perchè nell'ambiente limpido e
tranquillo quale si richiede affinchè risaltino i
limiti precisi della forma, ogni movimento furioso
e scompigliato urterebbe. Il freno dell'arte che
già aveva imposto all'Alberti di rinunciare alla
copia delle figure, ora lo induce a rinunciare al
movimento esagerato. Ma questa rinuncia è per
l'Alberti facilissima; è il suo stesso temperamento
che ve lo portava. « Truovasi chi esprimendo movi-
menti troppo arditi... credono essere lodati, perchè
odono quelle immagini molto parer vive, quali
molto gettino ogni suo membro, et per questo in
loro figure fanno parerle schermidori et istrioni
senza alcuna dignità di pictura ». Nel 1435 Dona-
tello non aveva ancora trovato lo stiacciato, nè
costruita la porta di S. Lorenzo; ma più tardi il
Filarete, criticandola, sembra prendere quasi le
parole dalle labbra dell'Alberti: « se tu ai affare
apostoli, non fare che paino schermidori come fece
Donatello in S. Lorenzo di Firenze ».* Se non che
le figure di Donatello non conoscevano i limiti
precisi della forma, e si movevano in un ambiente
tempestoso di luce ed ombra, dove la furia dei loro
moti trovava adatto accordo. Ma se le figure di
Donatello avessero avuto limiti precisi, se fossero
state tolte da quell'ambiente movimentato c tur-
binoso come il caos atonico di Epicuro, sarebbero
apparse davvero istrioni. Così, quando in una danza
cessa improvvisamente la musica che suggeriva
ed accordava tanto movimento, e coloro che bal-
lano non ristanno la nota aspettando, noi si sen-
1 Filarete, op. cit., pag. 622.
GIACOMO VESCO
E alla varietà egli non riuncia, perchè questa è
consentita anche dalla plastica: « non lodo copia
alcuna senza dignità. Ma in ogni storia la varietà
sempre fu gioconda et imprima sempre fu grata
quella pictura in quale siano i corpi con suoi posari
molto dissimili ». Qui egli trova tutta la ricchezza
desiderata; qui le grandezze e le linee possono
trionfare in tutti i loro accordi, abbandonarsi a
tutte le loro espansioni: salire con le loro inflessioni
grate alle braccia che si alzano, ritornare con le me-
desime stanche, cadere sino a' piedi agiunti insieme
a terra. «Ivi adunque stieno alcuni ritti et mostrino
tutta la faccia, con le mani in alto et con le dita
liete ». Maraviglia il fine senso dell'Alberti; egli
non cerca l'espressione nel viso, ma la suggestione
che, quasi direi, riecheggia dall'armonia dell'opera.
La letizia fiorisce sulle linee che salgono snelle e
sinuose sino alle dita liete, che non toccano terra
se non per attingere lo slancio verso l'alto, (fermi
in su uno piè): aeree e vaghe esse esprimono quella
letizia che solleva dalla terra e non fa più sentire
il peso delle membra, ma anche apre l'animo al
sogno e però si colora di melanconia. Chi non pensa,
alla Primavera del Botticelli o a « quelle ire sorelle
a qiiali Hesiodo pose nome Eglie, Heufronesis, et
Thalia, quali si dipignievano prese fra loro l'uria
e l'altra per mano, ridendo, con la vesta scinta
et ben monda? » Piacere e dolore intrecciano la
nostra vita mortale e non conoscono tra di loro
confine. « A li altri sia il viso contrario et le braccia
remisse coi piedi agiunti ». L'accordo delle linee
che cadono meste è compiuto. Ad accrescere la sug-
gestione fa l'Alberti che la figura volti la faccia.
Così il Botticelli dipinse la moglie del Levita. 11
cancello chiuso colle sue aste fino a terra, le
braccia abbandonate, il volto coperto: è una donna
che il dolore rende statua, o è una statua che il
dolore rende sensibile? Nessuno lo saprebbe dire.
Ma da queste figure poste tra due vite si spri-
giona una forza suggestiva che non si sa vincere.
* * *
« Et cosi ad ciascuno sia suo atto et flessione
di membra: altri segga, altri si posi su un ginocchio:
altri giaceano. Et, se cosi ivi sia lecito, sievi alcuno
ignudo et alcuni parte nudi et parte vestiti ». È
notevole come l'Alberti tra il variare degli atti e
delle flessioni ricordi le membra e le figure ignude;
per un puro scopo artistico, per il variare dei movi-
menti egli introduce la nudità. Bisogna ricordare
come egli nelle cose inanimate, come vesti, capelli,
foglie e fronde, desideri tutti e sette i movimenti
nel loro murmure sinfonico. Ora, come talvolta
dall'armonia orchestrale si stacca pura e melodica
la voce umana; così, immagina l'Alberti, il semplice
e sicuro moto delle membra ignude domini e com-
pensi tutto l'altro spensierato movimento delle
cose inanimate. Soffi quindi Zefiro « fra le nuvole
onde i panni ventoleggino » e i capelli « volgansi
in un giro quasi volendo anodarsi et ondeggino in
aria simile alle fiamme... e i rami in alto si torcano
ora in giù ora in fuori, ora in dentro »; ma su tutta
questa sinfonia si alzi Come un a solo il canto delle
membra ignude. « Et quinci verrà quella grafia,
clic i corpi da questa parte percossi dal vento sotto
i panili in buona parte mostreranno il nudo, dal-
l'altra parte i panni gettati dal vento dolce vole-
ranno per l'aria». È proprio la contraposizione
del movimento melodico al movimento armonico.
L'alta coscienza critica raggiunta dall'Alberti ma-
raviglia ancora più in un tempo in cui la stessa
grandissima forza della fantasia distornava dalla
riflessione.
* * *
Tutta la storia deve esser animata dal movimento:
qualunque cosa non vi partecipi è corda che tace,
è membro morto, realtà, non arte. Pure tutti questi
movimenti debbono comporsi in un'armonia che
è quiete e riposo. Perchè nell'ambiente limpido e
tranquillo quale si richiede affinchè risaltino i
limiti precisi della forma, ogni movimento furioso
e scompigliato urterebbe. Il freno dell'arte che
già aveva imposto all'Alberti di rinunciare alla
copia delle figure, ora lo induce a rinunciare al
movimento esagerato. Ma questa rinuncia è per
l'Alberti facilissima; è il suo stesso temperamento
che ve lo portava. « Truovasi chi esprimendo movi-
menti troppo arditi... credono essere lodati, perchè
odono quelle immagini molto parer vive, quali
molto gettino ogni suo membro, et per questo in
loro figure fanno parerle schermidori et istrioni
senza alcuna dignità di pictura ». Nel 1435 Dona-
tello non aveva ancora trovato lo stiacciato, nè
costruita la porta di S. Lorenzo; ma più tardi il
Filarete, criticandola, sembra prendere quasi le
parole dalle labbra dell'Alberti: « se tu ai affare
apostoli, non fare che paino schermidori come fece
Donatello in S. Lorenzo di Firenze ».* Se non che
le figure di Donatello non conoscevano i limiti
precisi della forma, e si movevano in un ambiente
tempestoso di luce ed ombra, dove la furia dei loro
moti trovava adatto accordo. Ma se le figure di
Donatello avessero avuto limiti precisi, se fossero
state tolte da quell'ambiente movimentato c tur-
binoso come il caos atonico di Epicuro, sarebbero
apparse davvero istrioni. Così, quando in una danza
cessa improvvisamente la musica che suggeriva
ed accordava tanto movimento, e coloro che bal-
lano non ristanno la nota aspettando, noi si sen-
1 Filarete, op. cit., pag. 622.