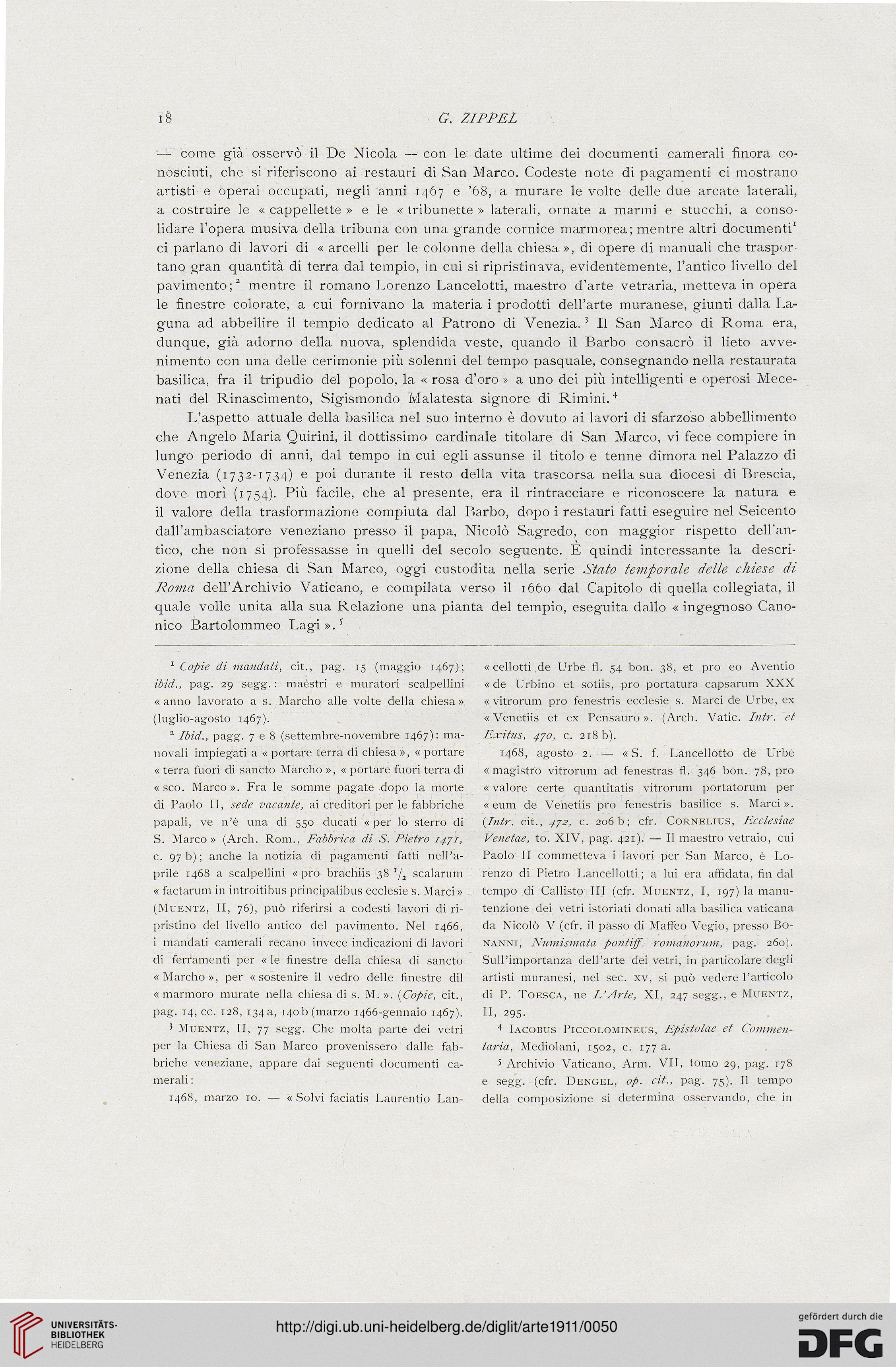G. ZIPPEL
- come già osservò il De Nicola — con le date ultime dei documenti camerali finora co-
nosciuti, che si riferiscono ai restauri di San Marco. Codeste note di pagamenti ci mostrano
artisti e operai occupati, negli anni 1467 e ’68, a murare le volte delle due arcate laterali,
a costruire le « cappelletto » e le « tribunette » laterali, ornate a marmi e stucchi, a conso-
lidare l’opera musiva della tribuna con una grande cornice marmorea; mentre altri documenti1
ci parlano di lavori di « arcelli per le colonne della chiesa », di opere di manuali che traspor-
tano gran quantità di terra dal tempio, in cui si ripristinava, evidentemente, l’antico livello del
pavimento;2 3 mentre il romano Lorenzo Lancelotti, maestro d’arte vetraria, metteva in opera
le finestre colorate, a cui fornivano la materia i prodotti dell’arte muranese, giunti dalla La-
guna ad abbellire il tempio dedicato al Patrono di Venezia.J II San Marco di Roma era,
dunque, già adorno della nuova, splendida veste, quando il Barbo consacrò il lieto avve-
nimento con una delle cerimonie più solenni del tempo pasquale, consegnando nella restaurata
basilica, fra il tripudio del popolo, la « rosa d’oro » a uno dei più intelligenti e operosi Mece-
nati del Rinascimento, Sigismondo Malatesta signore di Rimini.4
L’aspetto attuale della basilica nel suo interno è dovuto ai lavori di sfarzoso abbellimento
che Angelo Maria Quirini, il dottissimo cardinale titolare di San Marco, vi fece compiere in
lungo periodo di anni, dal tempo in cui egli assunse il titolo e tenne dimora nel Palazzo di
Venezia (1732-1734) e poi durante il resto della vita trascorsa nella sua diocesi di Brescia,
dove morì (1754). Più facile, che al presente, era il rintracciare e riconoscere la natura e
il valore della trasformazione compiuta dal Barbo, dopo i restauri fatti eseguire nel Seicento
dall’ambasciatore veneziano presso il papa, Nicolò Sagredo, con maggior rispetto dell'an-
tico, che non si professasse in quelli del secolo seguente. E quindi interessante la descri-
zione della chiesa di San Marco, oggi custodita nella serie Stato temporale delle chiese di
Roma dell’Archivio Vaticano, e compilata verso il 1660 dal Capitolo di quella collegiata, il
quale volle unita alla sua Relazione una pianta del tempio, eseguita dallo « ingegnoso Cano-
nico Bartolommeo Lagi ».s
1 Copie di mandati, cit., pag. 15 (maggio 1467);
ibid., pag. 29 segg. : maèstri e muratori scalpellini
« anno lavorato a s. Marcho alle volte della chiesa »
(luglio-agosto 1467).
2 Ibid., pagg. 7 e 8 (settembre-novembre 1467): ma-
novali impiegati a « portare terra di chiesa », « portare
« terra fuori di sancto Marcho », « portare fuori terra di
«sco. Marco». Fra le somme pagate dopo la morte
di Paolo II, sede vacante, ai creditori per le fabbriche
papali, ve n’è una di 550 ducati «per lo sterro di
S. Marco» (Arch. Rom., Fabbrica di S. Pietro 1471,
c. 97 b) ; anche la notizia di pagamenti fatti nell’a-
prile 1468 a scalpellini « prò brachiis 38 ’/j scalarum
« factarum in introitibus principalibus ecclesie s. Marci »
(Muentz, II, 76), può riferirsi a codesti lavori di ri-
pristino del livello antico del pavimento. Nel 1466,
i mandati canterali recano invece indicazioni di lavori
eli ferramenti per « le finestre della chiesa di sancto
« Marcho », per « sostenne il vedrò delle finestre dii
« marmoro murate nella chiesa di s. M. ». [Copie, cit.,
pag. 14, cc. 128, 1343, 140b (marzo 1466-gennaio 1467).
3 Muentz, II, 77 segg. Che molta parte dei vetri
per la Chiesa di San Marco provenissero dalle fab-
briche veneziane, appare dai seguenti documenti ca-
merali :
1468, marzo io. — « Solvi faciatis Laurentio Lan-
« cellotti de Urbe fi. 54 bon. 38, et prò eo Aventio
« de Urbino et sotiis, prò portatura capsarum XXX
« vitrorunt prò fenestris ecclesie s. Marci de Urbe, ex
« Venetiis et ex Pensauro». (Arch. Vatic. Intr. et
Exitus, 470, c. 218 b).
1468, agosto 2. — « S. f. Lancellotto de Urbe
« magistro vitrorunt ad fenestras fi. 346 bon. 78, prò
« valore certe quantitatis vitrorum portatorum per
« eum de Venetiis prò fenestris basilice s. Marci».
{Intr. cit., 472, c. 206 b; cfr. Cornelius, Ecclesiae
Venetae, to. XIV, pag. 421). — Il maestro vetraio, cui
Paolo II commetteva i lavori per San Marco, è Lo-
renzo di Pietro Lancellotti ; a lui era affidata, fin dal
tempo di Callisto III (cfr. Muentz, I, 197) la manu-
tenzione dei vetri istoriati donati alla basilica vaticana
da Nicolò V (cfr. il passo di Maffeo Vegio, presso Bo-
nanni, Numismata pontijf, romanorum, pag. 260).
Sull’importanza dell’arte dei vetri, in particolare degli
artisti nturanesi, nel sec. xv, si può vedere l’articolo
di P. Toesca, ne L’Arte, XI, 247 segg., e Muentz,
II, 295.
4 Iacobus Piccolomineus, Epistolae et Commen-
tario, Mediolani, 1502, c. 177 a.
s Archivio Vaticano, Arm. VII, tomo 29, pag. 178
e segg. (cfr. Dengel, op. cit., pag. 75). Il tempo
della composizione si determina osservando, che in
- come già osservò il De Nicola — con le date ultime dei documenti camerali finora co-
nosciuti, che si riferiscono ai restauri di San Marco. Codeste note di pagamenti ci mostrano
artisti e operai occupati, negli anni 1467 e ’68, a murare le volte delle due arcate laterali,
a costruire le « cappelletto » e le « tribunette » laterali, ornate a marmi e stucchi, a conso-
lidare l’opera musiva della tribuna con una grande cornice marmorea; mentre altri documenti1
ci parlano di lavori di « arcelli per le colonne della chiesa », di opere di manuali che traspor-
tano gran quantità di terra dal tempio, in cui si ripristinava, evidentemente, l’antico livello del
pavimento;2 3 mentre il romano Lorenzo Lancelotti, maestro d’arte vetraria, metteva in opera
le finestre colorate, a cui fornivano la materia i prodotti dell’arte muranese, giunti dalla La-
guna ad abbellire il tempio dedicato al Patrono di Venezia.J II San Marco di Roma era,
dunque, già adorno della nuova, splendida veste, quando il Barbo consacrò il lieto avve-
nimento con una delle cerimonie più solenni del tempo pasquale, consegnando nella restaurata
basilica, fra il tripudio del popolo, la « rosa d’oro » a uno dei più intelligenti e operosi Mece-
nati del Rinascimento, Sigismondo Malatesta signore di Rimini.4
L’aspetto attuale della basilica nel suo interno è dovuto ai lavori di sfarzoso abbellimento
che Angelo Maria Quirini, il dottissimo cardinale titolare di San Marco, vi fece compiere in
lungo periodo di anni, dal tempo in cui egli assunse il titolo e tenne dimora nel Palazzo di
Venezia (1732-1734) e poi durante il resto della vita trascorsa nella sua diocesi di Brescia,
dove morì (1754). Più facile, che al presente, era il rintracciare e riconoscere la natura e
il valore della trasformazione compiuta dal Barbo, dopo i restauri fatti eseguire nel Seicento
dall’ambasciatore veneziano presso il papa, Nicolò Sagredo, con maggior rispetto dell'an-
tico, che non si professasse in quelli del secolo seguente. E quindi interessante la descri-
zione della chiesa di San Marco, oggi custodita nella serie Stato temporale delle chiese di
Roma dell’Archivio Vaticano, e compilata verso il 1660 dal Capitolo di quella collegiata, il
quale volle unita alla sua Relazione una pianta del tempio, eseguita dallo « ingegnoso Cano-
nico Bartolommeo Lagi ».s
1 Copie di mandati, cit., pag. 15 (maggio 1467);
ibid., pag. 29 segg. : maèstri e muratori scalpellini
« anno lavorato a s. Marcho alle volte della chiesa »
(luglio-agosto 1467).
2 Ibid., pagg. 7 e 8 (settembre-novembre 1467): ma-
novali impiegati a « portare terra di chiesa », « portare
« terra fuori di sancto Marcho », « portare fuori terra di
«sco. Marco». Fra le somme pagate dopo la morte
di Paolo II, sede vacante, ai creditori per le fabbriche
papali, ve n’è una di 550 ducati «per lo sterro di
S. Marco» (Arch. Rom., Fabbrica di S. Pietro 1471,
c. 97 b) ; anche la notizia di pagamenti fatti nell’a-
prile 1468 a scalpellini « prò brachiis 38 ’/j scalarum
« factarum in introitibus principalibus ecclesie s. Marci »
(Muentz, II, 76), può riferirsi a codesti lavori di ri-
pristino del livello antico del pavimento. Nel 1466,
i mandati canterali recano invece indicazioni di lavori
eli ferramenti per « le finestre della chiesa di sancto
« Marcho », per « sostenne il vedrò delle finestre dii
« marmoro murate nella chiesa di s. M. ». [Copie, cit.,
pag. 14, cc. 128, 1343, 140b (marzo 1466-gennaio 1467).
3 Muentz, II, 77 segg. Che molta parte dei vetri
per la Chiesa di San Marco provenissero dalle fab-
briche veneziane, appare dai seguenti documenti ca-
merali :
1468, marzo io. — « Solvi faciatis Laurentio Lan-
« cellotti de Urbe fi. 54 bon. 38, et prò eo Aventio
« de Urbino et sotiis, prò portatura capsarum XXX
« vitrorunt prò fenestris ecclesie s. Marci de Urbe, ex
« Venetiis et ex Pensauro». (Arch. Vatic. Intr. et
Exitus, 470, c. 218 b).
1468, agosto 2. — « S. f. Lancellotto de Urbe
« magistro vitrorunt ad fenestras fi. 346 bon. 78, prò
« valore certe quantitatis vitrorum portatorum per
« eum de Venetiis prò fenestris basilice s. Marci».
{Intr. cit., 472, c. 206 b; cfr. Cornelius, Ecclesiae
Venetae, to. XIV, pag. 421). — Il maestro vetraio, cui
Paolo II commetteva i lavori per San Marco, è Lo-
renzo di Pietro Lancellotti ; a lui era affidata, fin dal
tempo di Callisto III (cfr. Muentz, I, 197) la manu-
tenzione dei vetri istoriati donati alla basilica vaticana
da Nicolò V (cfr. il passo di Maffeo Vegio, presso Bo-
nanni, Numismata pontijf, romanorum, pag. 260).
Sull’importanza dell’arte dei vetri, in particolare degli
artisti nturanesi, nel sec. xv, si può vedere l’articolo
di P. Toesca, ne L’Arte, XI, 247 segg., e Muentz,
II, 295.
4 Iacobus Piccolomineus, Epistolae et Commen-
tario, Mediolani, 1502, c. 177 a.
s Archivio Vaticano, Arm. VII, tomo 29, pag. 178
e segg. (cfr. Dengel, op. cit., pag. 75). Il tempo
della composizione si determina osservando, che in