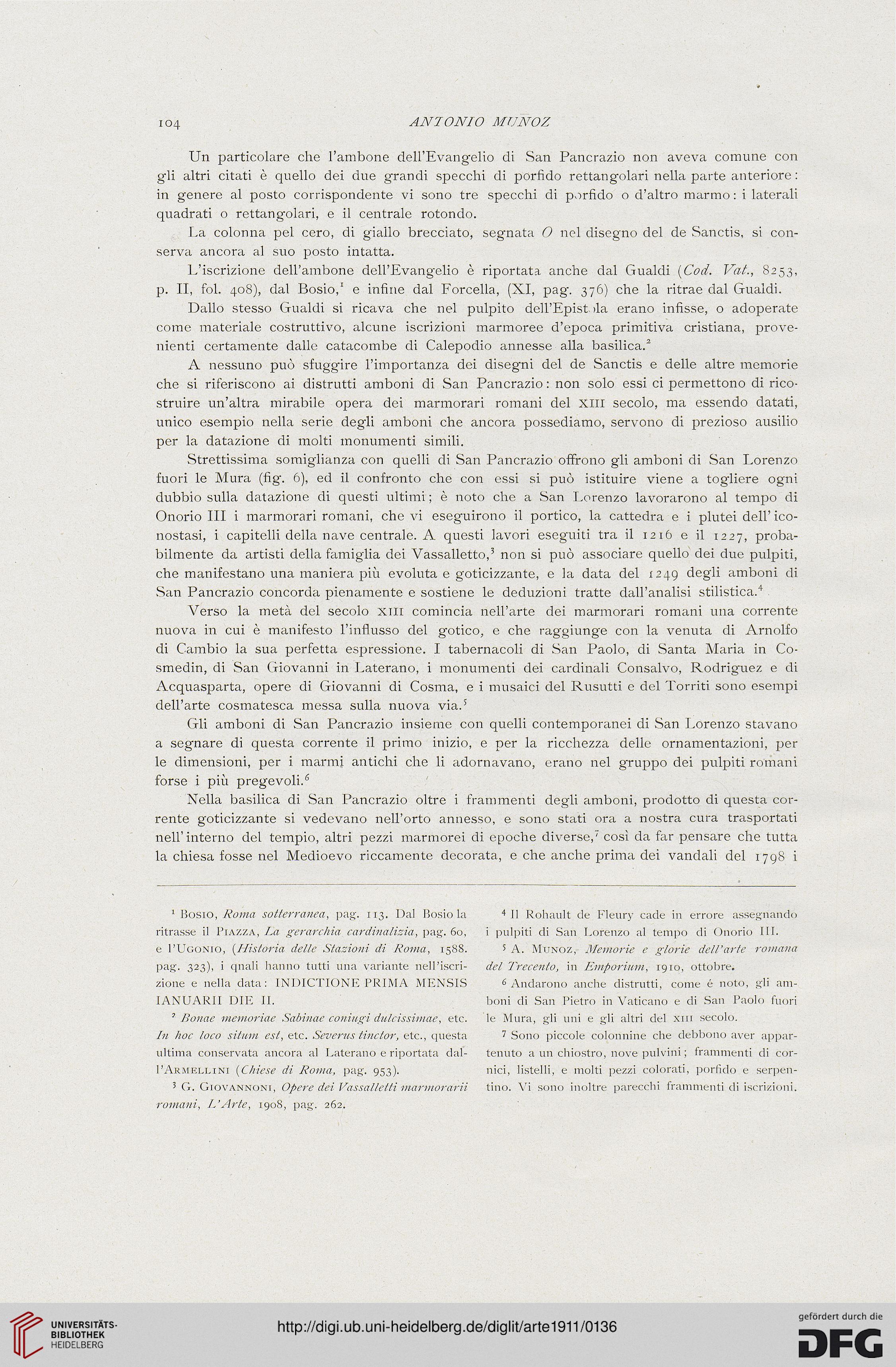104
ANTONIO MUNOZ
Un particolare che l’ambone dell’Evangelio di San Pancrazio non aveva comune con
gli altri citati è quello dei due grandi specchi di porfido rettangolari nella parte anteriore :
in genere al posto corrispondente vi sono tre specchi di porfido o d’altro marmo : i laterali
quadrati o rettangolari, e il centrale rotondo.
La colonna pel cero, di giallo brecciato, segnata O nel disegno del de Sanctis, si con-
serva ancora al suo posto intatta.
L’iscrizione dell’ambone dell’Evangelio è riportata anche dal Gualdi (Cod. Vai., 8253,
p. II, fol. 408), dal Bosio,1 e infine dal Forcella, (XI, pag\ 376) che la ritrae dal Gualdi.
Dallo stesso Gualdi si ricava che nel pulpito dell’Epist ila erano infisse, o adoperate
come materiale costruttivo, alcune iscrizioni marmoree d’epoca primitiva cristiana, prove-
nienti certamente dalle catacombe di Calepodio annesse alla basilica.2
A nessuno può sfuggire l’importanza dei disegni del de Sanctis e delle altre memorie
che si riferiscono ai distrutti amboni di San Pancrazio : non solo essi ci permettono di rico-
struire un’altra mirabile opera dei marmorari romani del xili secolo, ma essendo datati,
unico esempio nella serie degli amboni che ancora possediamo, servono di prezioso ausilio
per la datazione di molti monumenti simili.
Strettissima somiglianza con quelli di San Pancrazio offrono gli amboni di San Lorenzo
fuori le Mura (fìg. 6), ed il confronto che con essi si può istituire viene a togliere ogni
dubbio sulla datazione di questi ultimi ; è noto che a San Lorenzo lavorarono al tempo di
Onorio III i marmorari romani, che vi eseguirono il portico, la cattedra e i plutei dell’ ico-
nostasi, i capitelli della nave centrale. A questi lavori eseguiti tra il 1216 e il 1227, proba-
bilmente da artisti della famiglia dei Vassalletto,5 6 7 non si può associare quello dei due pulpiti,
che manifestano una maniera più evoluta e goticizzante, e la data del 1249 degli amboni di
San Pancrazio concorda pienamente e sostiene le deduzioni tratte dall’analisi stilistica.4
Verso la metà del secolo xili comincia nell’arte dei marmorari romani una corrente
nuova in cui è manifesto l’influsso del gotico, e che raggiunge con la venuta di Arnolfo
di Cambio la sua perfetta espressione. I tabernacoli di San Paolo, di Santa Maria in Co-
smedin, di San Giovanni in Laterano, i monumenti dei cardinali Consalvo, Rodriguez e di
Acquasparta, opere di Giovanni di Cosma, e i musaici del Rusutti e del Torriti sono esempi
dell’arte cosmatesca messa sulla nuova via.s
Gli amboni di San Pancrazio insieme con quelli contemporanei di San Lorenzo stavano
a segnare di questa corrente il primo inizio, e per la ricchezza delle ornamentazioni, per
le dimensioni, per i marmi antichi che li adornavano, erano nel gruppo dei pulpiti romani
forse i più pregevoli/
Nella basilica di San Pancrazio oltre i frammenti degli amboni, prodotto di questa cor-
rente goticizzante si vedevano nell’orto annesso, e sono stati ora a nostra cura trasportati
nell’interno del tempio, altri pezzi marmorei di epoche diverse,' così da far pensare che tutta
la chiesa fosse nel Medioevo riccamente decorata, e che anche prima dei vandali del 1798 i
1 Bosio, Roma sotterranea, pag. 113. Dal Bosio la
ritrasse il Piazza, La gerarchia cardinalìzia, pag. 60,
e I’Ugonio, (Historia delle Stazioni di Roma, 1588.
pag. 323), i quali hanno tutti una variante nell’iscri-
zione e nella data: INDICTIONK PRIMA MENSIS
IANUARII DIE II.
J Bonae memoriae Sabinae coniugi dulcissimae, etc.
In hoc loco sitimi est, etc. Severus tinctor, etc., questa
ultima conservata ancora al Laterano e riportata dal-
I’Armellini (Chiese di Roma, pag. 953).
5 G. Giovannont, Opere dei Vassallettì mormorarti
romani, L’Arte, 1908, pag. 262.
4 11 Rohault de Fleury cade in errore assegnando
i pulpiti di San Lorenzo al tempo di Onorio III.
5 A. Mijnoz, Memorie e glorie dell’arte romana
del Trecento, in Emporium, 1910, ottobre.
6 Andarono anche distrutti, come é noto, gli am-
boni di San Pietro in Vaticano e di San Paolo fuori
le Mura, gli uni e gli altri del xm secolo.
7 Sono piccole colonnine che debbono aver appar-
tenuto a un chiostro, nove pulvini ; frammenti di cor-
nici, listelli, e molti pezzi colorati, porfido e serpen-
tino. Vi sono inoltre parecchi frammenti di iscrizioni.
ANTONIO MUNOZ
Un particolare che l’ambone dell’Evangelio di San Pancrazio non aveva comune con
gli altri citati è quello dei due grandi specchi di porfido rettangolari nella parte anteriore :
in genere al posto corrispondente vi sono tre specchi di porfido o d’altro marmo : i laterali
quadrati o rettangolari, e il centrale rotondo.
La colonna pel cero, di giallo brecciato, segnata O nel disegno del de Sanctis, si con-
serva ancora al suo posto intatta.
L’iscrizione dell’ambone dell’Evangelio è riportata anche dal Gualdi (Cod. Vai., 8253,
p. II, fol. 408), dal Bosio,1 e infine dal Forcella, (XI, pag\ 376) che la ritrae dal Gualdi.
Dallo stesso Gualdi si ricava che nel pulpito dell’Epist ila erano infisse, o adoperate
come materiale costruttivo, alcune iscrizioni marmoree d’epoca primitiva cristiana, prove-
nienti certamente dalle catacombe di Calepodio annesse alla basilica.2
A nessuno può sfuggire l’importanza dei disegni del de Sanctis e delle altre memorie
che si riferiscono ai distrutti amboni di San Pancrazio : non solo essi ci permettono di rico-
struire un’altra mirabile opera dei marmorari romani del xili secolo, ma essendo datati,
unico esempio nella serie degli amboni che ancora possediamo, servono di prezioso ausilio
per la datazione di molti monumenti simili.
Strettissima somiglianza con quelli di San Pancrazio offrono gli amboni di San Lorenzo
fuori le Mura (fìg. 6), ed il confronto che con essi si può istituire viene a togliere ogni
dubbio sulla datazione di questi ultimi ; è noto che a San Lorenzo lavorarono al tempo di
Onorio III i marmorari romani, che vi eseguirono il portico, la cattedra e i plutei dell’ ico-
nostasi, i capitelli della nave centrale. A questi lavori eseguiti tra il 1216 e il 1227, proba-
bilmente da artisti della famiglia dei Vassalletto,5 6 7 non si può associare quello dei due pulpiti,
che manifestano una maniera più evoluta e goticizzante, e la data del 1249 degli amboni di
San Pancrazio concorda pienamente e sostiene le deduzioni tratte dall’analisi stilistica.4
Verso la metà del secolo xili comincia nell’arte dei marmorari romani una corrente
nuova in cui è manifesto l’influsso del gotico, e che raggiunge con la venuta di Arnolfo
di Cambio la sua perfetta espressione. I tabernacoli di San Paolo, di Santa Maria in Co-
smedin, di San Giovanni in Laterano, i monumenti dei cardinali Consalvo, Rodriguez e di
Acquasparta, opere di Giovanni di Cosma, e i musaici del Rusutti e del Torriti sono esempi
dell’arte cosmatesca messa sulla nuova via.s
Gli amboni di San Pancrazio insieme con quelli contemporanei di San Lorenzo stavano
a segnare di questa corrente il primo inizio, e per la ricchezza delle ornamentazioni, per
le dimensioni, per i marmi antichi che li adornavano, erano nel gruppo dei pulpiti romani
forse i più pregevoli/
Nella basilica di San Pancrazio oltre i frammenti degli amboni, prodotto di questa cor-
rente goticizzante si vedevano nell’orto annesso, e sono stati ora a nostra cura trasportati
nell’interno del tempio, altri pezzi marmorei di epoche diverse,' così da far pensare che tutta
la chiesa fosse nel Medioevo riccamente decorata, e che anche prima dei vandali del 1798 i
1 Bosio, Roma sotterranea, pag. 113. Dal Bosio la
ritrasse il Piazza, La gerarchia cardinalìzia, pag. 60,
e I’Ugonio, (Historia delle Stazioni di Roma, 1588.
pag. 323), i quali hanno tutti una variante nell’iscri-
zione e nella data: INDICTIONK PRIMA MENSIS
IANUARII DIE II.
J Bonae memoriae Sabinae coniugi dulcissimae, etc.
In hoc loco sitimi est, etc. Severus tinctor, etc., questa
ultima conservata ancora al Laterano e riportata dal-
I’Armellini (Chiese di Roma, pag. 953).
5 G. Giovannont, Opere dei Vassallettì mormorarti
romani, L’Arte, 1908, pag. 262.
4 11 Rohault de Fleury cade in errore assegnando
i pulpiti di San Lorenzo al tempo di Onorio III.
5 A. Mijnoz, Memorie e glorie dell’arte romana
del Trecento, in Emporium, 1910, ottobre.
6 Andarono anche distrutti, come é noto, gli am-
boni di San Pietro in Vaticano e di San Paolo fuori
le Mura, gli uni e gli altri del xm secolo.
7 Sono piccole colonnine che debbono aver appar-
tenuto a un chiostro, nove pulvini ; frammenti di cor-
nici, listelli, e molti pezzi colorati, porfido e serpen-
tino. Vi sono inoltre parecchi frammenti di iscrizioni.