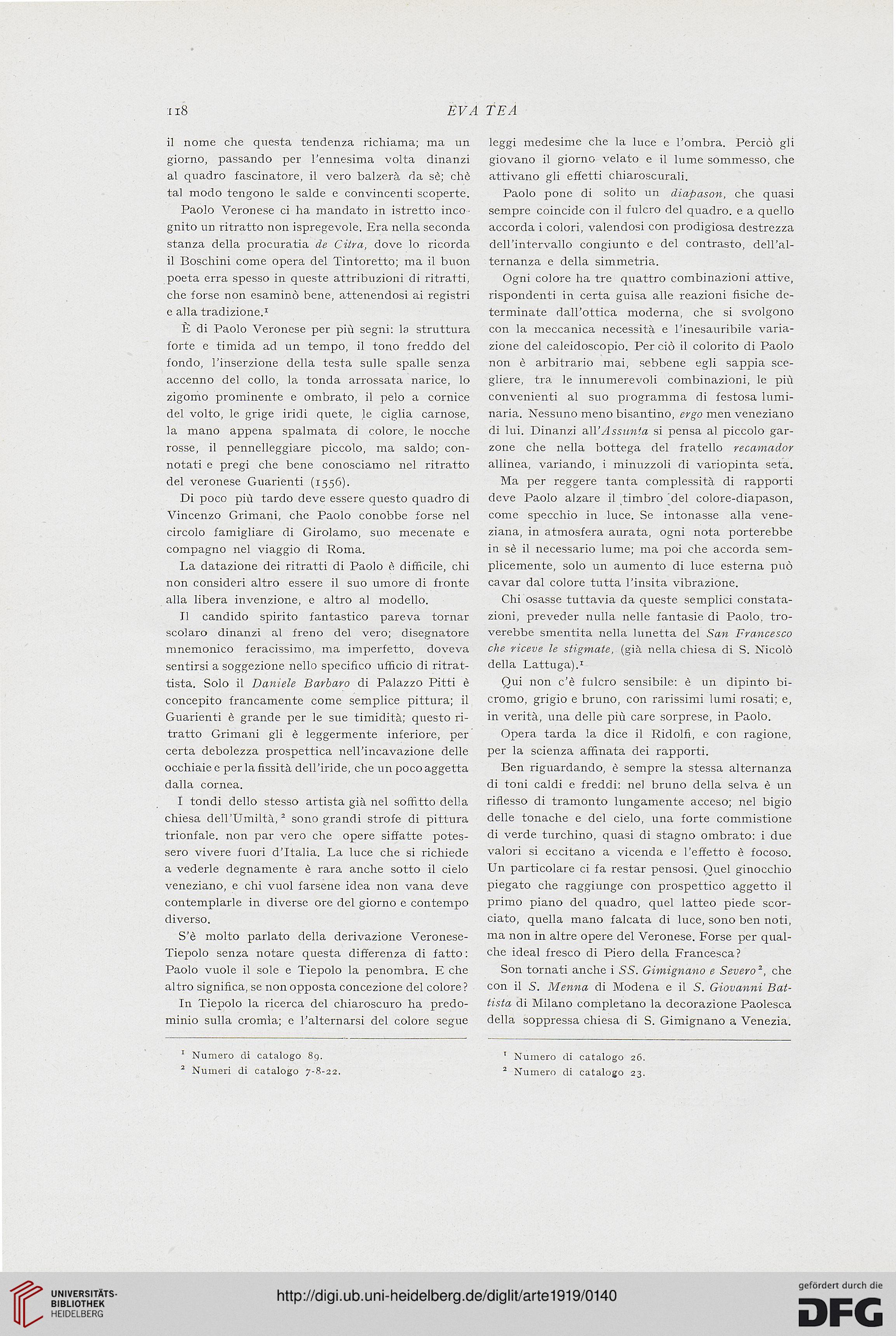118
ÈVA TEA
il nome che questa tendenza richiama; ma un
giorno, passando per l'ennesima volta dinanzi
al quadro fascinatore, il vero balzerà da sè; chè
tal modo tengono le salde e convincenti scoperte.
Paolo Veronese ci ha mandato in istretto inco-
gnito un ritratto non ispregevole. Era nella seconda
stanza della procuratia de Citra, dove lo ricorda
il Boschini come opera del Tintoretto; ma il buon
poeta erra spesso in queste attribuzioni di ritratti,
che forse non esaminò bene, attenendosi ai registri
e alla tradizione.1
E di Paolo Veronese per più segni: la struttura
forte e timida ad un tempo, il tono freddo del
fondo, l'inserzione della testa sulle spalle senza
accenno del collo, la tonda arrossata narice, lo
zìgomo prominente e ombrato, il pelo a cornice
del volto, le grige iridi quete, le ciglia carnose,
la mano appena spalmata di colore, le nocche
rosse, il pennclleggiare piccolo, ma saldo; con-
notati e pregi che bene conosciamo nel ritratto
del veronese Guarienti (1556).
Di poco più tardo deve essere questo quadro di
Vincenzo Grimani, che Paolo conobbe forse nel
circolo famigliare di Girolamo, suo mecenate e
compagno nel viaggio di Roma.
La datazione dei ritratti di Paolo è difficile, chi
non consideri altro essere il suo umore di fronte
alla libera invenzione, e altro al modello.
Il candido spirito fantastico pareva tornar
scolaro dinanzi al freno del vero; disegnatore
mnemonico feracissimo, ma imperfetto, doveva
sentirsi a soggezione nello specifico ufficio di ritrat-
tista. Solo il Daniele Barbaro di Palazzo Pitti è
concepito francamente come semplice pittura; il
Guarienti è grande per le sue timidità; questo ri-
tratto Grimani gli è leggermente inferiore, per
certa debolezza prospettica nell'incavazione delle
occhiaie e per la fissità dell'iride, che un poco aggetta
dalla cornea.
I tondi dello stesso artista già nel soffitto della
chiesa dell'Umiltà,2 sono grandi strofe di pittura
trionfale, non par vero che opere siffatte potes-
sero vivere fuori d'Italia. La luce che si richiede
a vederle degnamente è rara anche sotto il cielo
veneziano, e chi vuol farsene idea non vana deve
contemplarle in diverse ore del giorno e contempo
diverso.
S'è molto parlato della derivazione Veronese-
Tiepolo senza notare questa differenza di fatto :
Paolo vuole il sole e Tiepolo la penombra. E che
altro significa, se non opposta concezione del colore ?
fn Tiepolo la ricerca del chiaroscuro ha predo-
minio sulla cromia; e l'alternarsi del colore segue
leggi medesime che la luce e l'ombra. Perciò gli
giovano il giorno velato e il lume sommesso, che
attivano gli effetti chiaroscurali.
Paolo pone di solito un diapason, che quasi
sempre coincide con il fulcro del quadro, e a quello
accorda i colori, valendosi con prodigiosa destrezza
dell'intervallo congiunto e del contrasto, dell'al-
ternanza e della simmetria.
Ogni colore ha tre quattro combinazioni attive,
rispondenti in certa guisa alle reazioni fisiche de-
terminate dall'ottica moderna, che si svolgono
con la meccanica necessità e l'inesauribile varia-
zione del caleidoscopio. Per ciò il colorito di Paolo
non è arbitrario mai, sebbene egli sappia sce-
gliere, tra le innumerevoli combinazioni, le più
convenienti al suo programma di festosa lumi-
naria. Nessuno meno bisantino, ergo men veneziano
di lui. Dinanzi sdì'Assunta si pensa al piccolo gar-
zone che nella bottega del fratello recamador
allinea, variando, i minuzzoli di variopinta seta.
Ma per reggere tanta complessità di rapporti
deve Paolo alzare il timbro 'del colore-diapason,
come specchio in luce. Se intonasse alla vene-
ziana, in atmosfera aurata, ogni nota porterebbe
in sè il necessario lume; ma poi che accorda sem-
plicemente, solo un aumento di luce esterna può
cavar dal colore tutta l'insita vibrazione.
Chi osasse tuttavia da queste semplici constata-
zioni, preveder nulla nelle fantasie di Paolo, tro-
verebbe smentita nella lunetta del San Francesco
che riceve le stigmate, (già nella chiesa di S. Nicolò
della Lattuga).1
Qui non c'è fulcro sensibile: è un dipinto bi-
cromo, grigio e bruno, con rarissimi lumi rosati; e,
in verità, una delle più care sorprese, in Paolo.
Opera tarda la dice il Ridolfi, e con ragione,
per la scienza affinata dei rapporti.
Ben riguardando, è sempre la stessa alternanza
di toni caldi e freddi: nel bruno della selva è un
riflesso di tramonto lungamente acceso; nel bigio
delle tonache e del cielo, una forte commistione
di verde turchino, quasi di stagno ombrato: i due
valori si eccitano a vicenda e l'effetto è focoso.
Un particolare ci fa restar pensosi. Quel ginocchio
piegato che raggiunge con prospettico aggetto il
primo piano del quadro, quel latteo piede scor-
ciato, quella mano falcata di luce, sono ben noti,
ma non in altre opere del Veronese. Forse per qual-
che ideal fresco di Piero della Francesca?
Son tornati anche i SS. Gimignano e Severo 2, che
con il S. Menna di Modena e il S. Giovanni Bat-
tista di Milano completano la decorazione Paolesca
della soppressa chiesa di S. Gimignano a Venezia.
1 Numero di catalogo 89.
2 Numeri di catalogo 7-8-22.
' Numero di catalogo 26.
2 Numero di catalogo 23.
ÈVA TEA
il nome che questa tendenza richiama; ma un
giorno, passando per l'ennesima volta dinanzi
al quadro fascinatore, il vero balzerà da sè; chè
tal modo tengono le salde e convincenti scoperte.
Paolo Veronese ci ha mandato in istretto inco-
gnito un ritratto non ispregevole. Era nella seconda
stanza della procuratia de Citra, dove lo ricorda
il Boschini come opera del Tintoretto; ma il buon
poeta erra spesso in queste attribuzioni di ritratti,
che forse non esaminò bene, attenendosi ai registri
e alla tradizione.1
E di Paolo Veronese per più segni: la struttura
forte e timida ad un tempo, il tono freddo del
fondo, l'inserzione della testa sulle spalle senza
accenno del collo, la tonda arrossata narice, lo
zìgomo prominente e ombrato, il pelo a cornice
del volto, le grige iridi quete, le ciglia carnose,
la mano appena spalmata di colore, le nocche
rosse, il pennclleggiare piccolo, ma saldo; con-
notati e pregi che bene conosciamo nel ritratto
del veronese Guarienti (1556).
Di poco più tardo deve essere questo quadro di
Vincenzo Grimani, che Paolo conobbe forse nel
circolo famigliare di Girolamo, suo mecenate e
compagno nel viaggio di Roma.
La datazione dei ritratti di Paolo è difficile, chi
non consideri altro essere il suo umore di fronte
alla libera invenzione, e altro al modello.
Il candido spirito fantastico pareva tornar
scolaro dinanzi al freno del vero; disegnatore
mnemonico feracissimo, ma imperfetto, doveva
sentirsi a soggezione nello specifico ufficio di ritrat-
tista. Solo il Daniele Barbaro di Palazzo Pitti è
concepito francamente come semplice pittura; il
Guarienti è grande per le sue timidità; questo ri-
tratto Grimani gli è leggermente inferiore, per
certa debolezza prospettica nell'incavazione delle
occhiaie e per la fissità dell'iride, che un poco aggetta
dalla cornea.
I tondi dello stesso artista già nel soffitto della
chiesa dell'Umiltà,2 sono grandi strofe di pittura
trionfale, non par vero che opere siffatte potes-
sero vivere fuori d'Italia. La luce che si richiede
a vederle degnamente è rara anche sotto il cielo
veneziano, e chi vuol farsene idea non vana deve
contemplarle in diverse ore del giorno e contempo
diverso.
S'è molto parlato della derivazione Veronese-
Tiepolo senza notare questa differenza di fatto :
Paolo vuole il sole e Tiepolo la penombra. E che
altro significa, se non opposta concezione del colore ?
fn Tiepolo la ricerca del chiaroscuro ha predo-
minio sulla cromia; e l'alternarsi del colore segue
leggi medesime che la luce e l'ombra. Perciò gli
giovano il giorno velato e il lume sommesso, che
attivano gli effetti chiaroscurali.
Paolo pone di solito un diapason, che quasi
sempre coincide con il fulcro del quadro, e a quello
accorda i colori, valendosi con prodigiosa destrezza
dell'intervallo congiunto e del contrasto, dell'al-
ternanza e della simmetria.
Ogni colore ha tre quattro combinazioni attive,
rispondenti in certa guisa alle reazioni fisiche de-
terminate dall'ottica moderna, che si svolgono
con la meccanica necessità e l'inesauribile varia-
zione del caleidoscopio. Per ciò il colorito di Paolo
non è arbitrario mai, sebbene egli sappia sce-
gliere, tra le innumerevoli combinazioni, le più
convenienti al suo programma di festosa lumi-
naria. Nessuno meno bisantino, ergo men veneziano
di lui. Dinanzi sdì'Assunta si pensa al piccolo gar-
zone che nella bottega del fratello recamador
allinea, variando, i minuzzoli di variopinta seta.
Ma per reggere tanta complessità di rapporti
deve Paolo alzare il timbro 'del colore-diapason,
come specchio in luce. Se intonasse alla vene-
ziana, in atmosfera aurata, ogni nota porterebbe
in sè il necessario lume; ma poi che accorda sem-
plicemente, solo un aumento di luce esterna può
cavar dal colore tutta l'insita vibrazione.
Chi osasse tuttavia da queste semplici constata-
zioni, preveder nulla nelle fantasie di Paolo, tro-
verebbe smentita nella lunetta del San Francesco
che riceve le stigmate, (già nella chiesa di S. Nicolò
della Lattuga).1
Qui non c'è fulcro sensibile: è un dipinto bi-
cromo, grigio e bruno, con rarissimi lumi rosati; e,
in verità, una delle più care sorprese, in Paolo.
Opera tarda la dice il Ridolfi, e con ragione,
per la scienza affinata dei rapporti.
Ben riguardando, è sempre la stessa alternanza
di toni caldi e freddi: nel bruno della selva è un
riflesso di tramonto lungamente acceso; nel bigio
delle tonache e del cielo, una forte commistione
di verde turchino, quasi di stagno ombrato: i due
valori si eccitano a vicenda e l'effetto è focoso.
Un particolare ci fa restar pensosi. Quel ginocchio
piegato che raggiunge con prospettico aggetto il
primo piano del quadro, quel latteo piede scor-
ciato, quella mano falcata di luce, sono ben noti,
ma non in altre opere del Veronese. Forse per qual-
che ideal fresco di Piero della Francesca?
Son tornati anche i SS. Gimignano e Severo 2, che
con il S. Menna di Modena e il S. Giovanni Bat-
tista di Milano completano la decorazione Paolesca
della soppressa chiesa di S. Gimignano a Venezia.
1 Numero di catalogo 89.
2 Numeri di catalogo 7-8-22.
' Numero di catalogo 26.
2 Numero di catalogo 23.