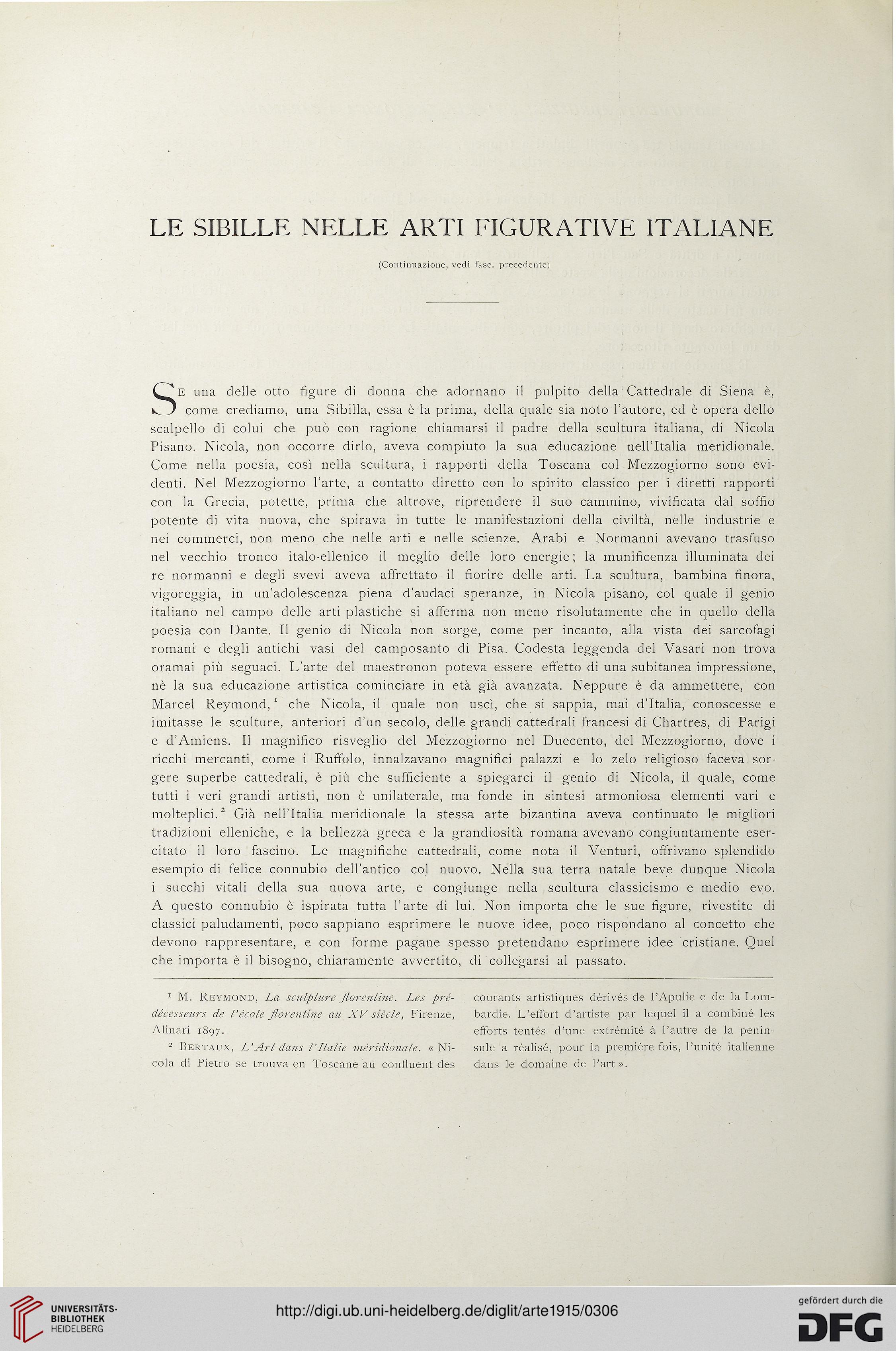LE SIBILLE NELLE ARTI FIGURATIVE ITALIANE
(Continuazione, vedi fase, precedente)
SE una delle otto figure di donna che adornano il pulpito della Cattedrale di Siena è,
_ come crediamo, una Sibilla, essa è la prima, della quale sia noto l’autore, ed è opera dello
scalpello di colui che può con ragione chiamarsi il padre della scultura italiana, di Nicola
Pisano. Nicola, non occorre dirlo, aveva compiuto la sua educazione nellTtalia meridionale.
Come nella poesia, così nella scultura, i rapporti della Toscana col Mezzogiorno sono evi-
denti. Nel Mezzogiorno l’arte, a contatto diretto con lo spirito classico per i diretti rapporti
con la Grecia, potette, prima che altrove, riprendere il suo cammino, vivificata dal soffio
potente di vita nuova, che spirava in tutte le manifestazioni della civiltà, nelle industrie e
nei commerci, non meno che nelle arti e nelle scienze. Arabi e Normanni avevano trasfuso
nel vecchio tronco italo-ellenico il meglio delle loro energie; la munificenza illuminata dei
re normanni e degli svevi aveva affrettato il fiorire delle arti. La scultura, bambina finora,
vigoreggia, in un’adolescenza piena d’audaci speranze, in Nicola pisano, col quale il genio
italiano nel campo delle arti plastiche si afferma non meno risolutamente che in quello della
poesia con Dante. Il genio di Nicola non sorge, come per incanto, alla vista dei sarcofagi
romani e degli antichi vasi del camposanto di Pisa. Codesta leggenda del Vasari non trova
oramai più seguaci. L’arte del maestronon poteva essere effetto di una subitanea impressione,
nè la sua educazione artistica cominciare in età già avanzata. Neppure è da ammettere, con
Marcel Reymond,1 che Nicola, il quale non uscì, che si sappia, mai d’Italia, conoscesse e
imitasse le sculture, anteriori d’un secolo, delle grandi cattedrali francesi di Chartres, di Parigi
e d’Amiens. Il magnifico risveglio del Mezzogiorno nel Duecento, del Mezzogiorno, dove i
ricchi mercanti, come i Ruffolo, innalzavano magnifici palazzi e lo zelo religioso faceva sor-
gere superbe cattedrali, è più che sufficiente a spiegarci il genio di Nicola, il quale, come
tutti i veri grandi artisti, non è unilaterale, ma fonde in sintesi armoniosa elementi vari e
molteplici.2 Già nellTtalia meridionale la stessa arte bizantina aveva continuato le migliori
tradizioni elleniche, e la bellezza greca e la grandiosità romana avevano congiuntamente eser-
citato il loro fascino. Le magnifiche cattedrali, come nota il Venturi, offrivano splendido
esempio di felice connubio dell’antico col nuovo. Nella sua terra natale beve dunque Nicola
i succhi vitali della sua nuova arte, e congiunge nella scultura classicismo e medio evo.
A questo connubio è ispirata tutta l’arte di lui. Non importa che le sue figure, rivestite di
classici paludamenti, poco sappiano esprimere le nuove idee, poco rispondano al concetto che
devono rappresentare, e con forme pagane spesso pretendano esprimere idee cristiane. Quel
che importa è il bisogno, chiaramente avvertito, di collegarsi al passato.
1 M. Reymond, La sculpture fiorentine. Les pré-
décesseurs de Fècole fiorentine au XV siècle, Firenze,
Alinari 1897.
2 Bertaux, L’Art dans FItalie méridionale. « Ni-
cola di Pietro se trouva en Toscane au contluent des
courants artistiques dérivés de l’Apulie e de la Lom-
bardie. L’effort d’artiste par lequel il a combiné les
efforts tentés d’une extrémité à l’autre de la penin-
sule a réalisé, pour la première fois, l’unité italienne
dans le domaine de l’art».
(Continuazione, vedi fase, precedente)
SE una delle otto figure di donna che adornano il pulpito della Cattedrale di Siena è,
_ come crediamo, una Sibilla, essa è la prima, della quale sia noto l’autore, ed è opera dello
scalpello di colui che può con ragione chiamarsi il padre della scultura italiana, di Nicola
Pisano. Nicola, non occorre dirlo, aveva compiuto la sua educazione nellTtalia meridionale.
Come nella poesia, così nella scultura, i rapporti della Toscana col Mezzogiorno sono evi-
denti. Nel Mezzogiorno l’arte, a contatto diretto con lo spirito classico per i diretti rapporti
con la Grecia, potette, prima che altrove, riprendere il suo cammino, vivificata dal soffio
potente di vita nuova, che spirava in tutte le manifestazioni della civiltà, nelle industrie e
nei commerci, non meno che nelle arti e nelle scienze. Arabi e Normanni avevano trasfuso
nel vecchio tronco italo-ellenico il meglio delle loro energie; la munificenza illuminata dei
re normanni e degli svevi aveva affrettato il fiorire delle arti. La scultura, bambina finora,
vigoreggia, in un’adolescenza piena d’audaci speranze, in Nicola pisano, col quale il genio
italiano nel campo delle arti plastiche si afferma non meno risolutamente che in quello della
poesia con Dante. Il genio di Nicola non sorge, come per incanto, alla vista dei sarcofagi
romani e degli antichi vasi del camposanto di Pisa. Codesta leggenda del Vasari non trova
oramai più seguaci. L’arte del maestronon poteva essere effetto di una subitanea impressione,
nè la sua educazione artistica cominciare in età già avanzata. Neppure è da ammettere, con
Marcel Reymond,1 che Nicola, il quale non uscì, che si sappia, mai d’Italia, conoscesse e
imitasse le sculture, anteriori d’un secolo, delle grandi cattedrali francesi di Chartres, di Parigi
e d’Amiens. Il magnifico risveglio del Mezzogiorno nel Duecento, del Mezzogiorno, dove i
ricchi mercanti, come i Ruffolo, innalzavano magnifici palazzi e lo zelo religioso faceva sor-
gere superbe cattedrali, è più che sufficiente a spiegarci il genio di Nicola, il quale, come
tutti i veri grandi artisti, non è unilaterale, ma fonde in sintesi armoniosa elementi vari e
molteplici.2 Già nellTtalia meridionale la stessa arte bizantina aveva continuato le migliori
tradizioni elleniche, e la bellezza greca e la grandiosità romana avevano congiuntamente eser-
citato il loro fascino. Le magnifiche cattedrali, come nota il Venturi, offrivano splendido
esempio di felice connubio dell’antico col nuovo. Nella sua terra natale beve dunque Nicola
i succhi vitali della sua nuova arte, e congiunge nella scultura classicismo e medio evo.
A questo connubio è ispirata tutta l’arte di lui. Non importa che le sue figure, rivestite di
classici paludamenti, poco sappiano esprimere le nuove idee, poco rispondano al concetto che
devono rappresentare, e con forme pagane spesso pretendano esprimere idee cristiane. Quel
che importa è il bisogno, chiaramente avvertito, di collegarsi al passato.
1 M. Reymond, La sculpture fiorentine. Les pré-
décesseurs de Fècole fiorentine au XV siècle, Firenze,
Alinari 1897.
2 Bertaux, L’Art dans FItalie méridionale. « Ni-
cola di Pietro se trouva en Toscane au contluent des
courants artistiques dérivés de l’Apulie e de la Lom-
bardie. L’effort d’artiste par lequel il a combiné les
efforts tentés d’une extrémité à l’autre de la penin-
sule a réalisé, pour la première fois, l’unité italienne
dans le domaine de l’art».