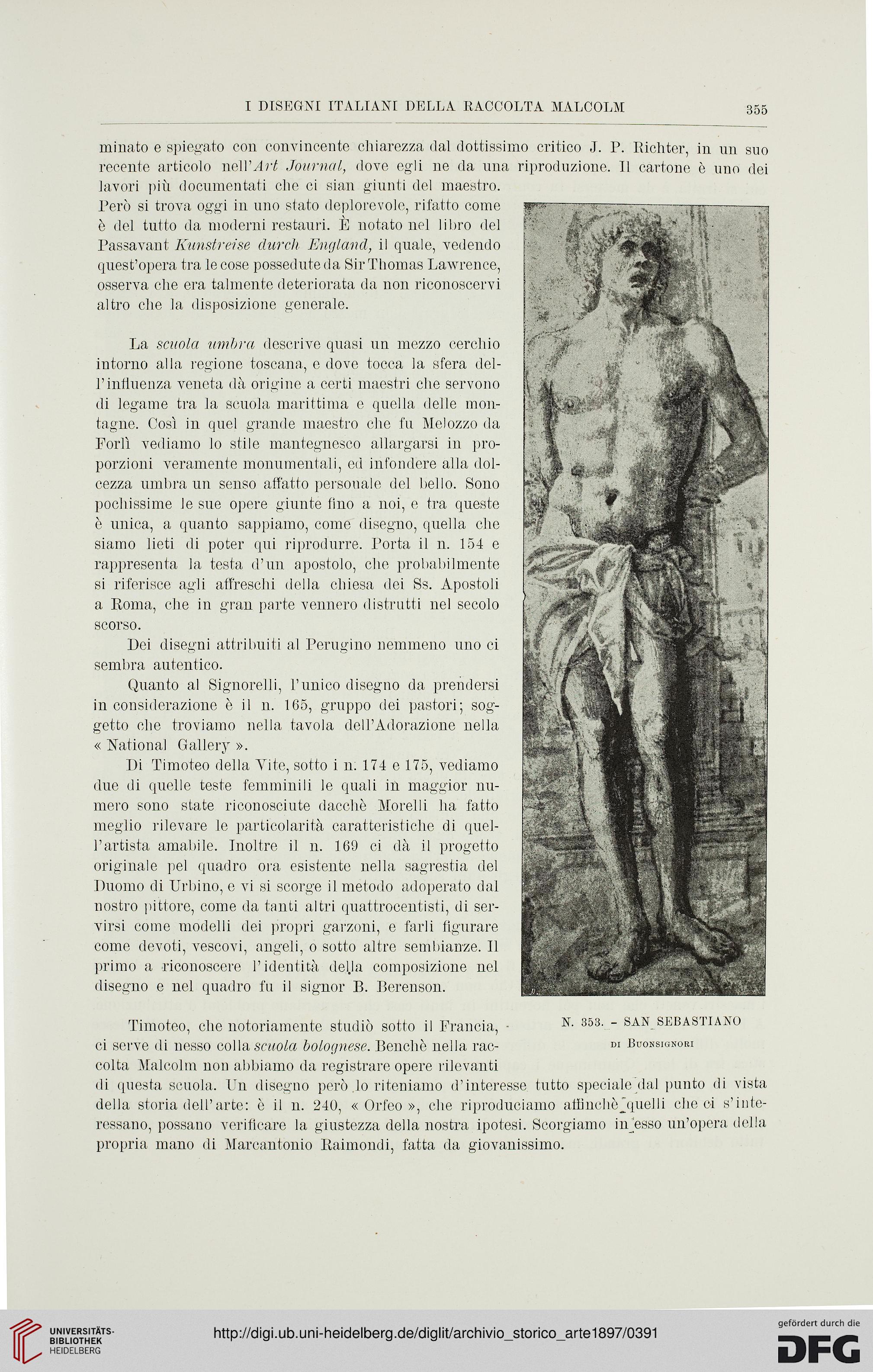I DISEGNI ITALIANI DELLA RACCOLTA MALCOLM
355
minato e spiegato con convincente chiarezza dal dottissimo critico J. P. Richter, in un suo
recente articolo nelV Art Journal, dove egli ne da una riproduzione. Il cartone è uno dei
lavori più documentati che ci sian giunti del maestro.
Però si trova oggi in uno stato deplorevole, rifatto come
è del tutto da moderni restauri. È notato nel libro del
Passavant Kunstreise durch England, il quale, vedendo
quest'opera tra le cose possedute da Sir Thomas Lawrence,
osserva che era talmente deteriorata da non riconoscervi
altro che la disposizione generale.
La scuola umbra descrive quasi un mezzo cerchio
intorno alla regione toscana, e dove tocca la sfera del-
l'influenza veneta dà origine a certi maestri che servono
di legame tra la scuola marittima e quella delle mon-
tagne. Così in quel grande maestro che fu Melozzo da
Forlì vediamo lo stile mantegnesco allargarsi in pro-
porzioni veramente monumentali, ed infondere alla dol-
cezza umbra un senso affatto personale del bello. Sono
pochissime le sue opere giunte fino a noi, e tra queste
è unica, a quanto sappiamo, come disegno, quella che
siamo lieti di poter qui riprodurre. Porta il n. 154 e
rappresenta la testa d'un apostolo, che probabilmente
si riferisce agli affreschi della chiesa dei Ss. Apostoli
a Roma, che in gran parte vennero distrutti nel secolo
scorso.
Dei disegni attribuiti al Perugino nemmeno uno ci
sembra autentico.
Quanto al Signore]!i, l'unico disegno da prendersi
inconsiderazione è il n. 165, gruppo dei pastori; sog-
getto che troviamo nella tavola dell'Adorazione nella
« National Gallerv ».
Di Timoteo della Yite, sotto i n. 174 e 175, vediamo
due di quelle teste femminili le quali in maggior nu-
mero sono state riconosciute dacché Morelli ha fatto
meglio rilevare le particolarità caratteristiche di quel-
l'artista amabile. Inoltre il n. 169 ci dà il progetto
originale pel quadro ora esistente nella sagrestia del
Duomo di Urbino, e vi si scorge il metodo adoperato dal
nostro pittore, come da tanti altri quattrocentisti, di ser-
virsi come modelli dei propri garzoni, e farli figurare
come devoti, vescovi, angeli, o sotto altre sembianze. Il
primo a riconoscere l'identità del.la composizione nel
disegno e nel quadro fu il signor B. Berenson.
Timoteo, che notoriamente studiò sotto il Francia, - n- 35b- ~ san Sebastiano
ci serve di nesso collii scuola bolognese. Benché nella rac- DI Buomighom
colta Malcolm non abbiamo da registrare opere rilevanti
di questa scuola. Un disegno però lo riteniamo d'interesse tutto speciale dal punto di vista
della storia dell'arte: é il n. 240, «Orfeo», che riproduciamo affinchè'quelli che ci s'inte-
ressano, possano verificare la giustezza della nostra ipotesi. Scorgiamo in esso un'opera della
propria mano di Marcantonio Raimondi, fatta da giovanissimo.
355
minato e spiegato con convincente chiarezza dal dottissimo critico J. P. Richter, in un suo
recente articolo nelV Art Journal, dove egli ne da una riproduzione. Il cartone è uno dei
lavori più documentati che ci sian giunti del maestro.
Però si trova oggi in uno stato deplorevole, rifatto come
è del tutto da moderni restauri. È notato nel libro del
Passavant Kunstreise durch England, il quale, vedendo
quest'opera tra le cose possedute da Sir Thomas Lawrence,
osserva che era talmente deteriorata da non riconoscervi
altro che la disposizione generale.
La scuola umbra descrive quasi un mezzo cerchio
intorno alla regione toscana, e dove tocca la sfera del-
l'influenza veneta dà origine a certi maestri che servono
di legame tra la scuola marittima e quella delle mon-
tagne. Così in quel grande maestro che fu Melozzo da
Forlì vediamo lo stile mantegnesco allargarsi in pro-
porzioni veramente monumentali, ed infondere alla dol-
cezza umbra un senso affatto personale del bello. Sono
pochissime le sue opere giunte fino a noi, e tra queste
è unica, a quanto sappiamo, come disegno, quella che
siamo lieti di poter qui riprodurre. Porta il n. 154 e
rappresenta la testa d'un apostolo, che probabilmente
si riferisce agli affreschi della chiesa dei Ss. Apostoli
a Roma, che in gran parte vennero distrutti nel secolo
scorso.
Dei disegni attribuiti al Perugino nemmeno uno ci
sembra autentico.
Quanto al Signore]!i, l'unico disegno da prendersi
inconsiderazione è il n. 165, gruppo dei pastori; sog-
getto che troviamo nella tavola dell'Adorazione nella
« National Gallerv ».
Di Timoteo della Yite, sotto i n. 174 e 175, vediamo
due di quelle teste femminili le quali in maggior nu-
mero sono state riconosciute dacché Morelli ha fatto
meglio rilevare le particolarità caratteristiche di quel-
l'artista amabile. Inoltre il n. 169 ci dà il progetto
originale pel quadro ora esistente nella sagrestia del
Duomo di Urbino, e vi si scorge il metodo adoperato dal
nostro pittore, come da tanti altri quattrocentisti, di ser-
virsi come modelli dei propri garzoni, e farli figurare
come devoti, vescovi, angeli, o sotto altre sembianze. Il
primo a riconoscere l'identità del.la composizione nel
disegno e nel quadro fu il signor B. Berenson.
Timoteo, che notoriamente studiò sotto il Francia, - n- 35b- ~ san Sebastiano
ci serve di nesso collii scuola bolognese. Benché nella rac- DI Buomighom
colta Malcolm non abbiamo da registrare opere rilevanti
di questa scuola. Un disegno però lo riteniamo d'interesse tutto speciale dal punto di vista
della storia dell'arte: é il n. 240, «Orfeo», che riproduciamo affinchè'quelli che ci s'inte-
ressano, possano verificare la giustezza della nostra ipotesi. Scorgiamo in esso un'opera della
propria mano di Marcantonio Raimondi, fatta da giovanissimo.