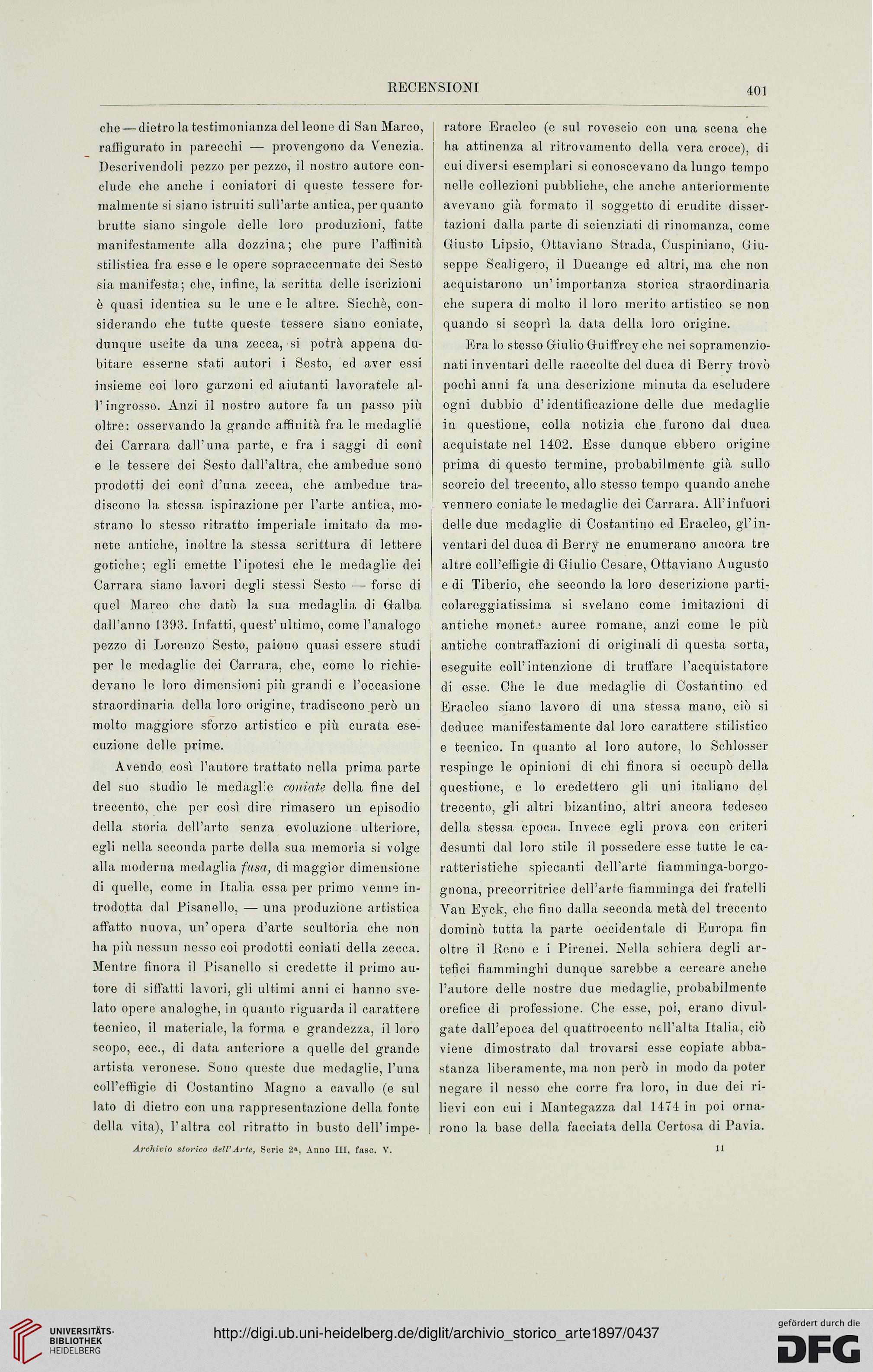RECENSIONI
401
che — dietro la testimonianza del leone di San Marco,
raffigurato in parecchi — provengono da Venezia.
Descrivendoli pezzo per pezzo, il nostro autore con-
clude che anche i coniatori di queste tessere for-
malmente si siano istruiti sull'arte antica, per quanto
brutte siano singole delle loro produzioni, fatte
manifestamente alla dozzina; che pure l'affinità
stilistica fra esse e le opere sopraccennate dei Sesto
sia manifesta; che, infine, la scritta delle iscrizioni
ò quasi identica su le une e le altre. Sicché, con-
siderando che tutte queste tessere siano coniate,
dunque uscite da una zecca, si potrà appena du-
bitare esserne stati autori i Sesto, ed aver essi
insieme coi loro garzoni ed aiutanti lavoratele al-
l'ingrosso. Anzi il nostro autore fa un passo più
oltre: osservando la grande affinità fra le medaglie
dei Carrara dall'una parte, e fra i saggi di coni
e le tessere dei Sesto dall'altra, che ambedue sono
prodotti dei coni d'una zecca, che ambedue tra-
discono la stessa ispirazione per l'arte antica, mo-
strano lo stesso ritratto imperiale imitato da mo-
nete antiche, inoltre la stessa scrittura di lettere
gotiche; egli emette l'ipotesi che le medaglie dei
Carrara siano lavori degli stessi Sesto — forse di
quel Marco che datò la sua medaglia di Galba
dall'anno 1393. Infatti, quest'ultimo, come l'analogo
pezzo di Lorenzo Sesto, paiono quasi essere studi
per le medaglie dei Carrara, che, come lo richie-
devano le loro dimensioni più grandi e l'occasione
straordinaria della loro origine, tradiscono però un
molto maggiore sforzo artistico e più curata ese-
cuzione delle prime.
Avendo così l'autore trattato nella prima parte
del suo studio le medaglie coniate della fine del
trecento, che per cosi dire rimasero un episodio
della storia dell'arte senza evoluzione ulteriore,
egli nella seconda parte della sua memoria si volge
alla moderna medaglia fusa, di maggior dimensione
di quelle, come in Italia essa per primo venne in-
trodotta dal Pisanello, — una produzione artistica
affatto nuova, un'opera d'arte scultoria che non
ha più nessun nesso coi prodotti coniati della zecca.
Mentre finora il Pisanello si credette il primo au-
tore di siffatti lavori, gli ultimi anni ci hanno sve-
lato opere analoghe, in quanto riguarda il carattere
tecnico, il materiale, la forma e grandezza, il loro
scopo, ecc., di data anteriore a quelle del grande
artista veronese. Sono queste due medaglie, l'una
coll'effigie di Costantino Magno a cavallo (e sul
lato di dietro con una rappresentazione della fonte
della vita), l'altra col ritratto in busto dell'impe-
Archivio storico dell'Afte, Serie 2», Anno III, fase. V.
ratore Eracleo (e sul rovescio con una scena che
ha attinenza al ritrovamento della vera croce), di
cui diversi esemplari si conoscevano da lungo tempo
nelle collezioni pubbliche, che anche anteriormente
avevano già formato il soggetto di erudite disser-
tazioni dalla parte di scienziati di rinomanza, come
Giusto Lipsie, Ottaviano Strada, Cuspiniano, Giu-
seppe Scaligero, il Ducange ed altri, ma che non
acquistarono un'importanza storica straordinaria
che supera di molto il loro merito artistico se non
quando si scoprì la data della loro origine.
Era lo stesso Giulio Guiffrey che nei sopramenzio-
nati inventari delle raccolte del duca di Berry trovò
pochi anni fa una descrizione minuta da escludere
ogni dubbio d'identificazione delle due medaglie
in questione, colla notizia che furono dal duca
acquistate nel 1402. Esse dunque ebbero origine
prima di questo termine, probabilmente già sullo
scorcio del trecento, allo stesso tempo quando anche
vennero coniate le medaglie dei Carrara. All'infuori
delle due medaglie di Costantino ed Eracleo, gl'in-
ventari del duca di Berry ne enumerano ancora tre
altre coll'effigie di Giulio Cesare, Ottaviano Augusto
e di Tiberio, che secondo la loro descrizione parti-
colareggiatissima si svelano come imitazioni di
antiche monet3 auree romane, anzi come le più
antiche contraffazioni di originali di questa sorta,
eseguite coli'intenzione di truffare l'acquistatore
di esse. Che le due medaglie di Costantino ed
Eracleo siano lavoro di una stessa mano, ciò si
deduce manifestamente dal loro carattere stilistico
e tecnico. In quanto al loro autore, lo Schlosser
respinge le opinioni di chi finora si occupò della
questione, e lo credettero gli uni italiano del
trecento, gli altri bizantino, altri ancora tedesco
della stessa epoca. Invece egli prova con criteri
desunti dal loro stile il possedere esse tutte le ca-
ratteristiche spiccanti dell'arte fiamminga-borgo-
gnona, precorritrice dell'arte fiamminga dei fratelli
Van Eyck, che fino dalla seconda metà del trecento
dominò tutta la parte occidentale di Europa fin
oltre il Reno e i Pirenei. Nella schiera degli ar-
tefici fiamminghi dunque sarebbe a cercare anche
l'autore delle nostre due medaglie, probabilmente
orefice di professione. Che esse, poi, erano divul-
gate dall'epoca del quattrocento nell'alta Italia, ciò
viene dimostrato dal trovarsi esse copiate abba-
stanza liberamente, ma non però in modo da poter
negare il nesso che corre fra loro, in due dei ri-
lievi con cui i Mantegazza dal 1474 in poi orna-
rono la base della facciata della Certosa di Pavia.
n
401
che — dietro la testimonianza del leone di San Marco,
raffigurato in parecchi — provengono da Venezia.
Descrivendoli pezzo per pezzo, il nostro autore con-
clude che anche i coniatori di queste tessere for-
malmente si siano istruiti sull'arte antica, per quanto
brutte siano singole delle loro produzioni, fatte
manifestamente alla dozzina; che pure l'affinità
stilistica fra esse e le opere sopraccennate dei Sesto
sia manifesta; che, infine, la scritta delle iscrizioni
ò quasi identica su le une e le altre. Sicché, con-
siderando che tutte queste tessere siano coniate,
dunque uscite da una zecca, si potrà appena du-
bitare esserne stati autori i Sesto, ed aver essi
insieme coi loro garzoni ed aiutanti lavoratele al-
l'ingrosso. Anzi il nostro autore fa un passo più
oltre: osservando la grande affinità fra le medaglie
dei Carrara dall'una parte, e fra i saggi di coni
e le tessere dei Sesto dall'altra, che ambedue sono
prodotti dei coni d'una zecca, che ambedue tra-
discono la stessa ispirazione per l'arte antica, mo-
strano lo stesso ritratto imperiale imitato da mo-
nete antiche, inoltre la stessa scrittura di lettere
gotiche; egli emette l'ipotesi che le medaglie dei
Carrara siano lavori degli stessi Sesto — forse di
quel Marco che datò la sua medaglia di Galba
dall'anno 1393. Infatti, quest'ultimo, come l'analogo
pezzo di Lorenzo Sesto, paiono quasi essere studi
per le medaglie dei Carrara, che, come lo richie-
devano le loro dimensioni più grandi e l'occasione
straordinaria della loro origine, tradiscono però un
molto maggiore sforzo artistico e più curata ese-
cuzione delle prime.
Avendo così l'autore trattato nella prima parte
del suo studio le medaglie coniate della fine del
trecento, che per cosi dire rimasero un episodio
della storia dell'arte senza evoluzione ulteriore,
egli nella seconda parte della sua memoria si volge
alla moderna medaglia fusa, di maggior dimensione
di quelle, come in Italia essa per primo venne in-
trodotta dal Pisanello, — una produzione artistica
affatto nuova, un'opera d'arte scultoria che non
ha più nessun nesso coi prodotti coniati della zecca.
Mentre finora il Pisanello si credette il primo au-
tore di siffatti lavori, gli ultimi anni ci hanno sve-
lato opere analoghe, in quanto riguarda il carattere
tecnico, il materiale, la forma e grandezza, il loro
scopo, ecc., di data anteriore a quelle del grande
artista veronese. Sono queste due medaglie, l'una
coll'effigie di Costantino Magno a cavallo (e sul
lato di dietro con una rappresentazione della fonte
della vita), l'altra col ritratto in busto dell'impe-
Archivio storico dell'Afte, Serie 2», Anno III, fase. V.
ratore Eracleo (e sul rovescio con una scena che
ha attinenza al ritrovamento della vera croce), di
cui diversi esemplari si conoscevano da lungo tempo
nelle collezioni pubbliche, che anche anteriormente
avevano già formato il soggetto di erudite disser-
tazioni dalla parte di scienziati di rinomanza, come
Giusto Lipsie, Ottaviano Strada, Cuspiniano, Giu-
seppe Scaligero, il Ducange ed altri, ma che non
acquistarono un'importanza storica straordinaria
che supera di molto il loro merito artistico se non
quando si scoprì la data della loro origine.
Era lo stesso Giulio Guiffrey che nei sopramenzio-
nati inventari delle raccolte del duca di Berry trovò
pochi anni fa una descrizione minuta da escludere
ogni dubbio d'identificazione delle due medaglie
in questione, colla notizia che furono dal duca
acquistate nel 1402. Esse dunque ebbero origine
prima di questo termine, probabilmente già sullo
scorcio del trecento, allo stesso tempo quando anche
vennero coniate le medaglie dei Carrara. All'infuori
delle due medaglie di Costantino ed Eracleo, gl'in-
ventari del duca di Berry ne enumerano ancora tre
altre coll'effigie di Giulio Cesare, Ottaviano Augusto
e di Tiberio, che secondo la loro descrizione parti-
colareggiatissima si svelano come imitazioni di
antiche monet3 auree romane, anzi come le più
antiche contraffazioni di originali di questa sorta,
eseguite coli'intenzione di truffare l'acquistatore
di esse. Che le due medaglie di Costantino ed
Eracleo siano lavoro di una stessa mano, ciò si
deduce manifestamente dal loro carattere stilistico
e tecnico. In quanto al loro autore, lo Schlosser
respinge le opinioni di chi finora si occupò della
questione, e lo credettero gli uni italiano del
trecento, gli altri bizantino, altri ancora tedesco
della stessa epoca. Invece egli prova con criteri
desunti dal loro stile il possedere esse tutte le ca-
ratteristiche spiccanti dell'arte fiamminga-borgo-
gnona, precorritrice dell'arte fiamminga dei fratelli
Van Eyck, che fino dalla seconda metà del trecento
dominò tutta la parte occidentale di Europa fin
oltre il Reno e i Pirenei. Nella schiera degli ar-
tefici fiamminghi dunque sarebbe a cercare anche
l'autore delle nostre due medaglie, probabilmente
orefice di professione. Che esse, poi, erano divul-
gate dall'epoca del quattrocento nell'alta Italia, ciò
viene dimostrato dal trovarsi esse copiate abba-
stanza liberamente, ma non però in modo da poter
negare il nesso che corre fra loro, in due dei ri-
lievi con cui i Mantegazza dal 1474 in poi orna-
rono la base della facciata della Certosa di Pavia.
n