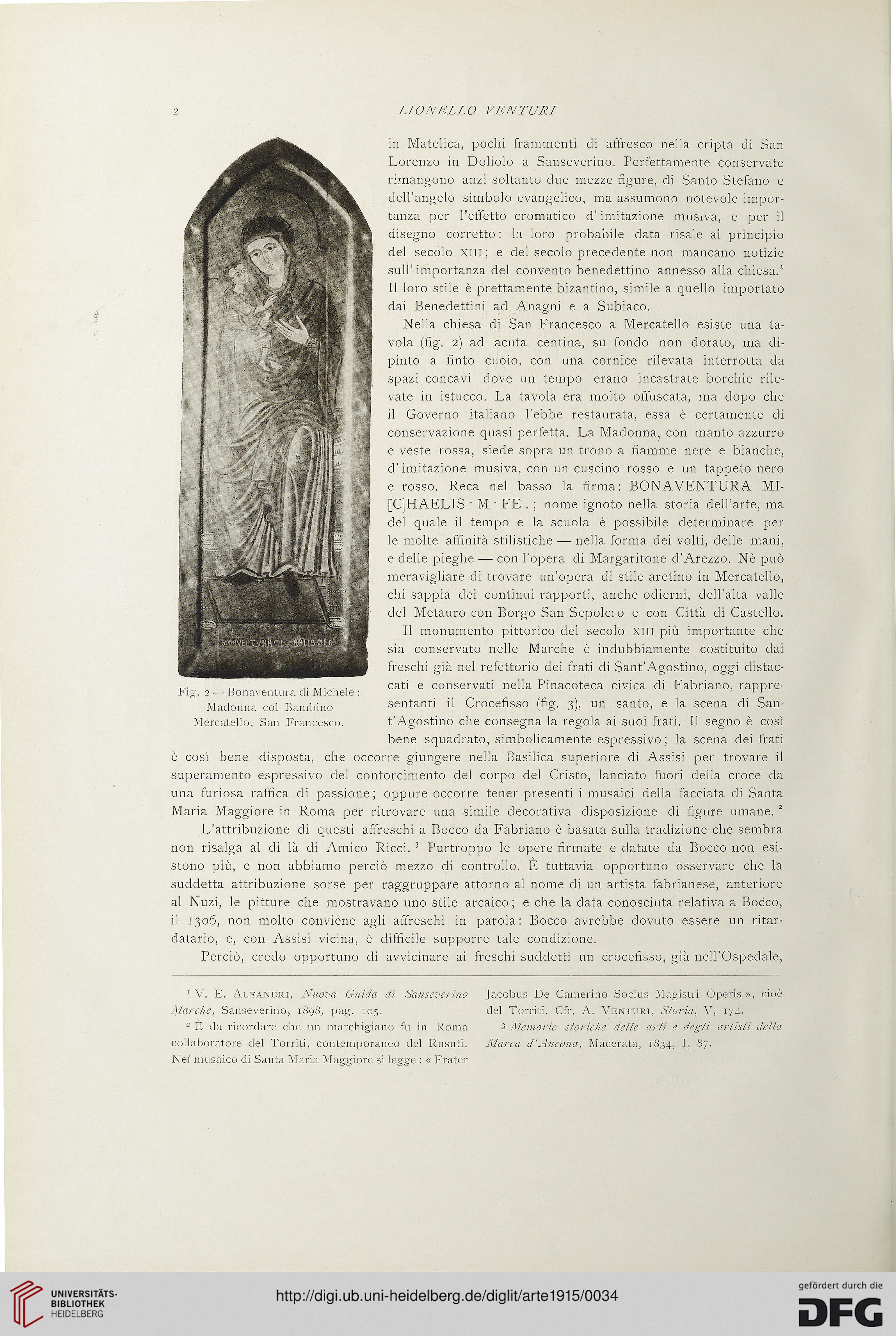LIONELLO VENTURO
2
in Matelica, pochi frammenti di affresco nella cripta di San
Lorenzo in Doliolo a Sanseverino. Perfettamente conservate
rimangono anzi soltanto due mezze figure, di Santo Stefano e
dell’angelo simbolo evangelico, ma assumono notevole impor-
tanza per l’efifetto cromatico d’imitazione musiva, e per il
disegno corretto : la loro probabile data risale al principio
del secolo XIII ; e del secolo precedente non mancano notizie
sull’importanza del convento benedettino annesso alla chiesa.1
Il loro stile è prettamente bizantino, simile a quello importato
dai Benedettini ad Anagni e a Subiaco.
Nella chiesa di San Francesco a Mercatello esiste una ta-
vola (fig. 2) ad acuta centina, su fondo non dorato, ma di-
pinto a finto cuoio, con una cornice rilevata interrotta da
spazi concavi dove un tempo erano incastrate borchie rile-
vate in istucco. La tavola era molto offuscata, ma dopo che
il Governo italiano l’ebbe restaurata, essa è certamente di
conservazione quasi perfetta. La Madonna, con manto azzurro
e veste rossa, siede sopra un trono a fiamme nere e bianche,
d’imitazione musiva, con un cuscino rosso e un tappeto nero
e rosso. Reca nel basso la firma: BONAVENTURA MI-
[C]HAELIS - M • FE . ; nome ignoto nella storia dell’arte, ma
del quale il tempo e la scuola è possibile determinare pel-
le molte affinità stilistiche — nella forma dei volti, delle mani,
e delle pieghe — con l’opera di Margaritone d’Arezzo. Nè può
meravigliare di trovare un’opera di stile aretino in Mercatello,
chi sappia dei continui rapporti, anche odierni, dell’alta valle
del Metauro con Borgo San Sepolcio e con Città di Castello.
Il monumento pittorico del secolo XIII più importante che
sia conservato nelle Marche è indubbiamente costituito dai
freschi già nel refettorio dei frati di Sant’Agostino, oggi distac-
cati e conservati nella Pinacoteca civica di Fabriano, rappre-
sentanti il Crocefisso (fig. 3), un santo, e la scena di San-
t’Agostino che consegna la regola ai suoi frati. Il segno è così
bene squadrato, simbolicamente espressivo; la scena dei frati
è così bene disposta, che occorre giungere nella Basilica superiore di Assisi per trovare il
superamento espressivo del contorcimento del corpo del Cristo, lanciato fuori della croce da
una furiosa raffica di passione; oppure occorre tener presenti i musaici della facciata di Santa
Maria Maggiore in Roma per ritrovare una simile decorativa disposizione di figure umane. 2
L’attribuzione di questi affreschi a Bocco da Fabriano è basata sulla tradizione che sembra
non risalga al di là di Amico Ricci. 3 Purtroppo le opere firmate e datate da Bocco non esi-
stono più, e non abbiamo perciò mezzo di controllo. E tuttavia opportuno osservare che la
suddetta attribuzione sorse per raggruppare attorno al nome di un artista fabrianese, anteriore
al Nuzi, le pitture che mostravano uno stile arcaico; e che la data conosciuta relativa a Bocco,
il 1306, non molto conviene agli affreschi in parola: Bocco avrebbe dovuto essere un ritar-
datario, e, con Assisi vicina, è difficile supporre tale condizione.
Perciò, credo opportuno di avvicinare ai freschi suddetti un crocefisso, già nell’Ospedale,
Fig-. 2 — Bonaventura di Michele
Madonna col Bambino
Mercatello, San Francesco.
1 V. E. Aleandri, Nuova Guida di Sanseverino
Marche, Sanseverino, 1898, pag. 105.
2 E da ricordare che un marchigiano fu in Roma
collaboratore del Torriti, contemporaneo del Rusuti.
Nel musaico di Santa Maria Maggiore si legge : « Frater
Jacobus De Camerino Socius Magistri Operis », cioè
del Torriti. Cfr. A. Venturi, Storia, V, 174.
3 Memorie storiche delle arti e degli artisti della
Marca d’Ancona, Macerata, 1834, I, S7.
2
in Matelica, pochi frammenti di affresco nella cripta di San
Lorenzo in Doliolo a Sanseverino. Perfettamente conservate
rimangono anzi soltanto due mezze figure, di Santo Stefano e
dell’angelo simbolo evangelico, ma assumono notevole impor-
tanza per l’efifetto cromatico d’imitazione musiva, e per il
disegno corretto : la loro probabile data risale al principio
del secolo XIII ; e del secolo precedente non mancano notizie
sull’importanza del convento benedettino annesso alla chiesa.1
Il loro stile è prettamente bizantino, simile a quello importato
dai Benedettini ad Anagni e a Subiaco.
Nella chiesa di San Francesco a Mercatello esiste una ta-
vola (fig. 2) ad acuta centina, su fondo non dorato, ma di-
pinto a finto cuoio, con una cornice rilevata interrotta da
spazi concavi dove un tempo erano incastrate borchie rile-
vate in istucco. La tavola era molto offuscata, ma dopo che
il Governo italiano l’ebbe restaurata, essa è certamente di
conservazione quasi perfetta. La Madonna, con manto azzurro
e veste rossa, siede sopra un trono a fiamme nere e bianche,
d’imitazione musiva, con un cuscino rosso e un tappeto nero
e rosso. Reca nel basso la firma: BONAVENTURA MI-
[C]HAELIS - M • FE . ; nome ignoto nella storia dell’arte, ma
del quale il tempo e la scuola è possibile determinare pel-
le molte affinità stilistiche — nella forma dei volti, delle mani,
e delle pieghe — con l’opera di Margaritone d’Arezzo. Nè può
meravigliare di trovare un’opera di stile aretino in Mercatello,
chi sappia dei continui rapporti, anche odierni, dell’alta valle
del Metauro con Borgo San Sepolcio e con Città di Castello.
Il monumento pittorico del secolo XIII più importante che
sia conservato nelle Marche è indubbiamente costituito dai
freschi già nel refettorio dei frati di Sant’Agostino, oggi distac-
cati e conservati nella Pinacoteca civica di Fabriano, rappre-
sentanti il Crocefisso (fig. 3), un santo, e la scena di San-
t’Agostino che consegna la regola ai suoi frati. Il segno è così
bene squadrato, simbolicamente espressivo; la scena dei frati
è così bene disposta, che occorre giungere nella Basilica superiore di Assisi per trovare il
superamento espressivo del contorcimento del corpo del Cristo, lanciato fuori della croce da
una furiosa raffica di passione; oppure occorre tener presenti i musaici della facciata di Santa
Maria Maggiore in Roma per ritrovare una simile decorativa disposizione di figure umane. 2
L’attribuzione di questi affreschi a Bocco da Fabriano è basata sulla tradizione che sembra
non risalga al di là di Amico Ricci. 3 Purtroppo le opere firmate e datate da Bocco non esi-
stono più, e non abbiamo perciò mezzo di controllo. E tuttavia opportuno osservare che la
suddetta attribuzione sorse per raggruppare attorno al nome di un artista fabrianese, anteriore
al Nuzi, le pitture che mostravano uno stile arcaico; e che la data conosciuta relativa a Bocco,
il 1306, non molto conviene agli affreschi in parola: Bocco avrebbe dovuto essere un ritar-
datario, e, con Assisi vicina, è difficile supporre tale condizione.
Perciò, credo opportuno di avvicinare ai freschi suddetti un crocefisso, già nell’Ospedale,
Fig-. 2 — Bonaventura di Michele
Madonna col Bambino
Mercatello, San Francesco.
1 V. E. Aleandri, Nuova Guida di Sanseverino
Marche, Sanseverino, 1898, pag. 105.
2 E da ricordare che un marchigiano fu in Roma
collaboratore del Torriti, contemporaneo del Rusuti.
Nel musaico di Santa Maria Maggiore si legge : « Frater
Jacobus De Camerino Socius Magistri Operis », cioè
del Torriti. Cfr. A. Venturi, Storia, V, 174.
3 Memorie storiche delle arti e degli artisti della
Marca d’Ancona, Macerata, 1834, I, S7.