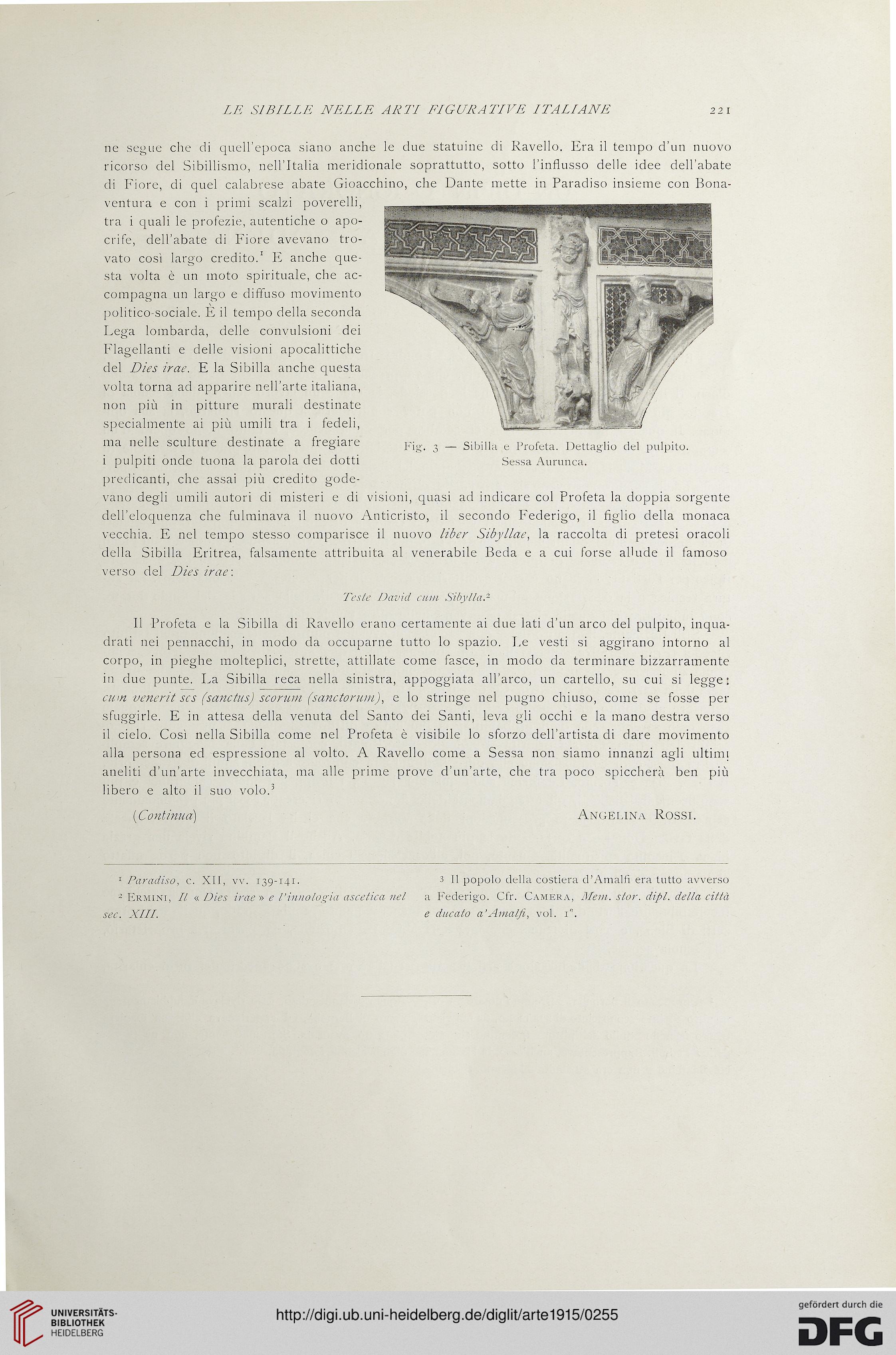LE SIBILLE NELLE ARTI FIGURATIVE ITALIANE
2 2 I
ne segue che di quell’epoca siano anche le due statuine di Ravello. Era il tempo d’un nuovo
ricorso del Sibillismo, nell’Italia meridionale soprattutto, sotto l’influsso delle idee dell’abate
di Fiore, di quel calabrese abate Gioacchino, che Dante mette in Paradiso insieme con Bona-
ventura e con i primi scalzi poverelli,
predicanti, che assai più credito gode-
vano degli umili autori di misteri e di visioni, quasi ad indicare col Profeta la doppia sorgente
dell’eloquenza che fulminava il nuovo Anticristo, il secondo Federigo, il figlio della monaca
vecchia. E nel tempo stesso comparisce il nuovo liber Sibyllae, la raccolta di pretesi oracoli
della Sibilla Eritrea, falsamente attribuita al venerabile Beda e a cui forse allude il famoso
verso del Dies irae\
Il Profeta e la Sibilla di Ravello erano certamente ai due lati d’un arco del pulpito, inqua-
drati nei pennacchi, in modo da occuparne tutto lo spazio. Le vesti si aggirano intorno al
corpo, in pieghe molteplici, strette, attillate come fasce, in modo da terminare bizzarramente
in due punte. Ea Sibilla reca nella sinistra, appoggiata all’arco, un cartello, su cui si legge:
cum venerit scs (sanctus) scorum (sanctorum), e lo stringe nel pugno chiuso, come se fosse per
sfuggirle. E in attesa della venuta del Santo dei Santi, leva gii occhi e la mano destra verso
il cielo. Così nella Sibilla come nel Profeta è visibile lo sforzo dell’artista di dare movimento
alla persona ed espressione al volto. A Ravello come a Sessa non siamo innanzi agli ultimi
aneliti d’un’arte invecchiata, ma alle prime prove d’un’arte, che tra poco spiccherà ben più
libero e alto il suo volo.3
(Continua) Angelina ROSSI.
1 Paradiso, c. XII, vv. 139-141. 3 II popolo della costiera d’Amalfi era tutto avverso
2 Ermini, Il « Dies irae » e l’innologià ascetica nel a Federigo. Cfr. Camera, Meni. stor. dipi, della città
sec. XIII. e ducato a’Amalfi, voi. i°.
tra i quali le profezie, autentiche o apo-
crife, dell’abate di Fiore avevano tro-
vato così largo credito.1 E anche que-
sta volta è un moto spirituale, che ac-
compagna un largo e diffuso movimento
politico-sociale. E il tempo della seconda
Lega lombarda, delle convulsioni dei
Flagellanti e delle visioni apocalittiche
del Dies irae. E la Sibilla anche questa
volta torna ad apparire nell’arte italiana,
non più in pitture murali destinate
specialmente ai più umili tra i fedeli,
ma nelle sculture destinate a fregiare
i pulpiti onde tuona la parola dei dotti
Fig'. 3 — Sibilla e Profeta. Dettaglio del pulpito.
Sessa Aurunca.
Teste David cum Sibylla.2
2 2 I
ne segue che di quell’epoca siano anche le due statuine di Ravello. Era il tempo d’un nuovo
ricorso del Sibillismo, nell’Italia meridionale soprattutto, sotto l’influsso delle idee dell’abate
di Fiore, di quel calabrese abate Gioacchino, che Dante mette in Paradiso insieme con Bona-
ventura e con i primi scalzi poverelli,
predicanti, che assai più credito gode-
vano degli umili autori di misteri e di visioni, quasi ad indicare col Profeta la doppia sorgente
dell’eloquenza che fulminava il nuovo Anticristo, il secondo Federigo, il figlio della monaca
vecchia. E nel tempo stesso comparisce il nuovo liber Sibyllae, la raccolta di pretesi oracoli
della Sibilla Eritrea, falsamente attribuita al venerabile Beda e a cui forse allude il famoso
verso del Dies irae\
Il Profeta e la Sibilla di Ravello erano certamente ai due lati d’un arco del pulpito, inqua-
drati nei pennacchi, in modo da occuparne tutto lo spazio. Le vesti si aggirano intorno al
corpo, in pieghe molteplici, strette, attillate come fasce, in modo da terminare bizzarramente
in due punte. Ea Sibilla reca nella sinistra, appoggiata all’arco, un cartello, su cui si legge:
cum venerit scs (sanctus) scorum (sanctorum), e lo stringe nel pugno chiuso, come se fosse per
sfuggirle. E in attesa della venuta del Santo dei Santi, leva gii occhi e la mano destra verso
il cielo. Così nella Sibilla come nel Profeta è visibile lo sforzo dell’artista di dare movimento
alla persona ed espressione al volto. A Ravello come a Sessa non siamo innanzi agli ultimi
aneliti d’un’arte invecchiata, ma alle prime prove d’un’arte, che tra poco spiccherà ben più
libero e alto il suo volo.3
(Continua) Angelina ROSSI.
1 Paradiso, c. XII, vv. 139-141. 3 II popolo della costiera d’Amalfi era tutto avverso
2 Ermini, Il « Dies irae » e l’innologià ascetica nel a Federigo. Cfr. Camera, Meni. stor. dipi, della città
sec. XIII. e ducato a’Amalfi, voi. i°.
tra i quali le profezie, autentiche o apo-
crife, dell’abate di Fiore avevano tro-
vato così largo credito.1 E anche que-
sta volta è un moto spirituale, che ac-
compagna un largo e diffuso movimento
politico-sociale. E il tempo della seconda
Lega lombarda, delle convulsioni dei
Flagellanti e delle visioni apocalittiche
del Dies irae. E la Sibilla anche questa
volta torna ad apparire nell’arte italiana,
non più in pitture murali destinate
specialmente ai più umili tra i fedeli,
ma nelle sculture destinate a fregiare
i pulpiti onde tuona la parola dei dotti
Fig'. 3 — Sibilla e Profeta. Dettaglio del pulpito.
Sessa Aurunca.
Teste David cum Sibylla.2