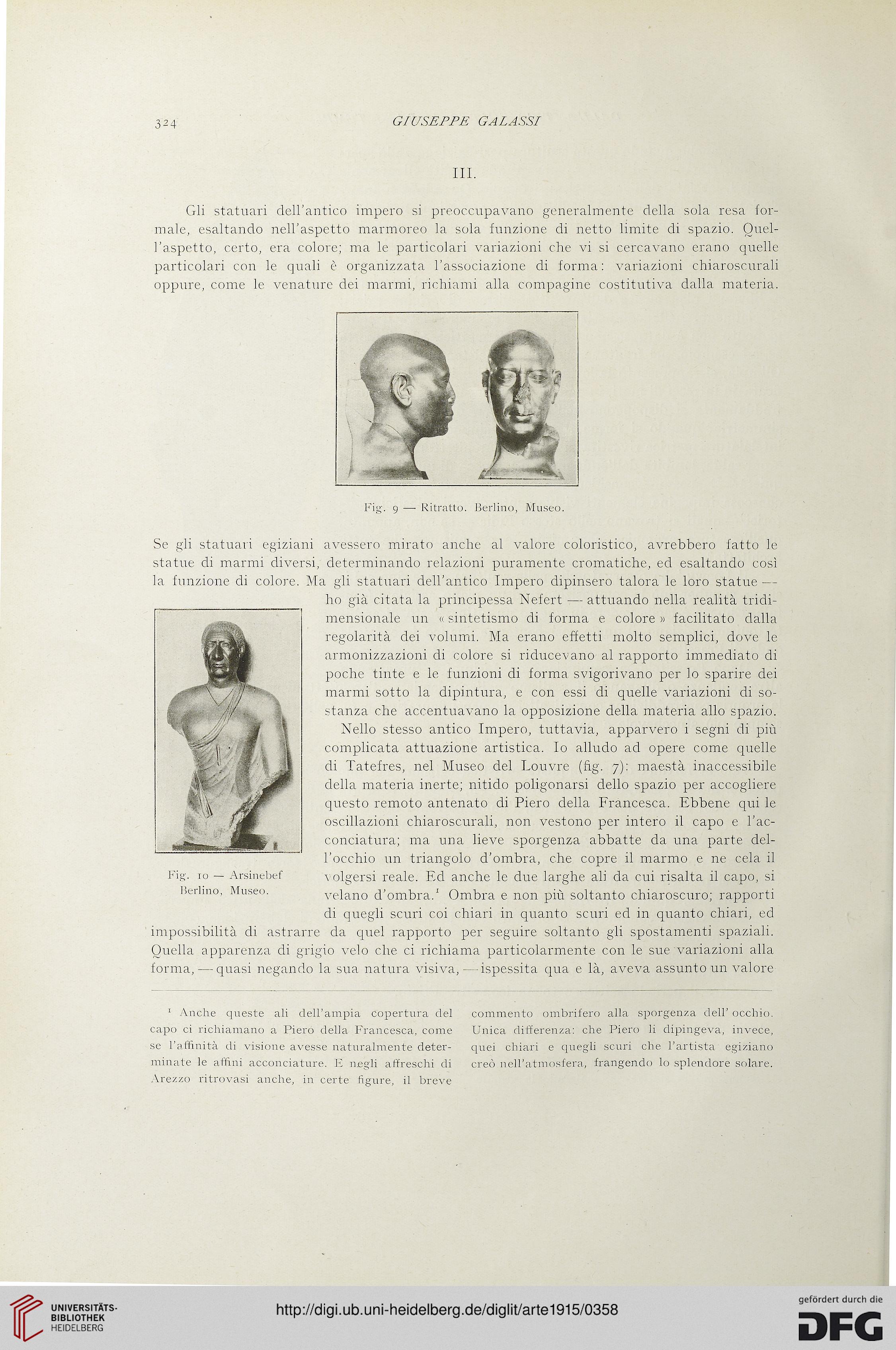324
GIUSEPPE GAZASSI
III.
Gli statuari dell’antico impero si preoccupavano generalmente della sola resa for-
ma®, esaltando nell’aspetto marmoreo la sola funzione di netto limite di spazio. Quel-
l’aspetto, certo, era colore; ma le particolari variazioni che vi si cercavano erano quelle
particolari con le quali è organizzata l’associazione di forma: variazioni chiaroscurali
oppure, come le venature dei marmi, richiami alla compagine costitutiva dalla materia.
Fig\ 9 — Ritratto. Berlino, Museo.
Se gli statuari egiziani avessero mirato anche al valore coloristico, avrebbero fatto le
statue di marmi diversi, determinando relazioni puramente cromatiche, ed esaltando così
la funzione di colore. Ma gli statuari dell’antico Impero dipinsero talora le loro statue —
ho già citata la principessa Nefert — attuando nella realità tridi-
mensionale un « sintetismo di forma e colore » facilitato dalla
regolarità dei volumi. Ma erano effetti molto semplici, dove le
armonizzazioni di colore si riducevano al rapporto immediato di
poche tinte e le funzioni di forma svigorivano per lo sparire dei
marmi sotto la dipintura, e con essi di quelle variazioni di so-
stanza che accentuavano la opposizione della materia allo spazio.
Nello stesso antico Impero, tuttavia, apparvero i segni di più
complicata attuazione artistica. Io alludo ad opere come quelle
di Tatefres, nel Museo del Louvre (fig. 7): maestà inaccessibile
della materia inerte; nitido poligonali dello spazio per accogliere
questo remoto antenato di Piero della Francesca. Ebbene qui le
oscillazioni chiaroscurali, non vestono per intero il capo e l’ac-
conciatura; ma una lieve sporgenza abbatte da una parte del-
l’occhio un triangolo d’ombra, che copre il marmo e ne cela il
volgersi reale. Ed anche le due larghe ali da cui risalta il capo, si
velano d’ombra.1 Ombra e non più soltanto chiaroscuro; rapporti
di quegli scuri coi chiari in quanto scuri ed in quanto chiari, ed
impossibilità di astrarre da quel rapporto per seguire soltanto gli spostamenti spaziali.
Quella apparenza di grigio velo che ci richiama particolarmente con le sue variazioni alla
forma, — quasi negando la sua natura visiva, —ispessita qua e là, aveva assunto un valore
1 Anche queste ali dell’ampia copertura del
capo ci richiamano a Piero della Francesca, come
se raffilità di visione avesse naturalmente deter-
minate le affini acconciature. E negli affreschi di
Arezzo ritrovasi anche, in certe figure, il breve
commento ombrifero alla sporgenza dell’ occhio.
Unica differenza: che Piero li dipingeva, invece,
quei chiari e quegli scuri che l’artista egiziano
creò nell’atmosfera, frangendo lo splendore solare.
GIUSEPPE GAZASSI
III.
Gli statuari dell’antico impero si preoccupavano generalmente della sola resa for-
ma®, esaltando nell’aspetto marmoreo la sola funzione di netto limite di spazio. Quel-
l’aspetto, certo, era colore; ma le particolari variazioni che vi si cercavano erano quelle
particolari con le quali è organizzata l’associazione di forma: variazioni chiaroscurali
oppure, come le venature dei marmi, richiami alla compagine costitutiva dalla materia.
Fig\ 9 — Ritratto. Berlino, Museo.
Se gli statuari egiziani avessero mirato anche al valore coloristico, avrebbero fatto le
statue di marmi diversi, determinando relazioni puramente cromatiche, ed esaltando così
la funzione di colore. Ma gli statuari dell’antico Impero dipinsero talora le loro statue —
ho già citata la principessa Nefert — attuando nella realità tridi-
mensionale un « sintetismo di forma e colore » facilitato dalla
regolarità dei volumi. Ma erano effetti molto semplici, dove le
armonizzazioni di colore si riducevano al rapporto immediato di
poche tinte e le funzioni di forma svigorivano per lo sparire dei
marmi sotto la dipintura, e con essi di quelle variazioni di so-
stanza che accentuavano la opposizione della materia allo spazio.
Nello stesso antico Impero, tuttavia, apparvero i segni di più
complicata attuazione artistica. Io alludo ad opere come quelle
di Tatefres, nel Museo del Louvre (fig. 7): maestà inaccessibile
della materia inerte; nitido poligonali dello spazio per accogliere
questo remoto antenato di Piero della Francesca. Ebbene qui le
oscillazioni chiaroscurali, non vestono per intero il capo e l’ac-
conciatura; ma una lieve sporgenza abbatte da una parte del-
l’occhio un triangolo d’ombra, che copre il marmo e ne cela il
volgersi reale. Ed anche le due larghe ali da cui risalta il capo, si
velano d’ombra.1 Ombra e non più soltanto chiaroscuro; rapporti
di quegli scuri coi chiari in quanto scuri ed in quanto chiari, ed
impossibilità di astrarre da quel rapporto per seguire soltanto gli spostamenti spaziali.
Quella apparenza di grigio velo che ci richiama particolarmente con le sue variazioni alla
forma, — quasi negando la sua natura visiva, —ispessita qua e là, aveva assunto un valore
1 Anche queste ali dell’ampia copertura del
capo ci richiamano a Piero della Francesca, come
se raffilità di visione avesse naturalmente deter-
minate le affini acconciature. E negli affreschi di
Arezzo ritrovasi anche, in certe figure, il breve
commento ombrifero alla sporgenza dell’ occhio.
Unica differenza: che Piero li dipingeva, invece,
quei chiari e quegli scuri che l’artista egiziano
creò nell’atmosfera, frangendo lo splendore solare.