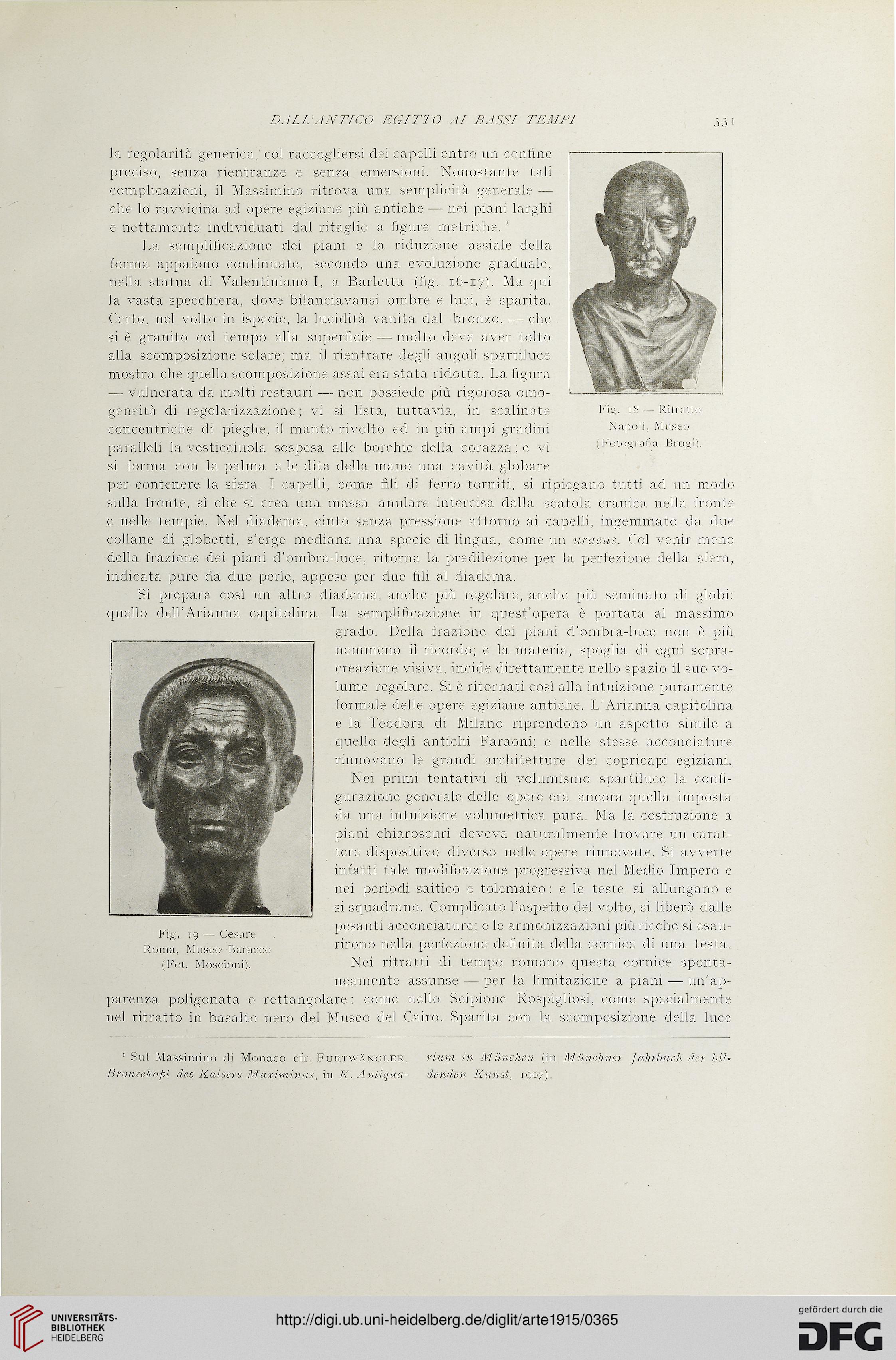DALL'ANTICO EGITTO AI BASSI TEMPI
la regolarità generica, col raccogliersi dei capelli entro un confine
preciso, senza rientranze e senza emersioni. Nonostante tali
complicazioni, il Massimino ritrova una semplicità generale -
che lo ravvicina ad opere egiziane più antiche — nei piani larghi
e nettamente individuati dal ritaglio a figure metriche. 1
La semplificazione dei piani e la riduzione assiale della
forma appaiono continuate, secondo una evoluzione graduale,
nella statua di Valentiniano I, a Barletta (fig. 16-17). qui
la vasta specchiera, dove bilanciavansi ombre e luci, è sparita.
Certo, nel volto in ispecie, la lucidità vanita dal bronzo, -— che
si è granito col tempo alla superficie — molto deve aver tolto
alla scomposizione solare; ma il rientrare degli angoli spartiiuce
mostra che quella scomposizione assai era stata ridotta. La figura
— vulnerata da molti restauri — non possiede più rigorosa omo-
geneità di regolarizzazione; vi si lista, tuttavia, in scalinate
concentriche di pieghe, il manto rivolto ed in più ampi gradini
paralleli la vesticciuola sospesa alle borchie della corazzale vi
si forma con la palma e le dita della mano una cavità globare
per contenere la sfera. I capelli, come fili di ferro torniti, si ripiegano tutti ad un modo
sulla fronte, sì che si crea una massa anulare intercisa dalla scatola cranica nella fronte
e nelle tempie. Nel diadema, cinto senza pressione attorno ai capelli, ingemmato da due
collane di globetti, s’erge mediana una specie di lingua, come un uraeus. Col venir meno
della frazione dei piani d’ombra-luce, ritorna la predilezione per la perfezione della sfera,
indicata pure da due perle, appese per due fili al diadema.
Si prepara così un altro diadema, anche più regolare, anche più seminato di globi:
quello dell’Arianna capitolina. La semplificazione in quest’opera è portata al massimo
grado. Della frazione dei piani d’ombra-luce non è più
nemmeno il ricordo; e la materia, spoglia di ogni sopra-
creazione visiva, incide direttamente nello spazio il suo vo-
lume regolare. Si è ritornati così alla intuizione puramente
formale delle opere egiziane antiche. L’Arianna capitolina
e la Teodora di Milano riprendono un aspetto simile a
quello degli antichi Faraoni; e nelle stesse acconciature
rinnovano le grandi architetture dei copricapi egiziani.
Nei primi tentativi di volumismo spartiluce la confi-
gurazione generale delle opere era ancora quella imposta
da una intuizione volumetrica pura. Ma la costruzione a
piani chiaroscuri doveva naturalmente trovare un carat-
tere dispositivo diverso nelle opere rinnovate. Si avverte
infatti tale modificazione progressiva nel Medio Impero e
nei periodi saitico e tolemaico : e le teste si allungano e
si squadrano. Complicato l’aspetto del volto, si liberò dalle
pesanti acconciature; e le armonizzazioni più ricche si esau-
rirono nella perfezione definita della cornice di una testa.
Nei ritratti di tempo romano questa cornice sponta-
neamente assunse — per la limitazione a piani — un’ap-
parenza poligonata o rettangolare : come nello Scipione Rospigliosi, come specialmente
nel ritratto in basalto nero del Museo del Cairo. Sparita con la scomposizione della luce
1 Sul Massimino di Monaco cfr. Furtwàngler, rium in Miinchen (in Mùnchner Jahrbuch (lev hit-
Bvonzeknpl des Kaisers Maximinus, in K. Antiqua- dend,en Kunst, 1907).
Fig. 19 — Cesare
Roma, Museo1 Baracelo
(Fot. Moscioni).
Fig. 18 — Ritratto
Napoli, Museo
(Fotografia Brogli.
la regolarità generica, col raccogliersi dei capelli entro un confine
preciso, senza rientranze e senza emersioni. Nonostante tali
complicazioni, il Massimino ritrova una semplicità generale -
che lo ravvicina ad opere egiziane più antiche — nei piani larghi
e nettamente individuati dal ritaglio a figure metriche. 1
La semplificazione dei piani e la riduzione assiale della
forma appaiono continuate, secondo una evoluzione graduale,
nella statua di Valentiniano I, a Barletta (fig. 16-17). qui
la vasta specchiera, dove bilanciavansi ombre e luci, è sparita.
Certo, nel volto in ispecie, la lucidità vanita dal bronzo, -— che
si è granito col tempo alla superficie — molto deve aver tolto
alla scomposizione solare; ma il rientrare degli angoli spartiiuce
mostra che quella scomposizione assai era stata ridotta. La figura
— vulnerata da molti restauri — non possiede più rigorosa omo-
geneità di regolarizzazione; vi si lista, tuttavia, in scalinate
concentriche di pieghe, il manto rivolto ed in più ampi gradini
paralleli la vesticciuola sospesa alle borchie della corazzale vi
si forma con la palma e le dita della mano una cavità globare
per contenere la sfera. I capelli, come fili di ferro torniti, si ripiegano tutti ad un modo
sulla fronte, sì che si crea una massa anulare intercisa dalla scatola cranica nella fronte
e nelle tempie. Nel diadema, cinto senza pressione attorno ai capelli, ingemmato da due
collane di globetti, s’erge mediana una specie di lingua, come un uraeus. Col venir meno
della frazione dei piani d’ombra-luce, ritorna la predilezione per la perfezione della sfera,
indicata pure da due perle, appese per due fili al diadema.
Si prepara così un altro diadema, anche più regolare, anche più seminato di globi:
quello dell’Arianna capitolina. La semplificazione in quest’opera è portata al massimo
grado. Della frazione dei piani d’ombra-luce non è più
nemmeno il ricordo; e la materia, spoglia di ogni sopra-
creazione visiva, incide direttamente nello spazio il suo vo-
lume regolare. Si è ritornati così alla intuizione puramente
formale delle opere egiziane antiche. L’Arianna capitolina
e la Teodora di Milano riprendono un aspetto simile a
quello degli antichi Faraoni; e nelle stesse acconciature
rinnovano le grandi architetture dei copricapi egiziani.
Nei primi tentativi di volumismo spartiluce la confi-
gurazione generale delle opere era ancora quella imposta
da una intuizione volumetrica pura. Ma la costruzione a
piani chiaroscuri doveva naturalmente trovare un carat-
tere dispositivo diverso nelle opere rinnovate. Si avverte
infatti tale modificazione progressiva nel Medio Impero e
nei periodi saitico e tolemaico : e le teste si allungano e
si squadrano. Complicato l’aspetto del volto, si liberò dalle
pesanti acconciature; e le armonizzazioni più ricche si esau-
rirono nella perfezione definita della cornice di una testa.
Nei ritratti di tempo romano questa cornice sponta-
neamente assunse — per la limitazione a piani — un’ap-
parenza poligonata o rettangolare : come nello Scipione Rospigliosi, come specialmente
nel ritratto in basalto nero del Museo del Cairo. Sparita con la scomposizione della luce
1 Sul Massimino di Monaco cfr. Furtwàngler, rium in Miinchen (in Mùnchner Jahrbuch (lev hit-
Bvonzeknpl des Kaisers Maximinus, in K. Antiqua- dend,en Kunst, 1907).
Fig. 19 — Cesare
Roma, Museo1 Baracelo
(Fot. Moscioni).
Fig. 18 — Ritratto
Napoli, Museo
(Fotografia Brogli.