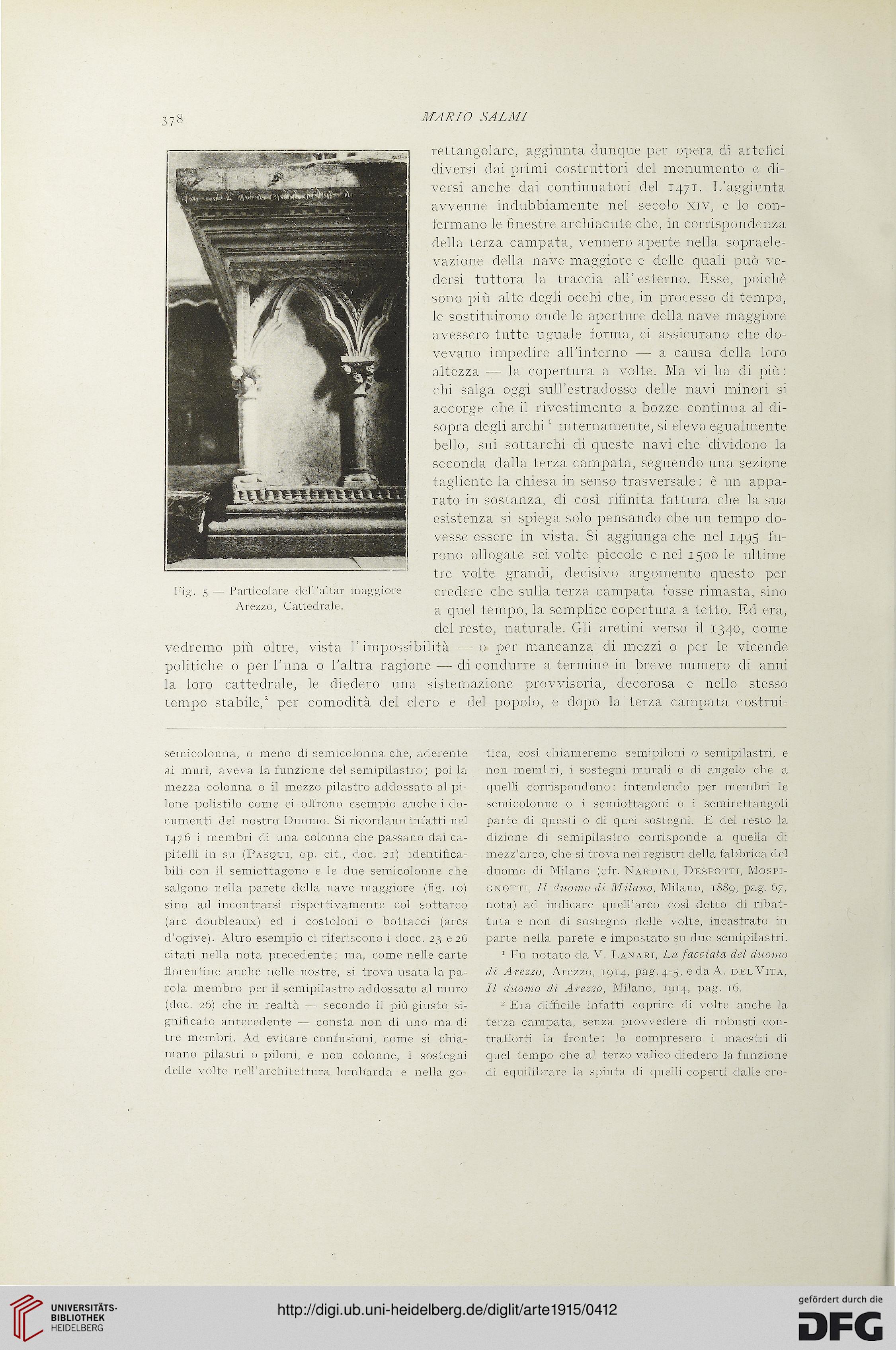378
MARIO SALMI
rettangolare, aggiunta dunque per opera di artefici
diversi dai primi costruttori del monumento e di-
versi anche dai continuatori del 1471. L’aggiunta
avvenne indubbiamente nel secolo xiv, e lo con-
fermano le finestre archiacute che, in corrispondenza
della terza campata, vennero aperte nella sopraele-
vazione della nave maggiore e delle quali può ve-
dersi tuttora la traccia all’esterno. Esse, poiché
sono più alte degli occhi che, in processo di tempo,
le sostituirono onde le aperture della nave maggiore
avessero tutte uguale forma, ci assicurano che do-
vevano impedire all’interno — a causa della loro
altezza — la copertura a volte. Ma vi ha di più :
chi salga oggi sull’estradosso delle navi minori si
accorge che il rivestimento a bozze continua al di-
sopra degli archi1 internamente, si eleva egualmente
bello, sui sottarchi di queste navi che dividono la
seconda dalla terza campata, seguendo una sezione
tagliente la chiesa in senso trasversale : è un appa-
rato in sostanza, di così rifinita fattura die la sua
esistenza si spiega solo pensando che un tempo do-
vesse essere in vista. Si aggiunga che nel 1495 fu-
rono allogate sei volte piccole e nel 1500 le ultime
tre volte grandi, decisivo argomento questo per
credere che sulla terza campata fosse rimasta, sino
a quel tempo, la semplice copertura a tetto. Ed era,
del resto, naturale. Gli aretini verso il 1340, come
vedremo più oltre, vista l’impossibilità —o per mancanza di mezzi o per le vicende
politiche o per l’una o l’altra ragione — di condurre a termine in breve numero di anni
la loro cattedrale, le diedero una sistemazione provvisoria, decorosa e nello stesso
tempo stabile/ per comodità del clero e del popolo, e dopo la terza campata costrui-
Fig. 5 — Particolare dell'aitar maggiore
Arezzo, Cattedrale.
semicolonna, o meno di semicolonna che, aderente
ai muri, aveva la funzione del semipilastro; poi la
mezza colonna o il mezzo pilastro addossato al pi-
lone polistilo come ci offrono esempio anche i do-
cumenti elei nostro Duomo. Si ricordano infatti nel
1476 i membri di una colonna che passano dai ca-
pitelli in su (Pasqui, op. cit., doc. 21) identifica-
bili con il semiottagono e le due semicolonne che
salgono nella parete della nave maggiore (fig. io)
sino ad incontrarsi rispettivamente col sottarco
(are doubleaux) ed i costoloni o bottacci (arcs
d’ogive). Altro esempio ci riferiscono i docc. 23 e 26
citati nella nota precedente; ma, come nelle carte
fiorentine anche nelle nostre, si trova usata la pa-
rola membro per il semipilastro addossato al muro
(doc. 26) che in realtà — secondo il più giusto si-
gnificato antecedente — consta non di uno ma di
tre membri. Ad evitare confusioni, come si chia-
mano pilastri o piloni, e non colonne, i sostegni
delle volte nell’architettura lombarda e nella go-
tica, così chiameremo semipiloni o semipilastri, e
non memi ri, i sostegni murali o di angolo che a
quelli corrispondono; intendendo per membri le
semicolonne o i semiottagoni o i semirettangoli
parte di questi o di quei sostegni. E del resto la
dizione di semipilastro corrisponde a queila di
mezz’arco, che si trova nei registri della fabbrica del
duomo di Milano (cfr. Nar-dini, Despotti, Mospi-
gnotti, Il duomo di Milano, Milano, 1889, pag. 67,
nota) ad indicare quell’arco così detto di ribat-
tuta e non di sostegno delle volte, incastrato in
parte nella parete e impostato su due semipilastri.
1 Fu notato da V. Lanari, La facciata del duomo
di Arezzo, Arezzo, 1914, pag. 4-5, e da A. del Vita,
Il duomo di Arezzo, Milano, T914, pag. 16.
2 Era difficile infatti coprire di volte anche la
terza campata, senza provvedere di robusti con-
trafforti la fronte : lo compresero i maestri di
quel tempo che al terzo valico diedero la funzione
di equilibrare la spinta di quelli coperti dalle ero-
MARIO SALMI
rettangolare, aggiunta dunque per opera di artefici
diversi dai primi costruttori del monumento e di-
versi anche dai continuatori del 1471. L’aggiunta
avvenne indubbiamente nel secolo xiv, e lo con-
fermano le finestre archiacute che, in corrispondenza
della terza campata, vennero aperte nella sopraele-
vazione della nave maggiore e delle quali può ve-
dersi tuttora la traccia all’esterno. Esse, poiché
sono più alte degli occhi che, in processo di tempo,
le sostituirono onde le aperture della nave maggiore
avessero tutte uguale forma, ci assicurano che do-
vevano impedire all’interno — a causa della loro
altezza — la copertura a volte. Ma vi ha di più :
chi salga oggi sull’estradosso delle navi minori si
accorge che il rivestimento a bozze continua al di-
sopra degli archi1 internamente, si eleva egualmente
bello, sui sottarchi di queste navi che dividono la
seconda dalla terza campata, seguendo una sezione
tagliente la chiesa in senso trasversale : è un appa-
rato in sostanza, di così rifinita fattura die la sua
esistenza si spiega solo pensando che un tempo do-
vesse essere in vista. Si aggiunga che nel 1495 fu-
rono allogate sei volte piccole e nel 1500 le ultime
tre volte grandi, decisivo argomento questo per
credere che sulla terza campata fosse rimasta, sino
a quel tempo, la semplice copertura a tetto. Ed era,
del resto, naturale. Gli aretini verso il 1340, come
vedremo più oltre, vista l’impossibilità —o per mancanza di mezzi o per le vicende
politiche o per l’una o l’altra ragione — di condurre a termine in breve numero di anni
la loro cattedrale, le diedero una sistemazione provvisoria, decorosa e nello stesso
tempo stabile/ per comodità del clero e del popolo, e dopo la terza campata costrui-
Fig. 5 — Particolare dell'aitar maggiore
Arezzo, Cattedrale.
semicolonna, o meno di semicolonna che, aderente
ai muri, aveva la funzione del semipilastro; poi la
mezza colonna o il mezzo pilastro addossato al pi-
lone polistilo come ci offrono esempio anche i do-
cumenti elei nostro Duomo. Si ricordano infatti nel
1476 i membri di una colonna che passano dai ca-
pitelli in su (Pasqui, op. cit., doc. 21) identifica-
bili con il semiottagono e le due semicolonne che
salgono nella parete della nave maggiore (fig. io)
sino ad incontrarsi rispettivamente col sottarco
(are doubleaux) ed i costoloni o bottacci (arcs
d’ogive). Altro esempio ci riferiscono i docc. 23 e 26
citati nella nota precedente; ma, come nelle carte
fiorentine anche nelle nostre, si trova usata la pa-
rola membro per il semipilastro addossato al muro
(doc. 26) che in realtà — secondo il più giusto si-
gnificato antecedente — consta non di uno ma di
tre membri. Ad evitare confusioni, come si chia-
mano pilastri o piloni, e non colonne, i sostegni
delle volte nell’architettura lombarda e nella go-
tica, così chiameremo semipiloni o semipilastri, e
non memi ri, i sostegni murali o di angolo che a
quelli corrispondono; intendendo per membri le
semicolonne o i semiottagoni o i semirettangoli
parte di questi o di quei sostegni. E del resto la
dizione di semipilastro corrisponde a queila di
mezz’arco, che si trova nei registri della fabbrica del
duomo di Milano (cfr. Nar-dini, Despotti, Mospi-
gnotti, Il duomo di Milano, Milano, 1889, pag. 67,
nota) ad indicare quell’arco così detto di ribat-
tuta e non di sostegno delle volte, incastrato in
parte nella parete e impostato su due semipilastri.
1 Fu notato da V. Lanari, La facciata del duomo
di Arezzo, Arezzo, 1914, pag. 4-5, e da A. del Vita,
Il duomo di Arezzo, Milano, T914, pag. 16.
2 Era difficile infatti coprire di volte anche la
terza campata, senza provvedere di robusti con-
trafforti la fronte : lo compresero i maestri di
quel tempo che al terzo valico diedero la funzione
di equilibrare la spinta di quelli coperti dalle ero-