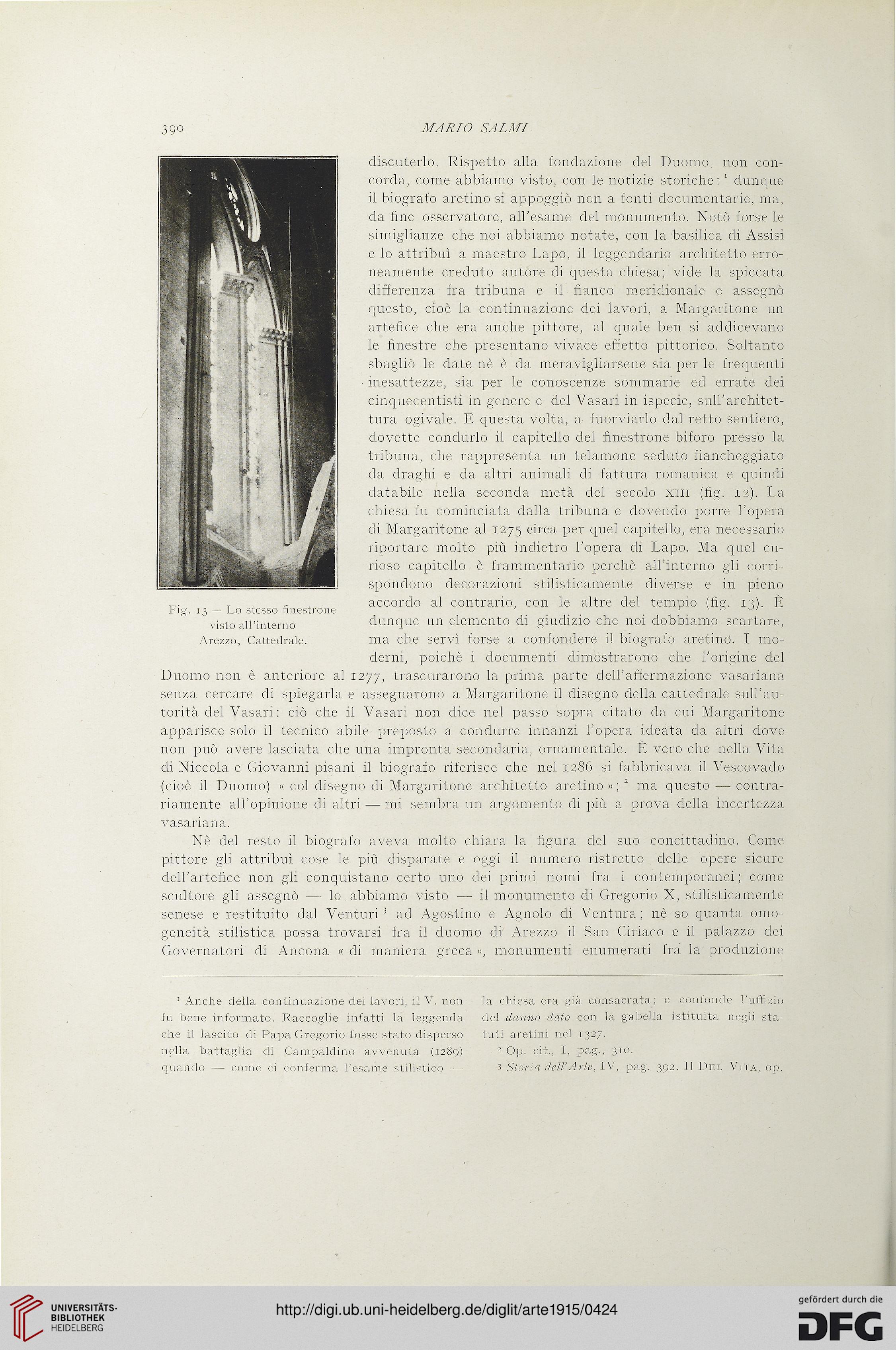MARIO SALMI
3QO
discuterlo. Rispetto alla fondazione del Duomo, non con-
corda, come abbiamo visto, con le notizie storiche: 1 dunque
il biografo aretino si appoggiò non a fonti documentarie, ma,
da fine osservatore, all’esame del monumento. Notò forse le
simiglianze che noi abbiamo notate, con la basilica di Assisi
e lo attribuì a maestro Lapo, il leggendario architetto erro-
neamente creduto autore di questa chiesa; vide la spiccata
differenza fra tribuna e il fianco meridionale e assegnò
questo, cioè la continuazione dei lavori, a Margaritone un
artefice che era anche pittore, al quale ben si addicevano
le finestre che presentano vivace effetto pittorico. Soltanto
sbagliò le date nè è da meravigliarsene sia per le frequenti
inesattezze, sia per le conoscenze sommarie ed errate dei
cinquecentisti in genere e del Vasari in ispecie, sull’architet-
tura ogivale. E questa volta, a fuorviarlo dal retto sentiero,
dovette condurlo il capitello del finestrone biforo presso la
tribuna, che rappresenta un telamone seduto fiancheggiato
da draghi e da altri animali di fattura romanica e quindi
databile nella seconda metà del secolo xm (fig. 12). La
chiesa fu cominciata dalla tribuna e dovendo porre l’opera
di Margaritone al 1275 circa per quel capitello, era necessario
riportare molto più indietro l’opera di Lapo. Ma quel cu-
rioso capitello è frammentario perchè all’interno gli corri-
spondono decorazioni stilisticamente diverse e in pieno
accordo al contrario, con le altre del tempio (fig. 13). È
dunque un elemento di giudizio che noi dobbiamo scartare,
ma che servì forse a confondere il biografo aretino. I mo-
derni, poiché i documenti dimostrarono che l’origine del
Duomo non è anteriore al 1277, trascurarono la prima parte dell’affermazione vasariana
senza cercare di spiegarla e assegnarono a Margaritone il disegno della cattedrale sull’au-
torità del Vasari : ciò che il Vasari non dice nel passo sopra citato da cui Margaritone
apparisce solo il tecnico abile preposto a condurre innanzi l’opera ideata da altri dove
non può avere lasciata che una impronta secondaria, ornamentale. E vero che nella Vita
di Niccola e Giovanni pisani il biografo riferisce che nel 1286 si fabbricava il Vescovado
(cioè il Duomo) « col disegno di Margaritone architetto aretino » ; 2 ma questo — contra-
riamente all’opinione di altri — mi sembra un argomento di più a prova della incertezza
vasariana.
Nè del resto il biografo aveva molto chiara la figura del suo concittadino. Come
pittore gli attribuì cose le più disparate e oggi il numero ristretto delle opere sicure
dell’artefice non gli conquistano certo uno dei primi nomi fra 1 contemporanei; come
scultore gli assegnò — lo abbiamo visto — il monumento di Gregorio X, stilisticamente
senese e restituito dal Venturi 3 ad Agostino e Agnolo di Ventura; nè so quanta omo-
geneità stilistica possa trovarsi fra il duomo di Arezzo il San Ciriaco e il palazzo dei
Governatori di Ancona « di maniera greca », monumenti enumerati fra la produzione
1 Anche della continuazione dei lavori, il V. non
fu bene informato. Raccoglie infatti la leggenda
che il lascito di Papa Gregorio fosse stato disperso
nella battaglia di Campaldino avvenuta (1289)
quando — come ci conferma l’esame stilistico —
la chiesa era già consacrata; e confonde l’uffizio
del danno dato con la gabella istituita negli sta-
tuti aretini nel 1327.
2 Op. cit., I, pag., 310.
3 Storia dell’Arte, IV, pag. 392. 11 Del Vita, op.
3QO
discuterlo. Rispetto alla fondazione del Duomo, non con-
corda, come abbiamo visto, con le notizie storiche: 1 dunque
il biografo aretino si appoggiò non a fonti documentarie, ma,
da fine osservatore, all’esame del monumento. Notò forse le
simiglianze che noi abbiamo notate, con la basilica di Assisi
e lo attribuì a maestro Lapo, il leggendario architetto erro-
neamente creduto autore di questa chiesa; vide la spiccata
differenza fra tribuna e il fianco meridionale e assegnò
questo, cioè la continuazione dei lavori, a Margaritone un
artefice che era anche pittore, al quale ben si addicevano
le finestre che presentano vivace effetto pittorico. Soltanto
sbagliò le date nè è da meravigliarsene sia per le frequenti
inesattezze, sia per le conoscenze sommarie ed errate dei
cinquecentisti in genere e del Vasari in ispecie, sull’architet-
tura ogivale. E questa volta, a fuorviarlo dal retto sentiero,
dovette condurlo il capitello del finestrone biforo presso la
tribuna, che rappresenta un telamone seduto fiancheggiato
da draghi e da altri animali di fattura romanica e quindi
databile nella seconda metà del secolo xm (fig. 12). La
chiesa fu cominciata dalla tribuna e dovendo porre l’opera
di Margaritone al 1275 circa per quel capitello, era necessario
riportare molto più indietro l’opera di Lapo. Ma quel cu-
rioso capitello è frammentario perchè all’interno gli corri-
spondono decorazioni stilisticamente diverse e in pieno
accordo al contrario, con le altre del tempio (fig. 13). È
dunque un elemento di giudizio che noi dobbiamo scartare,
ma che servì forse a confondere il biografo aretino. I mo-
derni, poiché i documenti dimostrarono che l’origine del
Duomo non è anteriore al 1277, trascurarono la prima parte dell’affermazione vasariana
senza cercare di spiegarla e assegnarono a Margaritone il disegno della cattedrale sull’au-
torità del Vasari : ciò che il Vasari non dice nel passo sopra citato da cui Margaritone
apparisce solo il tecnico abile preposto a condurre innanzi l’opera ideata da altri dove
non può avere lasciata che una impronta secondaria, ornamentale. E vero che nella Vita
di Niccola e Giovanni pisani il biografo riferisce che nel 1286 si fabbricava il Vescovado
(cioè il Duomo) « col disegno di Margaritone architetto aretino » ; 2 ma questo — contra-
riamente all’opinione di altri — mi sembra un argomento di più a prova della incertezza
vasariana.
Nè del resto il biografo aveva molto chiara la figura del suo concittadino. Come
pittore gli attribuì cose le più disparate e oggi il numero ristretto delle opere sicure
dell’artefice non gli conquistano certo uno dei primi nomi fra 1 contemporanei; come
scultore gli assegnò — lo abbiamo visto — il monumento di Gregorio X, stilisticamente
senese e restituito dal Venturi 3 ad Agostino e Agnolo di Ventura; nè so quanta omo-
geneità stilistica possa trovarsi fra il duomo di Arezzo il San Ciriaco e il palazzo dei
Governatori di Ancona « di maniera greca », monumenti enumerati fra la produzione
1 Anche della continuazione dei lavori, il V. non
fu bene informato. Raccoglie infatti la leggenda
che il lascito di Papa Gregorio fosse stato disperso
nella battaglia di Campaldino avvenuta (1289)
quando — come ci conferma l’esame stilistico —
la chiesa era già consacrata; e confonde l’uffizio
del danno dato con la gabella istituita negli sta-
tuti aretini nel 1327.
2 Op. cit., I, pag., 310.
3 Storia dell’Arte, IV, pag. 392. 11 Del Vita, op.