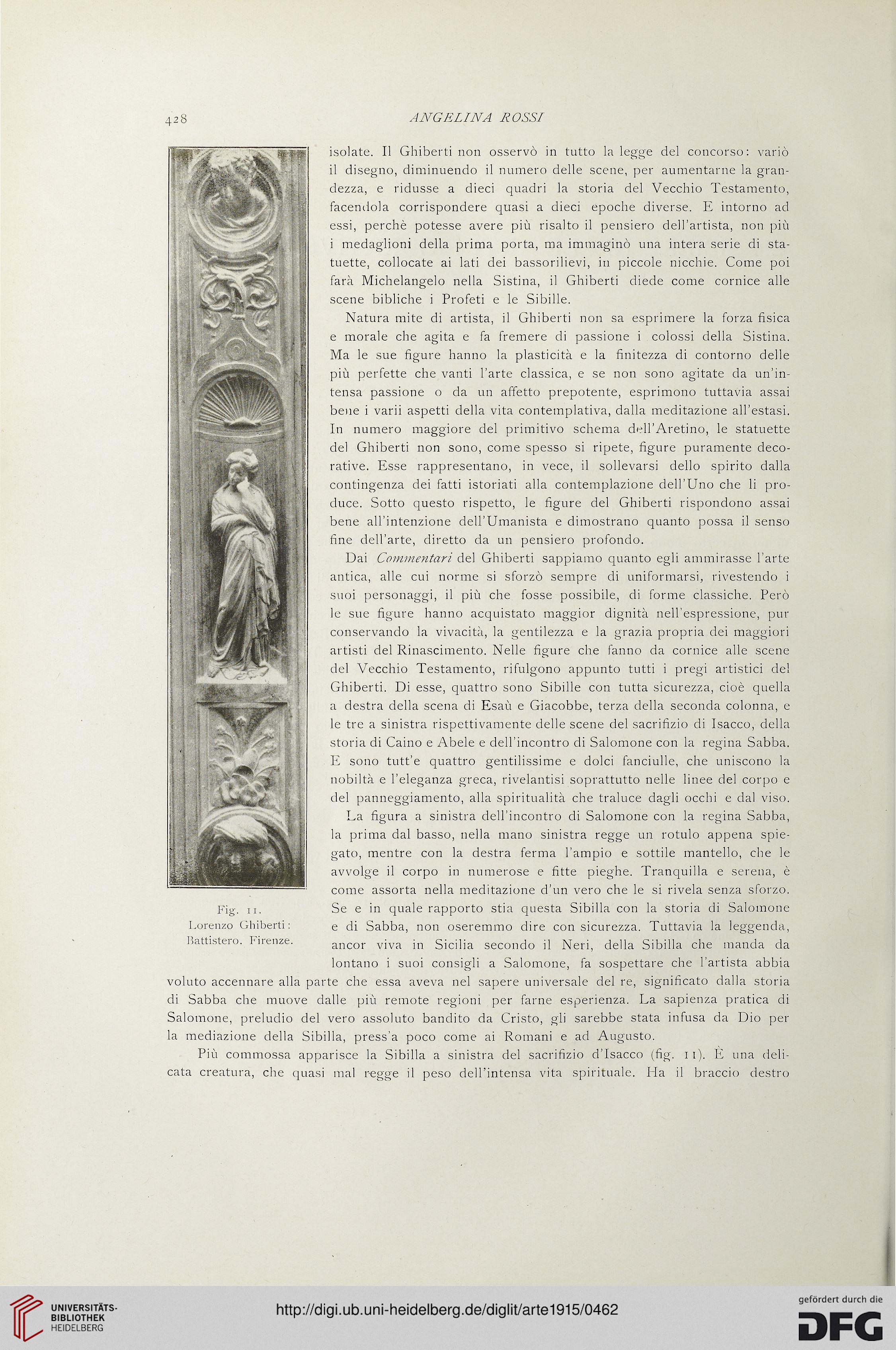428
ANGELINA ROSSI
isolate. Il Ghiberti non osservò in tutto la legge del concorso: variò
il disegno, diminuendo il numero delle scene, per aumentarne la gran-
dezza, e ridusse a dieci quadri la storia del Vecchio Testamento,
facendola corrispondere quasi a dieci epoche diverse. E intorno ad
essi, perchè potesse avere più risalto il pensiero dell’artista, non più
i medaglioni della prima porta, ma immaginò una intera serie di sta-
tuette, collocate ai lati dei bassorilievi, in piccole nicchie. Come poi
farà Michelangelo nella Sistina, il Ghiberti diede come cornice alle
scene bibliche i Profeti e le Sibille.
Natura mite di artista, il Ghiberti non sa esprimere la forza fisica
e morale che agita e fa fremere di passione i colossi della Sistina.
Ma le sue figure hanno la plasticità e la finitezza di contorno delle
più perfette che vanti l’arte classica, e se non sono agitate da un’in-
tensa passione o da un affetto prepotente, esprimono tuttavia assai
bene i varii aspetti della vita contemplativa, dalla meditazione all’estasi.
In numero maggiore del primitivo schema dell’Aretino, le statuette
del Ghiberti non sono, come spesso si ripete, figure puramente deco-
rative. Esse rappresentano, in vece, il sollevarsi dello spirito dalla
contingenza dei fatti istoriati alla contemplazione dell’Uno che li pro-
duce. Sotto questo rispetto, le figure del Ghiberti rispondono assai
bene all’intenzione dell’Umanista e dimostrano quanto possa il senso
fine dell’arte, diretto da un pensiero profondo.
Dai Commentari del Ghiberti sappiamo quanto egli ammirasse l’arte
antica, alle cui norme si sforzò sempre di uniformarsi, rivestendo i
suoi personaggi, il più che fosse possibile, di forme classiche. Però
le sue figure hanno acquistato maggior dignità nell'espressione, pur
conservando la vivacità, la gentilezza e la grazia propria dei maggiori
artisti del Rinascimento. Nelle figure che fanno da cornice alle scene
del Vecchio Testamento, rifulgono appunto tutti i pregi artistici de!
Ghiberti. Di esse, quattro sono Sibille con tutta sicurezza, cioè quella
a destra della scena di Esaù e Giacobbe, terza della seconda colonna, e
le tre a sinistra rispettivamente delle scene del sacrifizio di Isacco, della
storia di Caino e Abele e dell’incontro di Salomone con la regina Sabba.
E sono tutt’e quattro gentilissime e dolci fanciulle, che uniscono la
nobiltà e l’eleganza greca, rivelantisi soprattutto nelle linee del corpo e
del panneggiamento, alla spiritualità che traluce dagli occhi e dal viso.
La figura a sinistra dell’incontro di Salomone con la regina Sabba,
la prima dal basso, nella mano sinistra regge un rotulo appena spie-
gato, mentre con la destra ferma l’ampio e sottile mantello, che le
avvolge il corpo in numerose e fitte pieghe. Tranquilla e serena, è
come assorta nella meditazione d’un vero che le si rivela senza sforzo.
Se e in quale rapporto stia questa Sibilla con la storia di Salomone
e di Sabba, non oseremmo dire con sicurezza. Tuttavia la leggenda,
ancor viva in Sicilia secondo il Neri, della Sibilla che manda da
lontano i suoi consigli a Salomone, fa sospettare che l’artista abbia
voluto accennare alla parte che essa aveva nel sapere universale del re, significato dalla storia
di Sabba che muove dalle più remote regioni per farne esperienza. La sapienza pratica di
Salomone, preludio del vero assoluto bandito da Cristo, gli sarebbe stata infusa da Dio per
la mediazione della Sibilla, press’a poco come ai Romani e ad Augusto.
Più commossa apparisce la Sibilla a sinistra del sacrifizio d’Isacco (fig. il). E una deli-
cata creatura, che quasi mal regge il peso dell’intensa vita spirituale. Ha il braccio destro
Fig. ii.
Lorenzo Ghiberti :
Battistero. Firenze.
ANGELINA ROSSI
isolate. Il Ghiberti non osservò in tutto la legge del concorso: variò
il disegno, diminuendo il numero delle scene, per aumentarne la gran-
dezza, e ridusse a dieci quadri la storia del Vecchio Testamento,
facendola corrispondere quasi a dieci epoche diverse. E intorno ad
essi, perchè potesse avere più risalto il pensiero dell’artista, non più
i medaglioni della prima porta, ma immaginò una intera serie di sta-
tuette, collocate ai lati dei bassorilievi, in piccole nicchie. Come poi
farà Michelangelo nella Sistina, il Ghiberti diede come cornice alle
scene bibliche i Profeti e le Sibille.
Natura mite di artista, il Ghiberti non sa esprimere la forza fisica
e morale che agita e fa fremere di passione i colossi della Sistina.
Ma le sue figure hanno la plasticità e la finitezza di contorno delle
più perfette che vanti l’arte classica, e se non sono agitate da un’in-
tensa passione o da un affetto prepotente, esprimono tuttavia assai
bene i varii aspetti della vita contemplativa, dalla meditazione all’estasi.
In numero maggiore del primitivo schema dell’Aretino, le statuette
del Ghiberti non sono, come spesso si ripete, figure puramente deco-
rative. Esse rappresentano, in vece, il sollevarsi dello spirito dalla
contingenza dei fatti istoriati alla contemplazione dell’Uno che li pro-
duce. Sotto questo rispetto, le figure del Ghiberti rispondono assai
bene all’intenzione dell’Umanista e dimostrano quanto possa il senso
fine dell’arte, diretto da un pensiero profondo.
Dai Commentari del Ghiberti sappiamo quanto egli ammirasse l’arte
antica, alle cui norme si sforzò sempre di uniformarsi, rivestendo i
suoi personaggi, il più che fosse possibile, di forme classiche. Però
le sue figure hanno acquistato maggior dignità nell'espressione, pur
conservando la vivacità, la gentilezza e la grazia propria dei maggiori
artisti del Rinascimento. Nelle figure che fanno da cornice alle scene
del Vecchio Testamento, rifulgono appunto tutti i pregi artistici de!
Ghiberti. Di esse, quattro sono Sibille con tutta sicurezza, cioè quella
a destra della scena di Esaù e Giacobbe, terza della seconda colonna, e
le tre a sinistra rispettivamente delle scene del sacrifizio di Isacco, della
storia di Caino e Abele e dell’incontro di Salomone con la regina Sabba.
E sono tutt’e quattro gentilissime e dolci fanciulle, che uniscono la
nobiltà e l’eleganza greca, rivelantisi soprattutto nelle linee del corpo e
del panneggiamento, alla spiritualità che traluce dagli occhi e dal viso.
La figura a sinistra dell’incontro di Salomone con la regina Sabba,
la prima dal basso, nella mano sinistra regge un rotulo appena spie-
gato, mentre con la destra ferma l’ampio e sottile mantello, che le
avvolge il corpo in numerose e fitte pieghe. Tranquilla e serena, è
come assorta nella meditazione d’un vero che le si rivela senza sforzo.
Se e in quale rapporto stia questa Sibilla con la storia di Salomone
e di Sabba, non oseremmo dire con sicurezza. Tuttavia la leggenda,
ancor viva in Sicilia secondo il Neri, della Sibilla che manda da
lontano i suoi consigli a Salomone, fa sospettare che l’artista abbia
voluto accennare alla parte che essa aveva nel sapere universale del re, significato dalla storia
di Sabba che muove dalle più remote regioni per farne esperienza. La sapienza pratica di
Salomone, preludio del vero assoluto bandito da Cristo, gli sarebbe stata infusa da Dio per
la mediazione della Sibilla, press’a poco come ai Romani e ad Augusto.
Più commossa apparisce la Sibilla a sinistra del sacrifizio d’Isacco (fig. il). E una deli-
cata creatura, che quasi mal regge il peso dell’intensa vita spirituale. Ha il braccio destro
Fig. ii.
Lorenzo Ghiberti :
Battistero. Firenze.