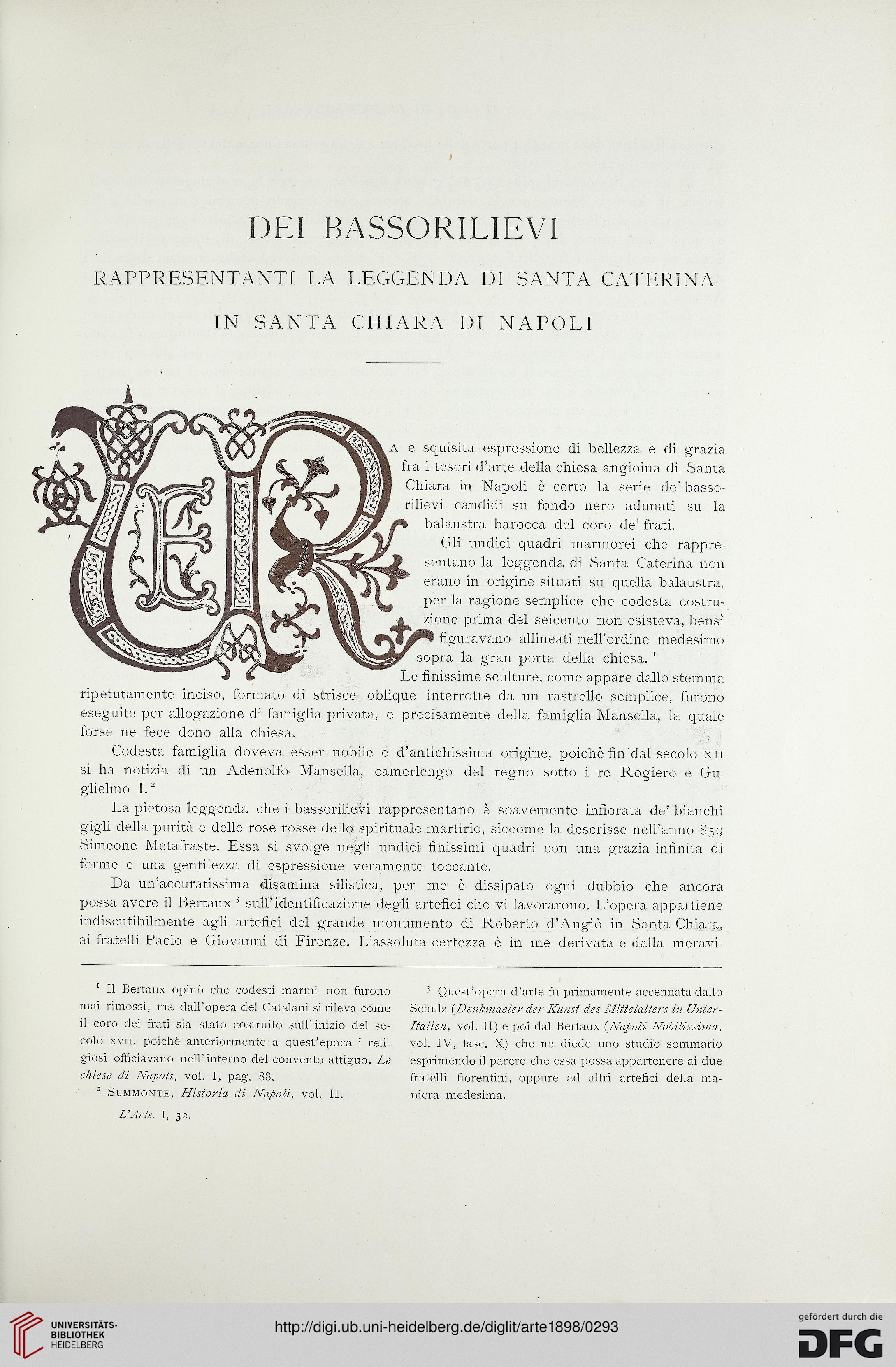DEI BASSORILIEVI
RAPPRESENTANTI LA LEGGENDA DI SANTA CATERINA
IN SANTA CHIARA DI NAPOLI
a e squisita espressione di bellezza e di grazia
fra i tesori d'arte della chiesa angioina di Santa
Chiara in Napoli è certo la serie de' basso-
rilievi candidi su fondo nero adunati su la
balaustra barocca del coro de' frati.
Gli undici quadri marmorei che rappre-
sentano la leggenda di Santa Caterina non
erano in origine situati su quella balaustra,
per la ragione semplice che codesta costru-
zione prima del seicento non esisteva, bensì
figuravano allineati nell'ordine medesimo
sopra la gran porta della chiesa. 1
Le finissime sculture, come appare dallo stemma
ripetutamente inciso, formato di strisce oblique interrotte da un rastrello semplice, furono
eseguite per allogazione di famiglia privata, e precisamente della famiglia Mansella, la quale
forse ne fece dono alla chiesa.
Codesta famiglia doveva esser nobile e d'antichissima origine, poiché fin'dal secolo xii
si ha notizia di un Adenolfo Mansella, camerlengo del regno sotto i re Rogiero e Gu-
glielmo 1.2
La pietosa leggenda che i bassorilievi rappresentano è soavemente infiorata de' bianchi
gigli della purità e delle rose rosse dello spirituale martirio, siccome la descrisse nell'anno 859
Simeone Metafraste. Essa si svolge negli undici finissimi quadri con una grazia infinita di
forme e una gentilezza di espressione veramente toccante.
Da un'accuratissima disamina silistica, per me è dissipato ogni dubbio che ancora
possa avere il Bertaux 3 sullf identificazione degli artefici che vi lavorarono. L'opera appartiene
indiscutibilmente agli artefici del grande monumento di Roberto d'Angiò in Santa Chiara,
ai fratelli Pacio e Giovanni di Firenze. L'assoluta certezza è in me derivata e dalla meravi-
1 ii Bertaux opinò che codesti marmi non furono
mai rimossi, ma dall'opera del Catalani si rileva come
il coro dei frati sia stato costruito sull'inizio del se-
colo xvii, poiché anteriormente a quest'epoca i reli-
giosi officiavano nell'interno del convento attiguo. Le
chiese di Napoli, voi. i, pag. 88.
2 Summonte, Historia di Napoli, voi. ii.
L'Arie. i, 32.
3 Quest'opera d'arte fu primamente accennata dallo
Schulz (Denkmaeler der Kunst des Mittelallers in Unter-
Ilalien, voi. ii) e poi dal Bertaux {Napoli Nobilissima,
voi. iv, fase. X) che ne diede uno studio sommario
esprimendo il parere che essa possa appartenere ai due
fratelli fiorentini, oppure ad altri artefici della ma-
niera medesima.
RAPPRESENTANTI LA LEGGENDA DI SANTA CATERINA
IN SANTA CHIARA DI NAPOLI
a e squisita espressione di bellezza e di grazia
fra i tesori d'arte della chiesa angioina di Santa
Chiara in Napoli è certo la serie de' basso-
rilievi candidi su fondo nero adunati su la
balaustra barocca del coro de' frati.
Gli undici quadri marmorei che rappre-
sentano la leggenda di Santa Caterina non
erano in origine situati su quella balaustra,
per la ragione semplice che codesta costru-
zione prima del seicento non esisteva, bensì
figuravano allineati nell'ordine medesimo
sopra la gran porta della chiesa. 1
Le finissime sculture, come appare dallo stemma
ripetutamente inciso, formato di strisce oblique interrotte da un rastrello semplice, furono
eseguite per allogazione di famiglia privata, e precisamente della famiglia Mansella, la quale
forse ne fece dono alla chiesa.
Codesta famiglia doveva esser nobile e d'antichissima origine, poiché fin'dal secolo xii
si ha notizia di un Adenolfo Mansella, camerlengo del regno sotto i re Rogiero e Gu-
glielmo 1.2
La pietosa leggenda che i bassorilievi rappresentano è soavemente infiorata de' bianchi
gigli della purità e delle rose rosse dello spirituale martirio, siccome la descrisse nell'anno 859
Simeone Metafraste. Essa si svolge negli undici finissimi quadri con una grazia infinita di
forme e una gentilezza di espressione veramente toccante.
Da un'accuratissima disamina silistica, per me è dissipato ogni dubbio che ancora
possa avere il Bertaux 3 sullf identificazione degli artefici che vi lavorarono. L'opera appartiene
indiscutibilmente agli artefici del grande monumento di Roberto d'Angiò in Santa Chiara,
ai fratelli Pacio e Giovanni di Firenze. L'assoluta certezza è in me derivata e dalla meravi-
1 ii Bertaux opinò che codesti marmi non furono
mai rimossi, ma dall'opera del Catalani si rileva come
il coro dei frati sia stato costruito sull'inizio del se-
colo xvii, poiché anteriormente a quest'epoca i reli-
giosi officiavano nell'interno del convento attiguo. Le
chiese di Napoli, voi. i, pag. 88.
2 Summonte, Historia di Napoli, voi. ii.
L'Arie. i, 32.
3 Quest'opera d'arte fu primamente accennata dallo
Schulz (Denkmaeler der Kunst des Mittelallers in Unter-
Ilalien, voi. ii) e poi dal Bertaux {Napoli Nobilissima,
voi. iv, fase. X) che ne diede uno studio sommario
esprimendo il parere che essa possa appartenere ai due
fratelli fiorentini, oppure ad altri artefici della ma-
niera medesima.