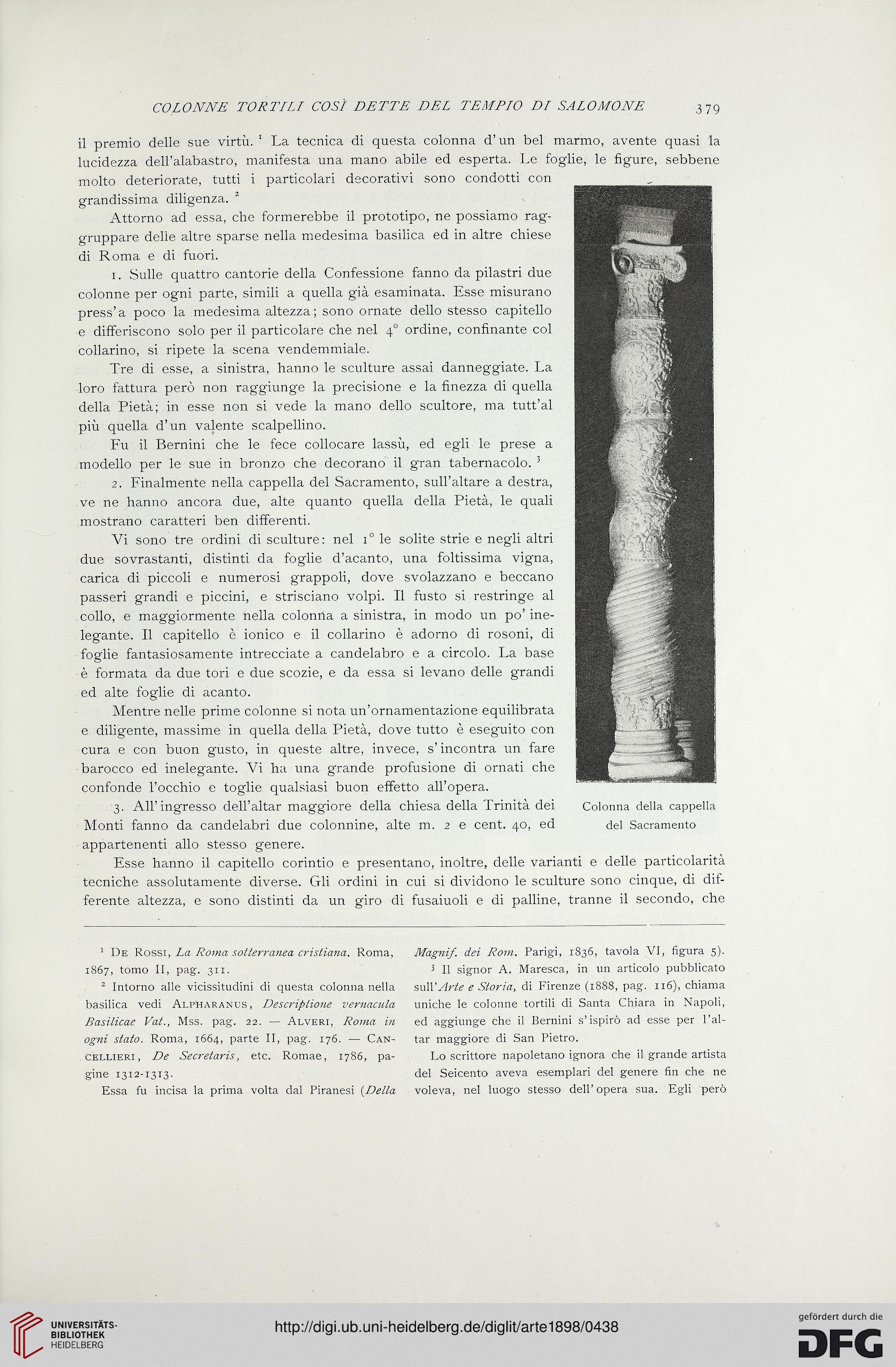COLONNE TORTILI COSÌ DETTE DEL TEMPIO DI SALOMONE
379
il premio delle sue virtù. 1 La tecnica di questa colonna d'un bel marmo, avente quasi la
lucidezza dell'alabastro, manifesta una mano abile ed esperta. Le foglie, le figure, sebbene
molto deteriorate, tutti i particolari decorativi sono condotti con
grandissima diligenza. 2
Attorno ad essa, che formerebbe il prototipo, ne possiamo rag-
gruppare delle altre sparse nella medesima basilica ed in altre chiese
di Roma e di fuori.
1. Sulle quattro cantorie della Confessione fanno da pilastri due
colonne per ogni parte, simili a quella già esaminata. Esse misurano
press'a poco la medesima altezza; sono ornate dello stesso capitello
e differiscono solo per il particolare che nel 40 ordine, confinante col
collarino, si ripete la scena vendemmiale.
Lre di esse, a sinistra, hanno le sculture assai danneggiate. La
loro fattura però non raggiunge la precisione e la finezza di quella
della Pietà; in esse non si vede la mano dello scultore, ma tutt'al
più quella d'un valente scalpellino.
Fu il Bernini che le fece collocare lassù, ed egli le prese a
modello per le sue in bronzo che decorano il gran tabernacolo. 3
2. Finalmente nella cappella del Sacramento, sull'altare a destra,
ve ne hanno ancora due, alte quanto quella della Pietà, le quali
mostrano caratteri ben differenti.
Vi sono tre ordini di sculture: nel i° le solite strie e negli altri
due sovrastanti, distinti da foglie d'acanto, una foltissima vigna,
carica di piccoli e numerosi grappoli, dove svolazzano e beccano
passeri grandi e piccini, e strisciano volpi. Il fusto si restringe al
collo, e maggiormente nella colonna a sinistra, in modo un po' ine-
legante. Il capitello è ionico e il collarino è adorno di rosoni, di
foglie fantasiosamente intrecciate a candelabro e a circolo. La base
è formata da due tori e due scozie, e da essa si levano delle grandi
ed alte foglie di acanto.
Mentre nelle prime colonne si nota un'ornamentazione equilibrata
e diligente, massime in quella della Pietà, dove tutto è eseguito con
cura e con buon gusto, in queste altre, invece, s'incontra un fare
barocco ed inelegante. Vi ha una grande profusione di ornati che
confonde l'occhio e toglie qualsiasi buon effetto all'opera.
3. All'ingresso dell'aitar maggiore della chiesa della Trinità dei Colonna della cappella
Monti fanno da candelabri due colonnine, alte m. 2 e cent. 40, ed del Sacramento
appartenenti allo stesso genere.
Esse hanno il capitello corintio e presentano, inoltre, delle varianti e delle particolarità
tecniche assolutamente diverse. Gli ordini in cui si dividono le sculture sono cinque, di dif-
ferente altezza, e sono distinti da un giro di fusaiuoli e di palline, tranne il secondo, che
1 De Rossi, La Roma sotterranea cristiana. Roma,
1867, tomo II, pag. 311.
2 Intorno alle vicissitudini di questa colonna nella
basilica vedi Alpharanus, Descripiione vernacula
Basilicae Vat., Mss. pag. 22. — Alveri, Roma in
ogni stato. Roma, 1664, parte II, pag. 176. — Can-
cellieri, De Secretaris, etc. Romae, 1786, pa-
gine 1312-1313.
Essa fu incisa la prima volta dal Piranesi (Della
Magni/, dei Rom. Parigi, 1836, tavola VI, figura 5).
3 II signor A. Maresca, in un articolo pubblicato
sull'Arte e Storia, di Firenze (1888, pag. 116), chiama
uniche le colonne tortili di Santa Chiara in Napoli,
ed aggiunge che il Bernini s'ispirò ad esse per l'ai-
tar maggiore di San Pietro.
Lo scrittore napoletano ignora che il grande artista
del Seicento aveva esemplari del genere fin che ne
voleva, nel luogo stesso dell'opera sua. Egli però
379
il premio delle sue virtù. 1 La tecnica di questa colonna d'un bel marmo, avente quasi la
lucidezza dell'alabastro, manifesta una mano abile ed esperta. Le foglie, le figure, sebbene
molto deteriorate, tutti i particolari decorativi sono condotti con
grandissima diligenza. 2
Attorno ad essa, che formerebbe il prototipo, ne possiamo rag-
gruppare delle altre sparse nella medesima basilica ed in altre chiese
di Roma e di fuori.
1. Sulle quattro cantorie della Confessione fanno da pilastri due
colonne per ogni parte, simili a quella già esaminata. Esse misurano
press'a poco la medesima altezza; sono ornate dello stesso capitello
e differiscono solo per il particolare che nel 40 ordine, confinante col
collarino, si ripete la scena vendemmiale.
Lre di esse, a sinistra, hanno le sculture assai danneggiate. La
loro fattura però non raggiunge la precisione e la finezza di quella
della Pietà; in esse non si vede la mano dello scultore, ma tutt'al
più quella d'un valente scalpellino.
Fu il Bernini che le fece collocare lassù, ed egli le prese a
modello per le sue in bronzo che decorano il gran tabernacolo. 3
2. Finalmente nella cappella del Sacramento, sull'altare a destra,
ve ne hanno ancora due, alte quanto quella della Pietà, le quali
mostrano caratteri ben differenti.
Vi sono tre ordini di sculture: nel i° le solite strie e negli altri
due sovrastanti, distinti da foglie d'acanto, una foltissima vigna,
carica di piccoli e numerosi grappoli, dove svolazzano e beccano
passeri grandi e piccini, e strisciano volpi. Il fusto si restringe al
collo, e maggiormente nella colonna a sinistra, in modo un po' ine-
legante. Il capitello è ionico e il collarino è adorno di rosoni, di
foglie fantasiosamente intrecciate a candelabro e a circolo. La base
è formata da due tori e due scozie, e da essa si levano delle grandi
ed alte foglie di acanto.
Mentre nelle prime colonne si nota un'ornamentazione equilibrata
e diligente, massime in quella della Pietà, dove tutto è eseguito con
cura e con buon gusto, in queste altre, invece, s'incontra un fare
barocco ed inelegante. Vi ha una grande profusione di ornati che
confonde l'occhio e toglie qualsiasi buon effetto all'opera.
3. All'ingresso dell'aitar maggiore della chiesa della Trinità dei Colonna della cappella
Monti fanno da candelabri due colonnine, alte m. 2 e cent. 40, ed del Sacramento
appartenenti allo stesso genere.
Esse hanno il capitello corintio e presentano, inoltre, delle varianti e delle particolarità
tecniche assolutamente diverse. Gli ordini in cui si dividono le sculture sono cinque, di dif-
ferente altezza, e sono distinti da un giro di fusaiuoli e di palline, tranne il secondo, che
1 De Rossi, La Roma sotterranea cristiana. Roma,
1867, tomo II, pag. 311.
2 Intorno alle vicissitudini di questa colonna nella
basilica vedi Alpharanus, Descripiione vernacula
Basilicae Vat., Mss. pag. 22. — Alveri, Roma in
ogni stato. Roma, 1664, parte II, pag. 176. — Can-
cellieri, De Secretaris, etc. Romae, 1786, pa-
gine 1312-1313.
Essa fu incisa la prima volta dal Piranesi (Della
Magni/, dei Rom. Parigi, 1836, tavola VI, figura 5).
3 II signor A. Maresca, in un articolo pubblicato
sull'Arte e Storia, di Firenze (1888, pag. 116), chiama
uniche le colonne tortili di Santa Chiara in Napoli,
ed aggiunge che il Bernini s'ispirò ad esse per l'ai-
tar maggiore di San Pietro.
Lo scrittore napoletano ignora che il grande artista
del Seicento aveva esemplari del genere fin che ne
voleva, nel luogo stesso dell'opera sua. Egli però