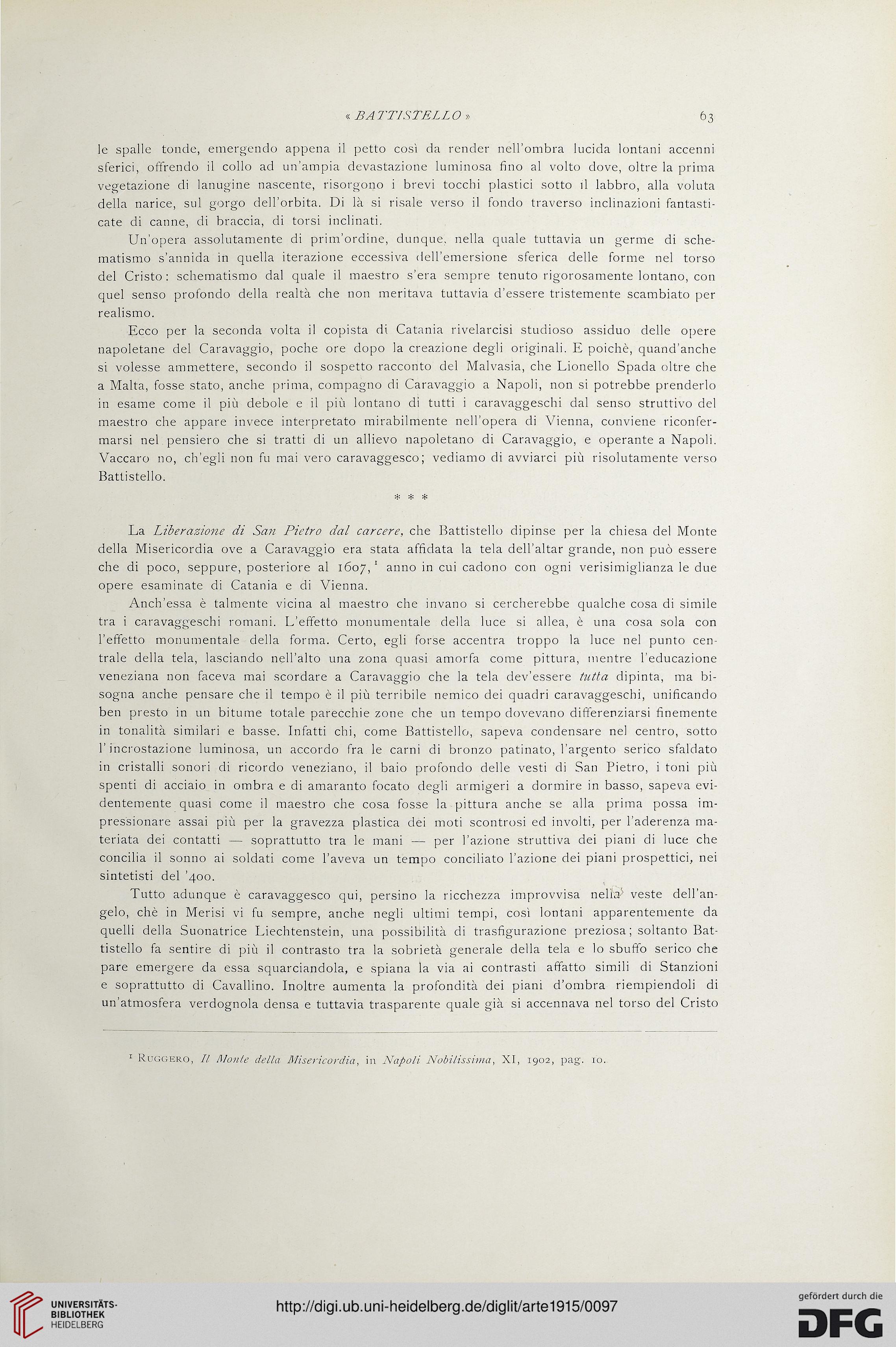« BATTI STELLO »
63
le spalle tonde, emergendo appena il petto così da render nell’ombra lucida lontani accenni
sferici, offrendo il collo ad un’ampia devastazione luminosa fino al volto dove, oltre la prima
vegetazione di lanugine nascente, risorgono i brevi tocchi plastici sotto il labbro, alla voluta
della narice, sul gorgo dell’orbita. Di là si risale verso il fondo traverso inclinazioni fantasti-
cate di canne, di braccia, di torsi inclinati.
Un’opera assolutamente di prim’ordine, dunque, nella quale tuttavia un germe di sche-
matismo s’annida in quella iterazione eccessiva dell’emersione sferica delle forme nel torso
del Cristo: schematismo dal quale il maestro s’era sempre tenuto rigorosamente lontano, con
quel senso profondo della realtà che non meritava tuttavia d’essere tristemente scambiato per
realismo.
Ecco per la seconda volta il copista di Catania rivelarcisi studioso assiduo delle opere
napoletane del Caravaggio, poche ore dopo la creazione degli originali. E poiché, quand’anche
si volesse ammettere, secondo il sospetto racconto del Malvasia, che Lionello Spada oltre che
a Malta, fosse stato, anche prima, compagno di Caravaggio a Napoli, non si potrebbe prenderlo
in esame come il più debole e il più lontano di tutti i caravaggeschi dal senso struttivo del
maestro che appare invece interpretato mirabilmente nell’opera di Vienna, conviene riconfer-
marsi nel pensiero che si tratti di un allievo napoletano di Caravaggio, e operante a Napoli.
Vaccaro no, ch’egli non fu mai vero caravaggesco; vediamo di avviarci più risolutamente verso
Battistello.
^ ^ ^
La Liberazione di San Pietro dal carcere, che Battistello dipinse per la chiesa del Monte
della Misericordia ove a Caravaggio era stata affidata la tela dell’altar grande, non può essere
che di poco, seppure, posteriore al 1607, 1 anno in cui cadono con ogni verisimiglìanza le due
opere esaminate di Catania e di Vienna.
Anch’essa è talmente vicina al maestro che invano si cercherebbe qualche cosa di simile
tra i caravaggeschi romani. L’effetto monumentale della luce si allea, è una cosa sola con
l’effetto monumentale della forma. Certo, egli forse accentra troppo la luce nel punto cen-
trale della tela, lasciando nell’alto una zona quasi amorfa come pittura, mentre l’educazione
veneziana non faceva mai scordare a Caravaggio che la tela dev’essere tutta dipinta, ma bi-
sogna anche pensare che il tempo è il più terribile nemico dei quadri caravaggeschi, unificando
ben presto in un bitume totale parecchie zone che un tempo dovevano differenziarsi finemente
in tonalità similari e basse. Infatti chi, come Battistello, sapeva condensare nel centro, sotto
l’incrostazione luminosa, un accordo fra le carni di bronzo patinato, l’argento serico sfaldato
in cristalli sonori di ricordo veneziano, il baio profondo delle vesti di San Pietro, i toni più
spenti di acciaio in ombra e di amaranto focato degli armigeri a dormire in basso, sapeva evi-
dentemente quasi come il maestro che cosa fosse la pittura anche se alla prima possa im-
pressionare assai più per la gravezza plastica dei moti scontrosi ed involti, per l’aderenza ma-
teriata dei contatti — soprattutto tra le mani — per l’azione struttiva dei piani di luce che
concilia il sonno ai soldati come l’aveva un tempo conciliato l’azione dei piani prospettici, nei
sintetisti del '400.
Tutto adunque è caravaggesco qui, persino la ricchezza improvvisa nella veste dell’an-
gelo, chè in Merisi vi fu sempre, anche negli ultimi tempi, così lontani apparentemente da
quelli della Suonatrice Liechtenstein, una possibilità di trasfigurazione preziosa ; soltanto Bat-
tistello fa sentire di più il contrasto tra la sobrietà generale della tela e lo sbuffo serico che
pare emergere da essa squarciandola, e spiana la via ai contrasti affatto simili di Stanzioni
e soprattutto di Cavallino. Inoltre aumenta la profondità dei piani d’ombra riempiendoli di
un’atmosfera verdognola densa e tuttavia trasparente quale già si accennava nel torso del Cristo
1 Ruggero, IL A/onte della Misericordia, in Napoli Nobilissima, XI, 1902, pag. io.
63
le spalle tonde, emergendo appena il petto così da render nell’ombra lucida lontani accenni
sferici, offrendo il collo ad un’ampia devastazione luminosa fino al volto dove, oltre la prima
vegetazione di lanugine nascente, risorgono i brevi tocchi plastici sotto il labbro, alla voluta
della narice, sul gorgo dell’orbita. Di là si risale verso il fondo traverso inclinazioni fantasti-
cate di canne, di braccia, di torsi inclinati.
Un’opera assolutamente di prim’ordine, dunque, nella quale tuttavia un germe di sche-
matismo s’annida in quella iterazione eccessiva dell’emersione sferica delle forme nel torso
del Cristo: schematismo dal quale il maestro s’era sempre tenuto rigorosamente lontano, con
quel senso profondo della realtà che non meritava tuttavia d’essere tristemente scambiato per
realismo.
Ecco per la seconda volta il copista di Catania rivelarcisi studioso assiduo delle opere
napoletane del Caravaggio, poche ore dopo la creazione degli originali. E poiché, quand’anche
si volesse ammettere, secondo il sospetto racconto del Malvasia, che Lionello Spada oltre che
a Malta, fosse stato, anche prima, compagno di Caravaggio a Napoli, non si potrebbe prenderlo
in esame come il più debole e il più lontano di tutti i caravaggeschi dal senso struttivo del
maestro che appare invece interpretato mirabilmente nell’opera di Vienna, conviene riconfer-
marsi nel pensiero che si tratti di un allievo napoletano di Caravaggio, e operante a Napoli.
Vaccaro no, ch’egli non fu mai vero caravaggesco; vediamo di avviarci più risolutamente verso
Battistello.
^ ^ ^
La Liberazione di San Pietro dal carcere, che Battistello dipinse per la chiesa del Monte
della Misericordia ove a Caravaggio era stata affidata la tela dell’altar grande, non può essere
che di poco, seppure, posteriore al 1607, 1 anno in cui cadono con ogni verisimiglìanza le due
opere esaminate di Catania e di Vienna.
Anch’essa è talmente vicina al maestro che invano si cercherebbe qualche cosa di simile
tra i caravaggeschi romani. L’effetto monumentale della luce si allea, è una cosa sola con
l’effetto monumentale della forma. Certo, egli forse accentra troppo la luce nel punto cen-
trale della tela, lasciando nell’alto una zona quasi amorfa come pittura, mentre l’educazione
veneziana non faceva mai scordare a Caravaggio che la tela dev’essere tutta dipinta, ma bi-
sogna anche pensare che il tempo è il più terribile nemico dei quadri caravaggeschi, unificando
ben presto in un bitume totale parecchie zone che un tempo dovevano differenziarsi finemente
in tonalità similari e basse. Infatti chi, come Battistello, sapeva condensare nel centro, sotto
l’incrostazione luminosa, un accordo fra le carni di bronzo patinato, l’argento serico sfaldato
in cristalli sonori di ricordo veneziano, il baio profondo delle vesti di San Pietro, i toni più
spenti di acciaio in ombra e di amaranto focato degli armigeri a dormire in basso, sapeva evi-
dentemente quasi come il maestro che cosa fosse la pittura anche se alla prima possa im-
pressionare assai più per la gravezza plastica dei moti scontrosi ed involti, per l’aderenza ma-
teriata dei contatti — soprattutto tra le mani — per l’azione struttiva dei piani di luce che
concilia il sonno ai soldati come l’aveva un tempo conciliato l’azione dei piani prospettici, nei
sintetisti del '400.
Tutto adunque è caravaggesco qui, persino la ricchezza improvvisa nella veste dell’an-
gelo, chè in Merisi vi fu sempre, anche negli ultimi tempi, così lontani apparentemente da
quelli della Suonatrice Liechtenstein, una possibilità di trasfigurazione preziosa ; soltanto Bat-
tistello fa sentire di più il contrasto tra la sobrietà generale della tela e lo sbuffo serico che
pare emergere da essa squarciandola, e spiana la via ai contrasti affatto simili di Stanzioni
e soprattutto di Cavallino. Inoltre aumenta la profondità dei piani d’ombra riempiendoli di
un’atmosfera verdognola densa e tuttavia trasparente quale già si accennava nel torso del Cristo
1 Ruggero, IL A/onte della Misericordia, in Napoli Nobilissima, XI, 1902, pag. io.