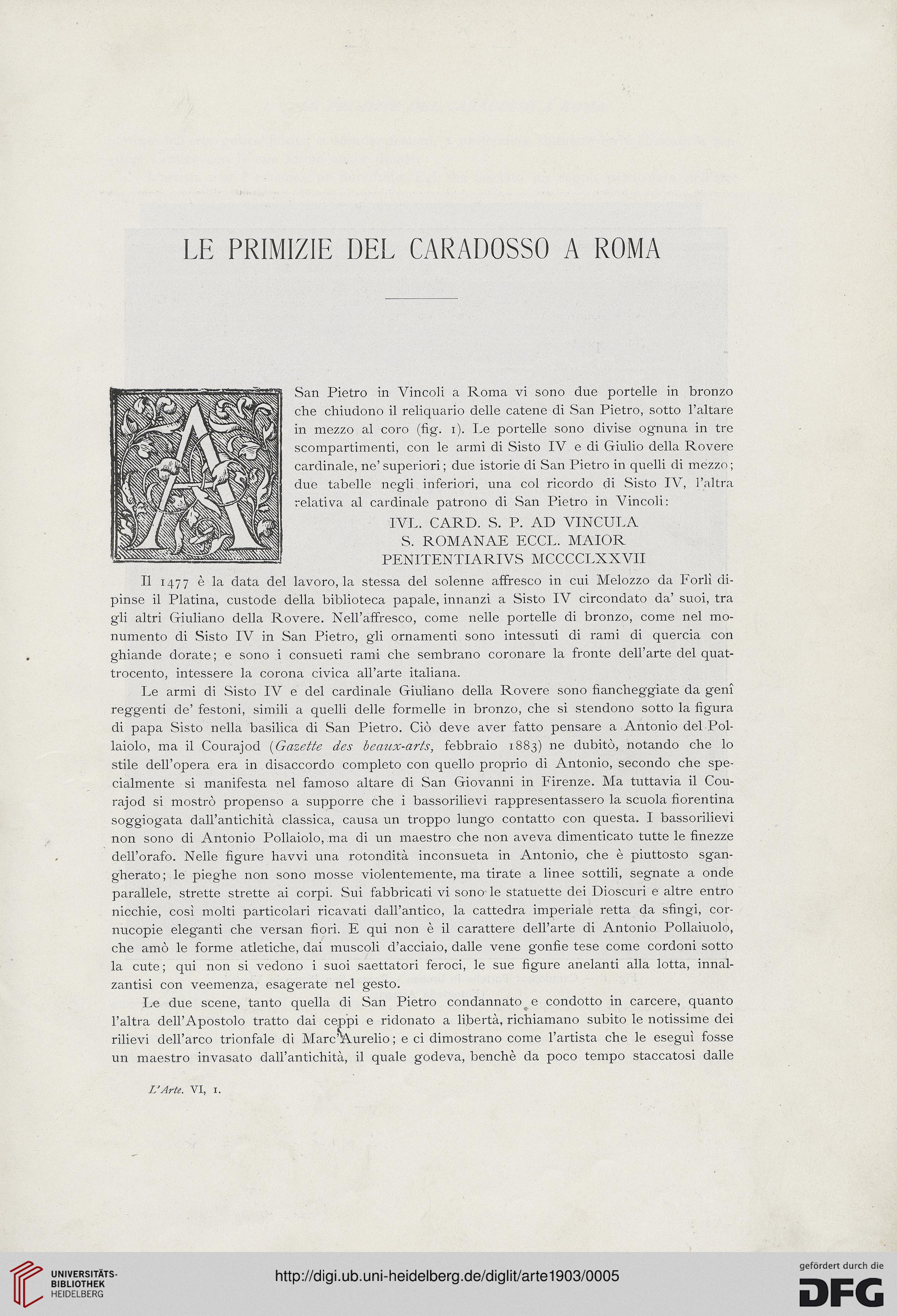LE PRIMIZIE DEL CARADOSSO A ROMA
San Pietro in Vincoli a Roma vi sono due portelle in bronzo
che chiudono il reliquario delle catene di San Pietro, sotto l’altare
in mezzo al coro (fig. i). Le portelle sono divise ognuna in tre
scompartimenti, con le armi di Sisto IV e di Giulio della Rovere
cardinale, ne’superiori ; due istorie di San Pietro in quelli di mezzo;
due tabelle negli inferiori, una col ricordo di Sisto IV, l’altra
relativa al cardinale patrono di San Pietro in Vincoli:
IVL. CARD. S. P. AD VINCULA
S. ROMANAE ECCL. MAIOR
PENITENTIARIVS MCCCCLXXVII
Il 1477 è la data del lavoro, la stessa del solenne affresco in cui Melozzo da Forlì di-
pinse il Platina, custode della biblioteca papale, innanzi a Sisto IV circondato da’ suoi, tra
gli altri Giuliano della Rovere. Nell’affresco, come nelle portelle di bronzo, come nel mo-
numento di Sisto IV in San Pietro, gli ornamenti sono intessuti di rami di quercia con
ghiande dorate; e sono i consueti rami che sembrano coronare la fronte dell’arte del quat-
trocento, intessere la corona civica all’arte italiana.
Le armi di Sisto IV e del cardinale Giuliano della Rovere sono fiancheggiate da geni
reggenti de’ festoni, simili a quelli delle formelle in bronzo, che si stendono sotto la figura
di papa Sisto nella basilica di San Pietro. Ciò deve aver fatto pensare a Antonio del Pol-
laiolo, ma il Courajod (Gavette des beaux-arts, febbraio 1883) ne dubitò, notando che lo
stile dell’opera era in disaccordo completo con quello proprio di Antonio, secondo che spe-
cialmente si manifesta nel famoso altare di San Giovanni in Firenze. Ma tuttavia il Cou-
rajod si mostrò propenso a supporre che i bassorilievi rappresentassero la scuola fiorentina
soggiogata dall’antichità classica, causa un troppo lungo contatto con questa. I bassorilievi
non sono di Antonio Pollaiolo, ma di un maestro che non aveva dimenticato tutte le finezze
dell’orafo. Nelle figure havvi una rotondità inconsueta in Antonio, che è piuttosto sgan-
gherato; le pieghe non sono mosse violentemente, ma tirate a linee sottili, segnate a onde
parallele, strette strette ai corpi. Sui fabbricati vi sono le statuette dei Dioscuri e altre entro
nicchie, così molti particolari ricavati dall’antico, la cattedra imperiale retta da sfingi, cor-
nucopie eleganti che versan fiori. E qui non è il carattere dell’arte di Antonio Poliamolo,
che amò le forme atletiche, dai muscoli d’acciaio, dalle vene gonfie tese come cordoni sotto
la cute; qui non si vedono i suoi saettatori feroci, le sue figure anelanti alla lotta, innal-
zantisi con veemenza, esagerate nel gesto.
Le due scene, tanto quella di San Pietro condannatole condotto in carcere, quanto
l’altra dell’Apostolo tratto dai ceppi e ridonato a libertà, richiamano subito le notissime dei
rilievi dell’arco trionfale di Marc’Aurelio ; e ci dimostrano come l’artista che le eseguì fosse
un maestro invasato dall’antichità, il quale godeva, benché da poco tempo staccatosi dalle
L'Arte. VI, 1.
San Pietro in Vincoli a Roma vi sono due portelle in bronzo
che chiudono il reliquario delle catene di San Pietro, sotto l’altare
in mezzo al coro (fig. i). Le portelle sono divise ognuna in tre
scompartimenti, con le armi di Sisto IV e di Giulio della Rovere
cardinale, ne’superiori ; due istorie di San Pietro in quelli di mezzo;
due tabelle negli inferiori, una col ricordo di Sisto IV, l’altra
relativa al cardinale patrono di San Pietro in Vincoli:
IVL. CARD. S. P. AD VINCULA
S. ROMANAE ECCL. MAIOR
PENITENTIARIVS MCCCCLXXVII
Il 1477 è la data del lavoro, la stessa del solenne affresco in cui Melozzo da Forlì di-
pinse il Platina, custode della biblioteca papale, innanzi a Sisto IV circondato da’ suoi, tra
gli altri Giuliano della Rovere. Nell’affresco, come nelle portelle di bronzo, come nel mo-
numento di Sisto IV in San Pietro, gli ornamenti sono intessuti di rami di quercia con
ghiande dorate; e sono i consueti rami che sembrano coronare la fronte dell’arte del quat-
trocento, intessere la corona civica all’arte italiana.
Le armi di Sisto IV e del cardinale Giuliano della Rovere sono fiancheggiate da geni
reggenti de’ festoni, simili a quelli delle formelle in bronzo, che si stendono sotto la figura
di papa Sisto nella basilica di San Pietro. Ciò deve aver fatto pensare a Antonio del Pol-
laiolo, ma il Courajod (Gavette des beaux-arts, febbraio 1883) ne dubitò, notando che lo
stile dell’opera era in disaccordo completo con quello proprio di Antonio, secondo che spe-
cialmente si manifesta nel famoso altare di San Giovanni in Firenze. Ma tuttavia il Cou-
rajod si mostrò propenso a supporre che i bassorilievi rappresentassero la scuola fiorentina
soggiogata dall’antichità classica, causa un troppo lungo contatto con questa. I bassorilievi
non sono di Antonio Pollaiolo, ma di un maestro che non aveva dimenticato tutte le finezze
dell’orafo. Nelle figure havvi una rotondità inconsueta in Antonio, che è piuttosto sgan-
gherato; le pieghe non sono mosse violentemente, ma tirate a linee sottili, segnate a onde
parallele, strette strette ai corpi. Sui fabbricati vi sono le statuette dei Dioscuri e altre entro
nicchie, così molti particolari ricavati dall’antico, la cattedra imperiale retta da sfingi, cor-
nucopie eleganti che versan fiori. E qui non è il carattere dell’arte di Antonio Poliamolo,
che amò le forme atletiche, dai muscoli d’acciaio, dalle vene gonfie tese come cordoni sotto
la cute; qui non si vedono i suoi saettatori feroci, le sue figure anelanti alla lotta, innal-
zantisi con veemenza, esagerate nel gesto.
Le due scene, tanto quella di San Pietro condannatole condotto in carcere, quanto
l’altra dell’Apostolo tratto dai ceppi e ridonato a libertà, richiamano subito le notissime dei
rilievi dell’arco trionfale di Marc’Aurelio ; e ci dimostrano come l’artista che le eseguì fosse
un maestro invasato dall’antichità, il quale godeva, benché da poco tempo staccatosi dalle
L'Arte. VI, 1.