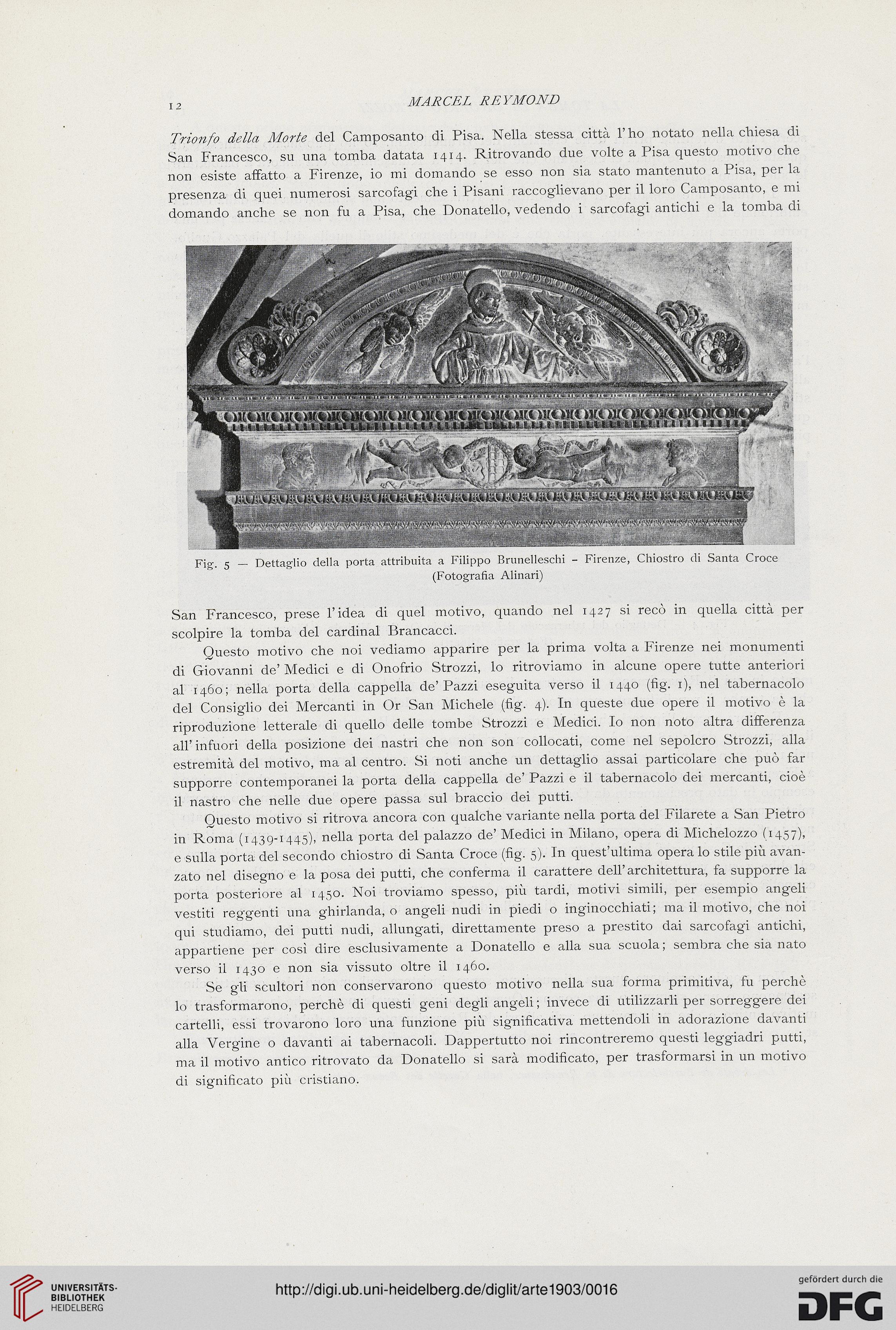MARCEL REYMOND
Trionfo della Morte del Camposanto di Pisa. Nella stessa città l’ho notato nella chiesa di
San Francesco, su una tomba datata 1414. Ritrovando due volte a Pisa questo motivo che
non esiste affatto a Firenze, io mi domando se esso non sia stato mantenuto a Pisa, per la
presenza di quei numerosi sarcofagi che i Pisani raccoglievano per il loro Camposanto, e mi
domando anche se non fu a Pisa, che Donatello, vedendo i sarcofagi antichi e la tomba di
San Francesco, prese l’idea di quel motivo, quando nel 1427 si recò in quella città per
scolpire la tomba del Cardinal Brancacci.
Questo motivo che noi vediamo apparire per la prima volta a Firenze nei monumenti
di Giovanni de’ Medici e di Onofrio Strozzi, lo ritroviamo in alcune opere tutte anteriori
al 1460; nella porta della cappella de’Pazzi eseguita verso il 1440 (fig. 1), nel tabernacolo
del Consiglio dei Mercanti in Or San Michele (fig. 4). In queste due opere il motivo è la
riproduzione letterale di quello delle tombe Strozzi e Medici. Io non noto altra differenza
all’infuori della posizione dei nastri che non son collocati, come nel sepolcro Strozzi, alla
estremità del motivo, ma al centro. Si noti anche un dettaglio assai particolare che può far
supporre contemporanei la porta della cappella de’ Pazzi e il tabernacolo dei mercanti, cioè
il nastro che nelle due opere passa sul braccio dei putti.
Questo motivo si ritrova ancora con qualche variante nella porta del Filarete a San Pietro
in Roma (1439-1445), nella porta del palazzo de’ Medici in Milano, opera di Michelozzo (1457),
e sulla porta del secondo chiostro di Santa Croce (fig. 5). In quest’ultima opera lo stile più avan-
zato nel disegno e la posa dei putti, che conferma il carattere dell’architettura, fa supporre la
porta posteriore al 1450. Noi troviamo spesso, più tardi, motivi simili, per esempio angeli
vestiti reggenti una ghirlanda, o angeli nudi in piedi o inginocchiati; ma il motivo, che noi
qui studiamo, dei putti nudi, allungati, direttamente preso a prestito dai sarcofagi antichi,
appartiene per così dire esclusivamente a Donatello e alla sua scuola ; sembra che sia nato
verso il 1430 e non sia vissuto oltre il 1460.
Se gli scultori non conservarono questo motivo nella sua forma primitiva, fu perchè
lo trasformarono, perchè di questi geni degli angeli ; invece di utilizzarli per sorreggere dei
cartelli, essi trovarono loro una funzione più significativa mettendoli in adorazione davanti
alla Vergine o davanti ai tabernacoli. Dappertutto noi rincontreremo questi leggiadri putti,
ma il motivo antico ritrovato da Donatello si sarà modificato, per trasformarsi in un motivo
di significato più cristiano.
Fig. 5 — Dettaglio della porta attribuita a Filippo Brunelleschi -
(Fotografia Alinari)
Firenze, Chiostro di Santa Croce
Trionfo della Morte del Camposanto di Pisa. Nella stessa città l’ho notato nella chiesa di
San Francesco, su una tomba datata 1414. Ritrovando due volte a Pisa questo motivo che
non esiste affatto a Firenze, io mi domando se esso non sia stato mantenuto a Pisa, per la
presenza di quei numerosi sarcofagi che i Pisani raccoglievano per il loro Camposanto, e mi
domando anche se non fu a Pisa, che Donatello, vedendo i sarcofagi antichi e la tomba di
San Francesco, prese l’idea di quel motivo, quando nel 1427 si recò in quella città per
scolpire la tomba del Cardinal Brancacci.
Questo motivo che noi vediamo apparire per la prima volta a Firenze nei monumenti
di Giovanni de’ Medici e di Onofrio Strozzi, lo ritroviamo in alcune opere tutte anteriori
al 1460; nella porta della cappella de’Pazzi eseguita verso il 1440 (fig. 1), nel tabernacolo
del Consiglio dei Mercanti in Or San Michele (fig. 4). In queste due opere il motivo è la
riproduzione letterale di quello delle tombe Strozzi e Medici. Io non noto altra differenza
all’infuori della posizione dei nastri che non son collocati, come nel sepolcro Strozzi, alla
estremità del motivo, ma al centro. Si noti anche un dettaglio assai particolare che può far
supporre contemporanei la porta della cappella de’ Pazzi e il tabernacolo dei mercanti, cioè
il nastro che nelle due opere passa sul braccio dei putti.
Questo motivo si ritrova ancora con qualche variante nella porta del Filarete a San Pietro
in Roma (1439-1445), nella porta del palazzo de’ Medici in Milano, opera di Michelozzo (1457),
e sulla porta del secondo chiostro di Santa Croce (fig. 5). In quest’ultima opera lo stile più avan-
zato nel disegno e la posa dei putti, che conferma il carattere dell’architettura, fa supporre la
porta posteriore al 1450. Noi troviamo spesso, più tardi, motivi simili, per esempio angeli
vestiti reggenti una ghirlanda, o angeli nudi in piedi o inginocchiati; ma il motivo, che noi
qui studiamo, dei putti nudi, allungati, direttamente preso a prestito dai sarcofagi antichi,
appartiene per così dire esclusivamente a Donatello e alla sua scuola ; sembra che sia nato
verso il 1430 e non sia vissuto oltre il 1460.
Se gli scultori non conservarono questo motivo nella sua forma primitiva, fu perchè
lo trasformarono, perchè di questi geni degli angeli ; invece di utilizzarli per sorreggere dei
cartelli, essi trovarono loro una funzione più significativa mettendoli in adorazione davanti
alla Vergine o davanti ai tabernacoli. Dappertutto noi rincontreremo questi leggiadri putti,
ma il motivo antico ritrovato da Donatello si sarà modificato, per trasformarsi in un motivo
di significato più cristiano.
Fig. 5 — Dettaglio della porta attribuita a Filippo Brunelleschi -
(Fotografia Alinari)
Firenze, Chiostro di Santa Croce