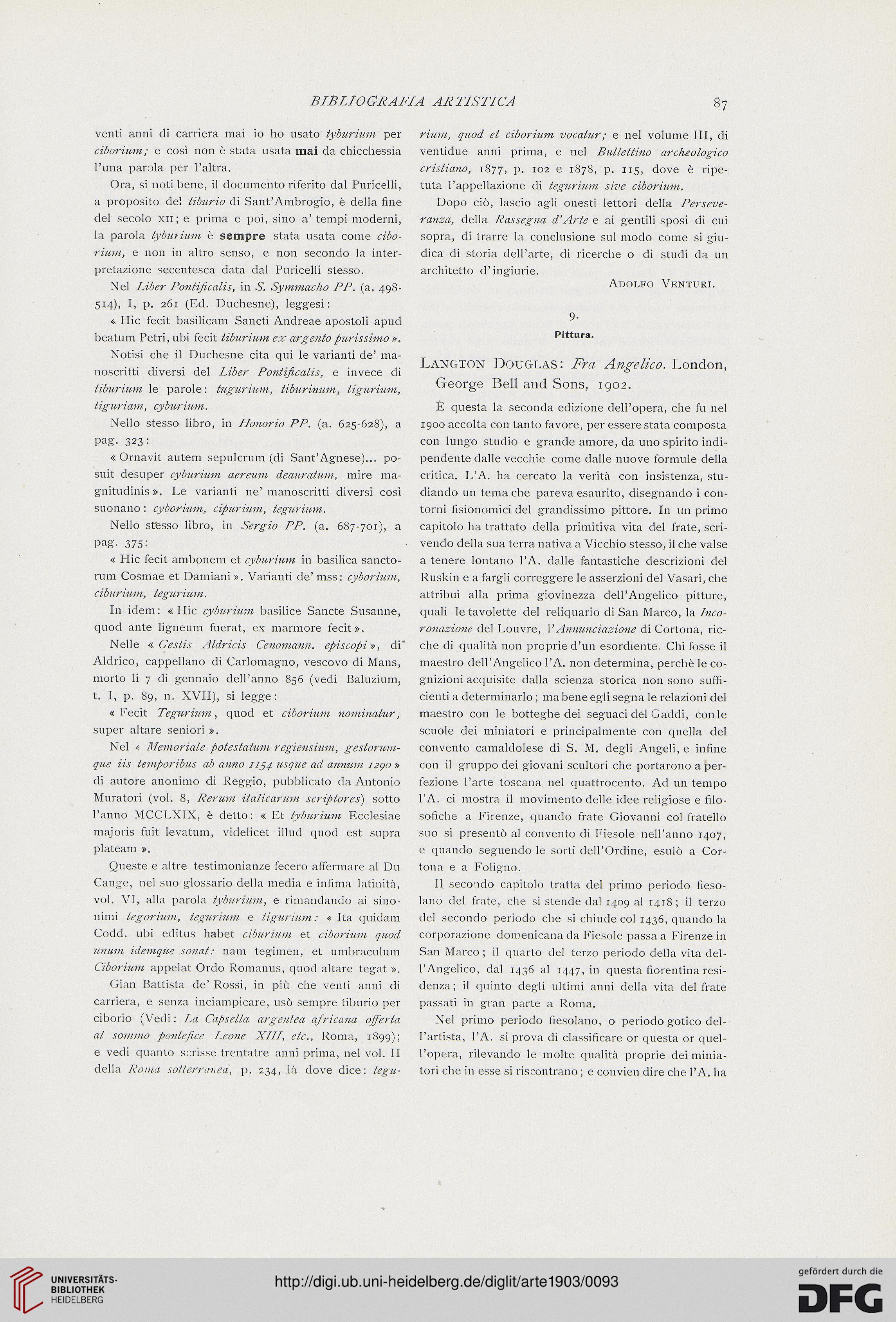BIBLIOGRAFIA ARTISTICA
87
venti anni di carriera mai io ho usato tyburìum per
cìborìum; e così non è stata usata mai da chicchessia
l’una parola per l’altra.
Ora, si noti bene, il documento riferito dal Puricelli,
a proposito de! tiburio di Sant’Ambrogio, è della fine
del secolo xil; e prima e poi, sino a’ tempi moderni,
la parola tyburium è sempre stata usata come cibo-
rium, e non in altro senso, e non secondo la inter-
pretazione secentesca data dal Puricelli stesso.
Nel Liber Pontìjìcalis, in .SI Symmacho PP. (a. 498-
514), I, p. 261 (Ed. Duchesne), leggesi :
« Hic fecit basilicam Sancti Andreae apostoli apud
beatum Petri, ubi fecit tìburìum ex argento purissimo ».
Notisi che il Duchesne cita qui le varianti de’ ma-
noscritti diversi del Liber Pontificalis, e invece di
tiburium le parole: tugurium, tiburinum, tigurium,
tiguriam, cyburium.
Nello stesso libro, in Honorio PP. (a. 625-628), a
pag. 323:
« Ornavit autem sepulcrum (di Sant’Agnese)... po-
suit desuper cyburium aereum deauratum, mire raa-
gnitudinis ». Le varianti ne’ manoscritti diversi così
suonano: cyborium, cipurium, tegurium.
Nello stèsso libro, in Sergio PP. (a. 687-701), a
pag. 375:
« Hic fecit ambonem et cyburium in basilica sancto-
rum Cosmae et Damiani ». Varianti de’ mss: cyborium,
ciburium, teguriutn.
In idem: «Hic cyburium basilice Sancte Susanne,
quod ante ligneum fuerat, ex marmore fecit».
Nelle « Gestis Aldricis Cenomann. episcopi », di’
Aidrico, cappellano di Carlomagno, vescovo di Mans,
morto li 7 di gennaio dell’anno 856 (vedi Baluzium,
t. I, p. 89, n. XVII), si legge:
«Fecit Tegurium, quod et ciborium nominatur,
super altare seniori ».
Nel « Memoriale potestatum regiensìum, gestorum-
que iis temporibus ab anno 1154 usque ad annum i2go »
di autore anonimo di Reggio, pubblicato da Antonio
Muratori (voi. 8, Rerum italicarum scriptores) sotto
l’anno MCCLXIX, è detto: « Et tyburium Ecclesiae
majoris fuit levatimi, videlicet illud quod est supra
plateam ».
Queste e altre testimonianze fecero affermare al Du
Cange, nel suo glossario della media e infima latinità,
voi. VI, alia parola tyburium, e rimandando ai sino-
nimi tegorium, tegurium e tigurium : « Ita quidam
Codd. ubi editus habet ciburium et ciborium quod
unum idemque sonat: nam tegimen, et umbraculum
Ciborium appelat Ordo Romanus, quod altare tegat ».
Gian Battista de’ Rossi, in più che venti anni di
carriera, e senza inciampicare, usò sempre tiburio per
ciborio (Vedi : La Capsella argentea africana offerta
al sommo pontefice Leone XIII, etc., Roma, 1899);
e vedi quanto scrisse trentatre anni prima, nel voi. II
della Roma sotterranea, p. 234, là dove dice: tegu-
rium, quod et ciborium vocatur; e nel volume III, di
ventidue anni prima, e nel Bullettino archeologico
cristiano, 1877, p. 102 e 1878, p. 115, dove è ripe-
tuta l’appellazione di tegurium sive ciborium.
Dopo ciò, lascio agli onesti lettori della Perseve-
ranza, della Rassegna d’Arte e ai gentili sposi di cui
sopra, di trarre la conclusione sul modo come si giu-
dica di storia dell’arte, di ricerche o di studi da un
architetto d’ingiurie.
Adolfo Venturi.
9-
Pittura.
Langton Douglas: Fra Angelico. London,
George Bell and Sons, 1902.
È questa la seconda edizione dell’opera, che fu nel
1900 accolta con tanto favore, per essere stata composta
con lungo studio e grande amore, da uno spirito indi-
pendente dalle vecchie come dalle nuove formule della
critica. L’A. ha cercato la verità con insistenza, stu-
diando un tema che pareva esaurito, disegnando i con-
torni fisionomici del grandissimo pittore. In un primo
capitolo ha trattato della primitiva vita del frate, scri-
vendo della sua terra nativa a Viccbio stesso, il che valse
a tenere lontano l’A. dalle fantastiche descrizioni del
Ruskin e a fargli correggere le asserzioni del Vasari, che
attribui alla prima giovinezza dell’Angelico pitture,
quali le tavolette del reliquario di San Marco, la Inco-
ronazione del Louvre, l’Annunciazione di Cortona, ric-
che di qualità non proprie d’un esordiente. Chi fosse il
maestro dell’Angelico l’A. non determina, perchè le co-
gnizioni acquisite dalla scienza storica non sono suffi-
cienti a determinarlo ; ma bene egli segna le relazioni del
maestro con le botteghe dei seguaci del Caddi, conle
scuole dei miniatori e principalmente con quella del
convento camaldolese di S. M. degli Angeli, e infine
con il gruppo dei giovani scultori che portarono a per-
fezione l’arte toscana nel quattrocento. Ad un tempo
l’A. ci mostra il movimento delle idee religiose e filo-
sofiche a Firenze, quando frate Giovanni col fratello
suo si presentò al convento di Fiesole nell’anno 1407,
e quando seguendo le sorti dell’Ordine, esulò a Cor-
tona e a Foligno.
Il secondo capitolo tratta del primo periodo fieso-
lano del frate, che si stende dal 1409 al 14r8 ; il terzo
del secondo periodo che si chiude col 1436, quando la
corporazione domenicana da Fiesole passa a Firenze in
San Marco ; il quarto del terzo periodo della vita del-
l’Angelico, dal 1436 al 1447, in questa fiorentina resi-
denza; il quinto degli ultimi anni della vita del frate
passati in gran parte a Roma.
Nel primo periodo fiesolano, o periodo gotico del-
l’artista, l’A. si prova di classificare or questa or quel-
l’opera, rilevando le molte qualità proprie dei minia-
tori che in esse si riscontrano ; e convien dire che l’A. ha
87
venti anni di carriera mai io ho usato tyburìum per
cìborìum; e così non è stata usata mai da chicchessia
l’una parola per l’altra.
Ora, si noti bene, il documento riferito dal Puricelli,
a proposito de! tiburio di Sant’Ambrogio, è della fine
del secolo xil; e prima e poi, sino a’ tempi moderni,
la parola tyburium è sempre stata usata come cibo-
rium, e non in altro senso, e non secondo la inter-
pretazione secentesca data dal Puricelli stesso.
Nel Liber Pontìjìcalis, in .SI Symmacho PP. (a. 498-
514), I, p. 261 (Ed. Duchesne), leggesi :
« Hic fecit basilicam Sancti Andreae apostoli apud
beatum Petri, ubi fecit tìburìum ex argento purissimo ».
Notisi che il Duchesne cita qui le varianti de’ ma-
noscritti diversi del Liber Pontificalis, e invece di
tiburium le parole: tugurium, tiburinum, tigurium,
tiguriam, cyburium.
Nello stesso libro, in Honorio PP. (a. 625-628), a
pag. 323:
« Ornavit autem sepulcrum (di Sant’Agnese)... po-
suit desuper cyburium aereum deauratum, mire raa-
gnitudinis ». Le varianti ne’ manoscritti diversi così
suonano: cyborium, cipurium, tegurium.
Nello stèsso libro, in Sergio PP. (a. 687-701), a
pag. 375:
« Hic fecit ambonem et cyburium in basilica sancto-
rum Cosmae et Damiani ». Varianti de’ mss: cyborium,
ciburium, teguriutn.
In idem: «Hic cyburium basilice Sancte Susanne,
quod ante ligneum fuerat, ex marmore fecit».
Nelle « Gestis Aldricis Cenomann. episcopi », di’
Aidrico, cappellano di Carlomagno, vescovo di Mans,
morto li 7 di gennaio dell’anno 856 (vedi Baluzium,
t. I, p. 89, n. XVII), si legge:
«Fecit Tegurium, quod et ciborium nominatur,
super altare seniori ».
Nel « Memoriale potestatum regiensìum, gestorum-
que iis temporibus ab anno 1154 usque ad annum i2go »
di autore anonimo di Reggio, pubblicato da Antonio
Muratori (voi. 8, Rerum italicarum scriptores) sotto
l’anno MCCLXIX, è detto: « Et tyburium Ecclesiae
majoris fuit levatimi, videlicet illud quod est supra
plateam ».
Queste e altre testimonianze fecero affermare al Du
Cange, nel suo glossario della media e infima latinità,
voi. VI, alia parola tyburium, e rimandando ai sino-
nimi tegorium, tegurium e tigurium : « Ita quidam
Codd. ubi editus habet ciburium et ciborium quod
unum idemque sonat: nam tegimen, et umbraculum
Ciborium appelat Ordo Romanus, quod altare tegat ».
Gian Battista de’ Rossi, in più che venti anni di
carriera, e senza inciampicare, usò sempre tiburio per
ciborio (Vedi : La Capsella argentea africana offerta
al sommo pontefice Leone XIII, etc., Roma, 1899);
e vedi quanto scrisse trentatre anni prima, nel voi. II
della Roma sotterranea, p. 234, là dove dice: tegu-
rium, quod et ciborium vocatur; e nel volume III, di
ventidue anni prima, e nel Bullettino archeologico
cristiano, 1877, p. 102 e 1878, p. 115, dove è ripe-
tuta l’appellazione di tegurium sive ciborium.
Dopo ciò, lascio agli onesti lettori della Perseve-
ranza, della Rassegna d’Arte e ai gentili sposi di cui
sopra, di trarre la conclusione sul modo come si giu-
dica di storia dell’arte, di ricerche o di studi da un
architetto d’ingiurie.
Adolfo Venturi.
9-
Pittura.
Langton Douglas: Fra Angelico. London,
George Bell and Sons, 1902.
È questa la seconda edizione dell’opera, che fu nel
1900 accolta con tanto favore, per essere stata composta
con lungo studio e grande amore, da uno spirito indi-
pendente dalle vecchie come dalle nuove formule della
critica. L’A. ha cercato la verità con insistenza, stu-
diando un tema che pareva esaurito, disegnando i con-
torni fisionomici del grandissimo pittore. In un primo
capitolo ha trattato della primitiva vita del frate, scri-
vendo della sua terra nativa a Viccbio stesso, il che valse
a tenere lontano l’A. dalle fantastiche descrizioni del
Ruskin e a fargli correggere le asserzioni del Vasari, che
attribui alla prima giovinezza dell’Angelico pitture,
quali le tavolette del reliquario di San Marco, la Inco-
ronazione del Louvre, l’Annunciazione di Cortona, ric-
che di qualità non proprie d’un esordiente. Chi fosse il
maestro dell’Angelico l’A. non determina, perchè le co-
gnizioni acquisite dalla scienza storica non sono suffi-
cienti a determinarlo ; ma bene egli segna le relazioni del
maestro con le botteghe dei seguaci del Caddi, conle
scuole dei miniatori e principalmente con quella del
convento camaldolese di S. M. degli Angeli, e infine
con il gruppo dei giovani scultori che portarono a per-
fezione l’arte toscana nel quattrocento. Ad un tempo
l’A. ci mostra il movimento delle idee religiose e filo-
sofiche a Firenze, quando frate Giovanni col fratello
suo si presentò al convento di Fiesole nell’anno 1407,
e quando seguendo le sorti dell’Ordine, esulò a Cor-
tona e a Foligno.
Il secondo capitolo tratta del primo periodo fieso-
lano del frate, che si stende dal 1409 al 14r8 ; il terzo
del secondo periodo che si chiude col 1436, quando la
corporazione domenicana da Fiesole passa a Firenze in
San Marco ; il quarto del terzo periodo della vita del-
l’Angelico, dal 1436 al 1447, in questa fiorentina resi-
denza; il quinto degli ultimi anni della vita del frate
passati in gran parte a Roma.
Nel primo periodo fiesolano, o periodo gotico del-
l’artista, l’A. si prova di classificare or questa or quel-
l’opera, rilevando le molte qualità proprie dei minia-
tori che in esse si riscontrano ; e convien dire che l’A. ha