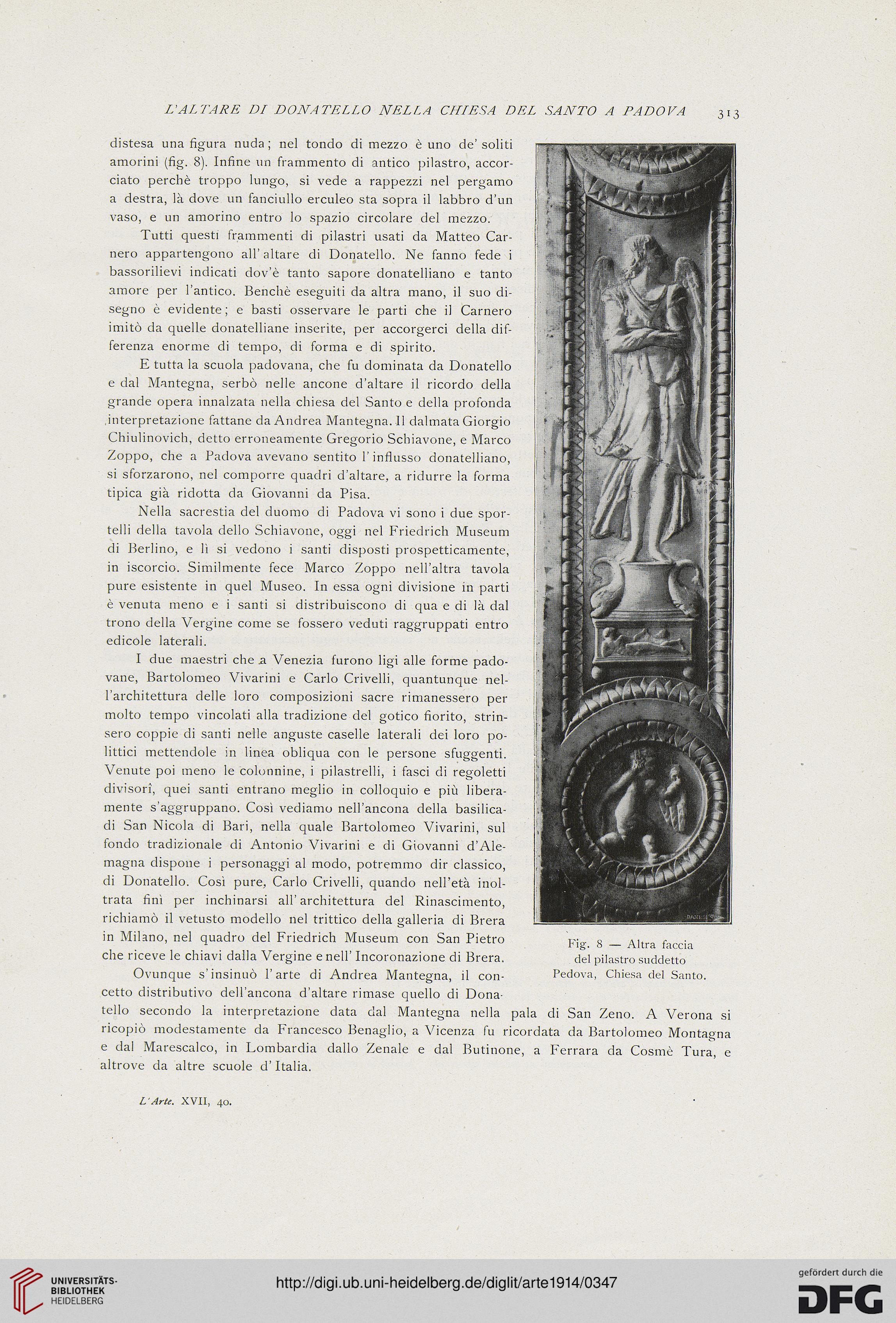L'ALTARE DI DONATELLO NELLA CHIESA DEL SANTO A PADOVA
3i3
distesa una figura nuda ; nel tondo di mezzo è uno de’ soliti
amorini (fig. 8). Infine un frammento di antico pilastro, accor-
ciato perchè troppo lungo, si vede a rappezzi nel pergamo
a destra, là dove un fanciullo erculeo sta sopra il labbro d’un
vaso, e un amorino entro lo spazio circolare del mezzo.
Tutti questi frammenti di pilastri usati da Matteo Car-
nero appartengono all’ altare di Donatello. Ne fanno fede i
bassorilievi indicati dov’è tanto sapore donatelliano e tanto
amore per l’antico. Benché eseguiti da altra mano, il suo di-
segno è evidente ; e basti osservare le parti che il Carnero
imitò da quelle donatelliane inserite, per accorgerci della dif-
ferenza enorme di tempo, di forma e di spirito.
E tutta la scuola padovana, che fu dominata da Donatello
e dal Mantegna, serbò nelle ancone d’altare il ricordo della
grande opera innalzata nella chiesa del Santo e della profonda
interpretazione fattane da Andrea Mantegna. Il dalmata Giorgio
Chiulinovich, detto erroneamente Gregorio Scbiavone, e Marco
Zoppo, che a Padova avevano sentito l’influsso donatelliano,
si sforzarono, nel comporre quadri d’altare, a ridurre la forma
tipica già ridotta da Giovanni da Pisa.
Nella sacrestia del duomo di Padova vi sono i due spor-
telli della tavola dello Schiavone, oggi nel Friedrich Museum
di Berlino, e lì si vedono i santi disposti prospetticamente,
in iscorcio. Similmente fece Marco Zoppo nell’altra tavola
pure esistente in quel Museo. In essa ogni divisione in parti
è venuta meno e i santi si distribuiscono di qua e di là dal
trono della Vergine come se fossero veduti raggruppati entro
edicole laterali.
I due maestri che a Venezia furono ligi alle forme pado-
vane, Bartolomeo Vivarini e Carlo Crivelli, quantunque nel-
l’architettura delle loro composizioni sacre rimanessero per
molto tempo vincolati alla tradizione del gotico fiorito, strin-
sero coppie di santi nelle anguste caselle laterali dei loro po-
littici mettendole in linea obliqua con le persone sfuggenti.
Venute poi meno le colonnine, i pilastrelli, i fasci di regoletti
divisori, quei santi entrano meglio in colloquio e più libera-
mente s’aggruppano. Così vediamo nell’ancona della basilica-
di San Nicola di Bari, nella quale Bartolomeo Vivarini, sul
fondo tradizionale di Antonio Vivarini e di Giovanni d’Ale-
magna dispone i personaggi al modo, potremmo dir classico,
di Donatello. Così pure, Carlo Crivelli, quando nell’età inol-
trata finì per inchinarsi all’ architettura del Rinascimento,
richiamò il vetusto modello nel trittico della galleria di Brera
in Milano, nel quadro del Friedrich Museum con San Pietro p;g._ 8 _ Altra faccia
che riceve le chiavi dalla Vergine e nell’ Incoronazione di Brera. del pilastro suddetto
Ovunque s’insinuò l’arte di Andrea Mantegna, il con- Pedova, Chiesa del Santo,
cetto distributivo dell’ancona d’altare rimase quello di Dona-
tello secondo la interpretazione data dal Mantegna nella pala di San Zeno. A Verona si
ricopiò modestamente da Francesco Benaglio, a Vicenza fu ricordata da Bartolomeo Montagna
e dal Marescalco, in Lombardia dallo Zenale e dal Bufinone, a Ferrara da Cosmè Tura, e
altrove da altre scuole d’Italia.
L'Arte. XVII, 40.
3i3
distesa una figura nuda ; nel tondo di mezzo è uno de’ soliti
amorini (fig. 8). Infine un frammento di antico pilastro, accor-
ciato perchè troppo lungo, si vede a rappezzi nel pergamo
a destra, là dove un fanciullo erculeo sta sopra il labbro d’un
vaso, e un amorino entro lo spazio circolare del mezzo.
Tutti questi frammenti di pilastri usati da Matteo Car-
nero appartengono all’ altare di Donatello. Ne fanno fede i
bassorilievi indicati dov’è tanto sapore donatelliano e tanto
amore per l’antico. Benché eseguiti da altra mano, il suo di-
segno è evidente ; e basti osservare le parti che il Carnero
imitò da quelle donatelliane inserite, per accorgerci della dif-
ferenza enorme di tempo, di forma e di spirito.
E tutta la scuola padovana, che fu dominata da Donatello
e dal Mantegna, serbò nelle ancone d’altare il ricordo della
grande opera innalzata nella chiesa del Santo e della profonda
interpretazione fattane da Andrea Mantegna. Il dalmata Giorgio
Chiulinovich, detto erroneamente Gregorio Scbiavone, e Marco
Zoppo, che a Padova avevano sentito l’influsso donatelliano,
si sforzarono, nel comporre quadri d’altare, a ridurre la forma
tipica già ridotta da Giovanni da Pisa.
Nella sacrestia del duomo di Padova vi sono i due spor-
telli della tavola dello Schiavone, oggi nel Friedrich Museum
di Berlino, e lì si vedono i santi disposti prospetticamente,
in iscorcio. Similmente fece Marco Zoppo nell’altra tavola
pure esistente in quel Museo. In essa ogni divisione in parti
è venuta meno e i santi si distribuiscono di qua e di là dal
trono della Vergine come se fossero veduti raggruppati entro
edicole laterali.
I due maestri che a Venezia furono ligi alle forme pado-
vane, Bartolomeo Vivarini e Carlo Crivelli, quantunque nel-
l’architettura delle loro composizioni sacre rimanessero per
molto tempo vincolati alla tradizione del gotico fiorito, strin-
sero coppie di santi nelle anguste caselle laterali dei loro po-
littici mettendole in linea obliqua con le persone sfuggenti.
Venute poi meno le colonnine, i pilastrelli, i fasci di regoletti
divisori, quei santi entrano meglio in colloquio e più libera-
mente s’aggruppano. Così vediamo nell’ancona della basilica-
di San Nicola di Bari, nella quale Bartolomeo Vivarini, sul
fondo tradizionale di Antonio Vivarini e di Giovanni d’Ale-
magna dispone i personaggi al modo, potremmo dir classico,
di Donatello. Così pure, Carlo Crivelli, quando nell’età inol-
trata finì per inchinarsi all’ architettura del Rinascimento,
richiamò il vetusto modello nel trittico della galleria di Brera
in Milano, nel quadro del Friedrich Museum con San Pietro p;g._ 8 _ Altra faccia
che riceve le chiavi dalla Vergine e nell’ Incoronazione di Brera. del pilastro suddetto
Ovunque s’insinuò l’arte di Andrea Mantegna, il con- Pedova, Chiesa del Santo,
cetto distributivo dell’ancona d’altare rimase quello di Dona-
tello secondo la interpretazione data dal Mantegna nella pala di San Zeno. A Verona si
ricopiò modestamente da Francesco Benaglio, a Vicenza fu ricordata da Bartolomeo Montagna
e dal Marescalco, in Lombardia dallo Zenale e dal Bufinone, a Ferrara da Cosmè Tura, e
altrove da altre scuole d’Italia.
L'Arte. XVII, 40.