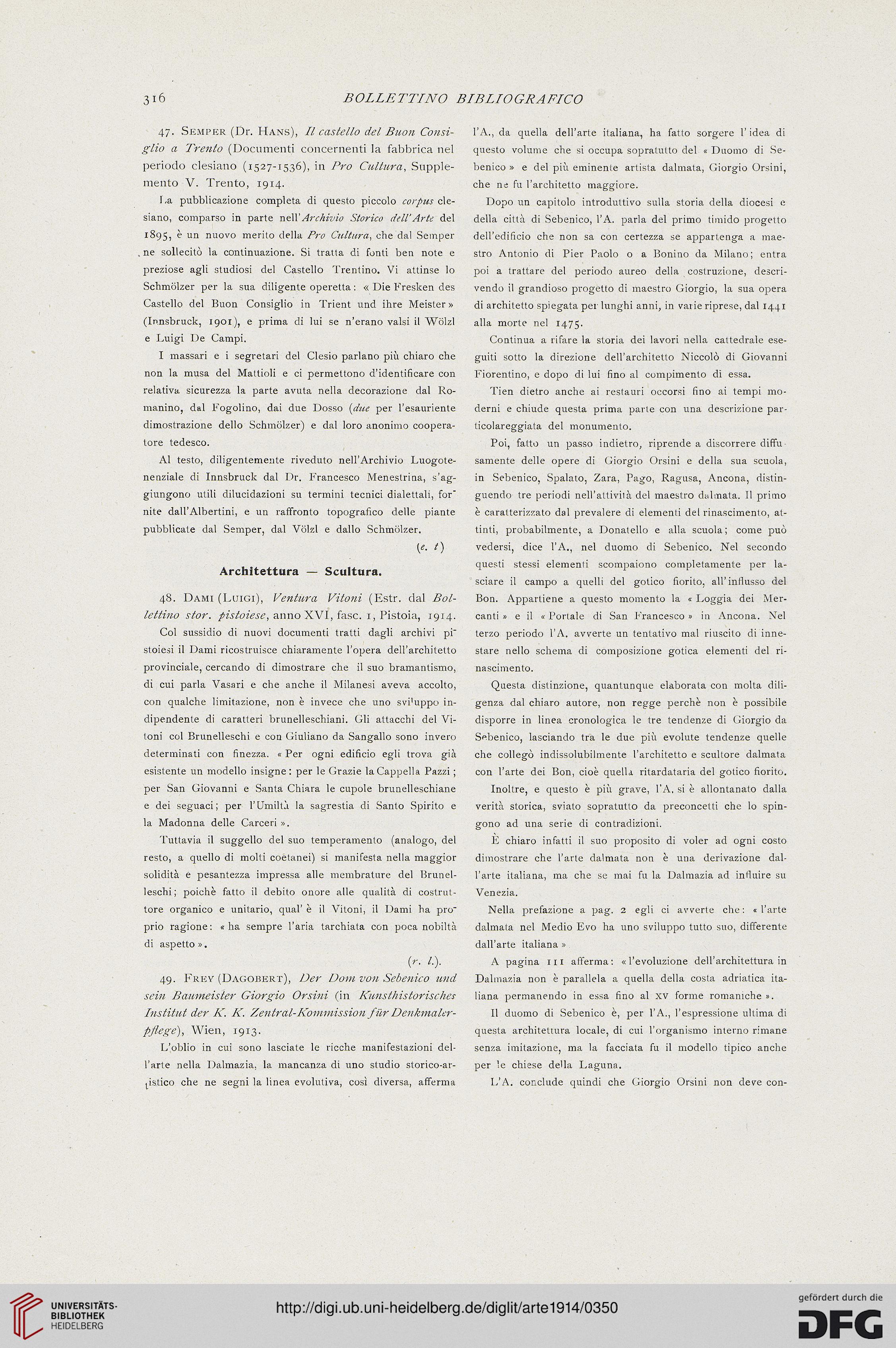316
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
47. Sempp;r (Dr. Hans), Il castello del Buon Consi-
glio a Trento (Documenti concernenti la fabbrica nel
periodo desiano (1527-1536), in Pro Cultura, Supple-
mento V. Trento, 1914.
La pubblicazione completa di questo piccolo corpus de-
siano, comparso in parte ne\YArchivio Storico dell’Arte del
1895, è un nuovo merito della Pro Cultura, che dal Seinper
ne sollecitò la continuazione. Si tratta di fonti ben note e
preziose agli studiosi del Castello Trentino. Vi attinse lo
Schmolzer per la sua diligente operetta : « Die Fresken des
Castello del Buon Consiglio in Trient und ihre Meister »
(In.nsbruck, 1901), e prima di lui se n’erano valsi il Wòlzl
e Luigi De Campi.
I massari e i segretari del Clesio parlano più chiaro che
non la musa del Mattioli e ci permettono d’identificare con
relativa sicurezza la parte avuta nella decorazione dal Ro-
manino, dal Fogolino, dai due Dosso (due per l’esauriente
dimostrazione dello Schmolzer) e dal loro anonimo coopera-
tore tedesco.
Al testo, diligentemente riveduto nell’Archivio Luogote-
nenziale di Innsbruck dal Dr. Francesco Menestrina, s’ag-
giungono utili dilucidazioni su termini tecnici dialettali, for'
nite dall’Albertini, e un raffronto topografico delle piante
pubblicate dal Semper, dal Volzl e dallo Schmolzer.
[e. t)
Architettura — Scultura.
48. Dami (Luigi), Ventura Vitoni (Estr. dal Bol-
lettino stor. pistoiese, anno XVI, fase. 1, Pistoia, 1914.
Col sussidio di nuovi documenti tratti dagli archivi pi'
stoiesi il Dami ricostruisce chiaramente l’opera dell’architetto
provinciale, cercando di dimostrare che il suo bramantismo,
di cui parla Vasari e che anche il Milanesi aveva accolto,
con qualche limitazione, non è invece che uno svi’uppo in-
dipendente di caratteri brunelleschiani. Gli attacchi del Vi-
toni col Brunelleschi e con Giuliano da Sangallo sono invero
determinati con finezza. « Per ogni edificio egli trova già
esistente un modello insigne: per le Grazie la Cappella Pazzi ;
per San Giovanni e Santa Chiara le cupole brunelleschiane
e dei seguaci; per l’Umiltà la sagrestia di Santo Spirito e
la Madonna delle Carceri».
Tuttavia il suggello del suo temperamento (analogo, del
resto, a quello di molti coetanei) si manifesta nella maggior
solidità è pesantezza impressa alle membrature del Brunel-
leschi ; poiché fatto il debito onore alle qualità di costrut-
tore organico e unitario, qual’ è il Vitoni, il Dami ha prò"
prio ragione: «ha sempre l’aria tarchiata con poca nobiltà
di aspetto ».
{r. /.).
49. Frey (Dagobert), Der Dom von Sebenico und
sein Baumeister Giorgio Orsini (in Kunsthistorisches
Institut der K. K. 'Zentral-Kommission fìir Denkmaler-
pflege), Wien, 1913.
L’oblio in cui sono lasciate le ricche manifestazioni del-
l’arte nella Dalmazia, la mancanza di uno studio storico-ar-
tistico che ne segni la linea evolutiva, così diversa, afferma
l’A., da quella dell’arte italiana, ha fatto sorgere l’idea di
questo volume che si occupa sopratutto del « Duomo di Se-
benico » e del più eminente artista dalmata, Giorgio Orsini,
che ne fu l’architetto maggiore.
Dopo un capitolo introduttivo sulla storia della diocesi e
della città di Sebenico, l’A. parla del primo timido progetto
dell’edificio che non sa con certezza se appartenga a mae-
stro Antonio di Pier Paolo o a Bonino da Milano; entra
poi a trattare del periodo aureo della costruzione, descri-
vendo il grandioso progetto di maestro Giorgio, la sua opera
di architetto spiegata per lunghi anni, in varie riprese, dal 1441
alla morte nel 1475.
Continua a rifare la storia dei lavori nella cattedrale ese-
guiti sotto la direzione dell’architetto Niccolò di Giovanni
Fiorentino, e dopo di lui fino al compimento di essa.
Tien dietro anche ai restauri occorsi fino ai tempi mo-
derni e chiude questa prima parte con una descrizione par-
ticolareggiata del monumento.
Poi, fatto un passo indietro, riprende a discorrere diffu
samente delle opere di Giorgio Orsini e della sua scuola,
in Sebenico, Spalato, Zara, Pago, Ragusa, Ancona, distin-
guendo tre periodi nell’attivilà del maestro dalmata. Il primo
è caratterizzato dal prevalere di elementi del rinascimento, at-
tinti, probabilmente, a Donatello e alla scuola; come può
vedersi, dice l’A., nel duomo di Sebenico. Nel secondo
questi stessi elementi scompaiono completamente per la-
sciare il campo a quelli del gotico fiorito, all’influsso del
Bon. Appartiene a questo momento la « Loggia dei Mer-
canti » e il « Portale di San Francesco » in Ancona. Nel
terzo periodo l’A. avverte un tentativo mal riuscito di inne-
stare nello schema di composizione gotica elementi del ri-
nascimento.
Questa distinzione, quantunque elaborata con molta dili-
genza dal chiaro autore, non regge perchè non è possibile
disporre in linea cronologica le tre tendenze di Giorgio da
Sebenico, lasciando tra le due più evolute tendenze quelle
che collegò indissolubilmente l’architetto e scultore dalmata
con l’arte dei Bon, cioè quella ritardataria del gotico fiorito.
Inoltre, e questo è più grave, l’A. si è allontanato dalla
verità storica, sviato sopratutto da preconcetti che lo spin-
gono ad una serie di contradizioni.
E chiaro infatti il suo proposito di voler ad ogni costo
dimostrare che l’arte dalmata non è una derivazione dal-
l’arte italiana, ma che se mai fu la Dalmazia ad influire su
Venezia.
Nella prefazione a pag. 2 egli ci avverte che: «l’arte
dalmata nel Medio Evo ha uno sviluppo tutto suo, differente
dall’arte italiana »
A pagina ni afferma: «l’evoluzione dell’architettura in
Dalmazia non è parallela a quella della costa adriatica ita-
liana permanendo in essa fino al xv forme romaniche ».
Il duomo di Sebenico è, per l’A., l’espressione ultima di
questa architettura locale, di cui l’organismo interno rimane
senza imitazione, ma la facciata fu il modello tipico anche
per le chiese della Laguna.
L’A. conclude quindi che Giorgio Orsini non deve con-
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
47. Sempp;r (Dr. Hans), Il castello del Buon Consi-
glio a Trento (Documenti concernenti la fabbrica nel
periodo desiano (1527-1536), in Pro Cultura, Supple-
mento V. Trento, 1914.
La pubblicazione completa di questo piccolo corpus de-
siano, comparso in parte ne\YArchivio Storico dell’Arte del
1895, è un nuovo merito della Pro Cultura, che dal Seinper
ne sollecitò la continuazione. Si tratta di fonti ben note e
preziose agli studiosi del Castello Trentino. Vi attinse lo
Schmolzer per la sua diligente operetta : « Die Fresken des
Castello del Buon Consiglio in Trient und ihre Meister »
(In.nsbruck, 1901), e prima di lui se n’erano valsi il Wòlzl
e Luigi De Campi.
I massari e i segretari del Clesio parlano più chiaro che
non la musa del Mattioli e ci permettono d’identificare con
relativa sicurezza la parte avuta nella decorazione dal Ro-
manino, dal Fogolino, dai due Dosso (due per l’esauriente
dimostrazione dello Schmolzer) e dal loro anonimo coopera-
tore tedesco.
Al testo, diligentemente riveduto nell’Archivio Luogote-
nenziale di Innsbruck dal Dr. Francesco Menestrina, s’ag-
giungono utili dilucidazioni su termini tecnici dialettali, for'
nite dall’Albertini, e un raffronto topografico delle piante
pubblicate dal Semper, dal Volzl e dallo Schmolzer.
[e. t)
Architettura — Scultura.
48. Dami (Luigi), Ventura Vitoni (Estr. dal Bol-
lettino stor. pistoiese, anno XVI, fase. 1, Pistoia, 1914.
Col sussidio di nuovi documenti tratti dagli archivi pi'
stoiesi il Dami ricostruisce chiaramente l’opera dell’architetto
provinciale, cercando di dimostrare che il suo bramantismo,
di cui parla Vasari e che anche il Milanesi aveva accolto,
con qualche limitazione, non è invece che uno svi’uppo in-
dipendente di caratteri brunelleschiani. Gli attacchi del Vi-
toni col Brunelleschi e con Giuliano da Sangallo sono invero
determinati con finezza. « Per ogni edificio egli trova già
esistente un modello insigne: per le Grazie la Cappella Pazzi ;
per San Giovanni e Santa Chiara le cupole brunelleschiane
e dei seguaci; per l’Umiltà la sagrestia di Santo Spirito e
la Madonna delle Carceri».
Tuttavia il suggello del suo temperamento (analogo, del
resto, a quello di molti coetanei) si manifesta nella maggior
solidità è pesantezza impressa alle membrature del Brunel-
leschi ; poiché fatto il debito onore alle qualità di costrut-
tore organico e unitario, qual’ è il Vitoni, il Dami ha prò"
prio ragione: «ha sempre l’aria tarchiata con poca nobiltà
di aspetto ».
{r. /.).
49. Frey (Dagobert), Der Dom von Sebenico und
sein Baumeister Giorgio Orsini (in Kunsthistorisches
Institut der K. K. 'Zentral-Kommission fìir Denkmaler-
pflege), Wien, 1913.
L’oblio in cui sono lasciate le ricche manifestazioni del-
l’arte nella Dalmazia, la mancanza di uno studio storico-ar-
tistico che ne segni la linea evolutiva, così diversa, afferma
l’A., da quella dell’arte italiana, ha fatto sorgere l’idea di
questo volume che si occupa sopratutto del « Duomo di Se-
benico » e del più eminente artista dalmata, Giorgio Orsini,
che ne fu l’architetto maggiore.
Dopo un capitolo introduttivo sulla storia della diocesi e
della città di Sebenico, l’A. parla del primo timido progetto
dell’edificio che non sa con certezza se appartenga a mae-
stro Antonio di Pier Paolo o a Bonino da Milano; entra
poi a trattare del periodo aureo della costruzione, descri-
vendo il grandioso progetto di maestro Giorgio, la sua opera
di architetto spiegata per lunghi anni, in varie riprese, dal 1441
alla morte nel 1475.
Continua a rifare la storia dei lavori nella cattedrale ese-
guiti sotto la direzione dell’architetto Niccolò di Giovanni
Fiorentino, e dopo di lui fino al compimento di essa.
Tien dietro anche ai restauri occorsi fino ai tempi mo-
derni e chiude questa prima parte con una descrizione par-
ticolareggiata del monumento.
Poi, fatto un passo indietro, riprende a discorrere diffu
samente delle opere di Giorgio Orsini e della sua scuola,
in Sebenico, Spalato, Zara, Pago, Ragusa, Ancona, distin-
guendo tre periodi nell’attivilà del maestro dalmata. Il primo
è caratterizzato dal prevalere di elementi del rinascimento, at-
tinti, probabilmente, a Donatello e alla scuola; come può
vedersi, dice l’A., nel duomo di Sebenico. Nel secondo
questi stessi elementi scompaiono completamente per la-
sciare il campo a quelli del gotico fiorito, all’influsso del
Bon. Appartiene a questo momento la « Loggia dei Mer-
canti » e il « Portale di San Francesco » in Ancona. Nel
terzo periodo l’A. avverte un tentativo mal riuscito di inne-
stare nello schema di composizione gotica elementi del ri-
nascimento.
Questa distinzione, quantunque elaborata con molta dili-
genza dal chiaro autore, non regge perchè non è possibile
disporre in linea cronologica le tre tendenze di Giorgio da
Sebenico, lasciando tra le due più evolute tendenze quelle
che collegò indissolubilmente l’architetto e scultore dalmata
con l’arte dei Bon, cioè quella ritardataria del gotico fiorito.
Inoltre, e questo è più grave, l’A. si è allontanato dalla
verità storica, sviato sopratutto da preconcetti che lo spin-
gono ad una serie di contradizioni.
E chiaro infatti il suo proposito di voler ad ogni costo
dimostrare che l’arte dalmata non è una derivazione dal-
l’arte italiana, ma che se mai fu la Dalmazia ad influire su
Venezia.
Nella prefazione a pag. 2 egli ci avverte che: «l’arte
dalmata nel Medio Evo ha uno sviluppo tutto suo, differente
dall’arte italiana »
A pagina ni afferma: «l’evoluzione dell’architettura in
Dalmazia non è parallela a quella della costa adriatica ita-
liana permanendo in essa fino al xv forme romaniche ».
Il duomo di Sebenico è, per l’A., l’espressione ultima di
questa architettura locale, di cui l’organismo interno rimane
senza imitazione, ma la facciata fu il modello tipico anche
per le chiese della Laguna.
L’A. conclude quindi che Giorgio Orsini non deve con-