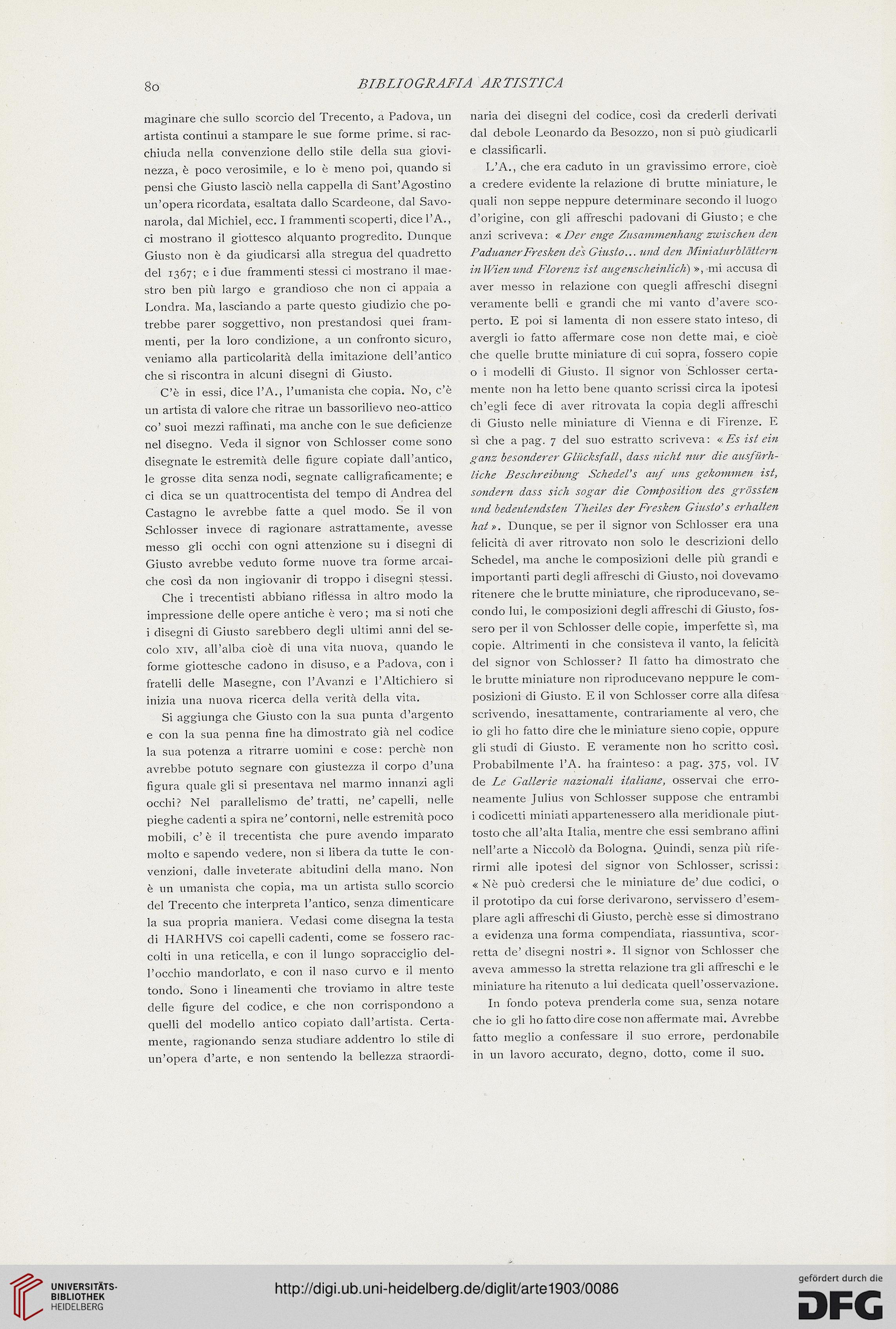8o
BIBLIOGRAFIA ARTISTICA
maginare che sullo scorcio del Trecento, a Padova, un
artista continui a stampare le sue forme prime, si rac-
chiuda nella convenzione dello stile della sua giovi-
nezza, è poco verosimile, e lo è meno poi, quando si
pensi che Giusto lasciò nella cappella di Sant’Agostino
un’opera ricordata, esaltata dallo Scardeone, dal Savo-
narola, dal Michiel, ecc. I frammenti scoperti, dice l’A.,
ci mostrano il giottesco alquanto progredito. Dunque
Giusto non è da giudicarsi alla stregua del quadretto
del 1367; e i due frammenti stessi ci mostrano il mae-
stro ben più largo e grandioso che non ci appaia a
Londra. Ma, lasciando a parte questo giudizio che po-
trebbe parer soggettivo, non prestandosi quei fram-
menti, per la loro condizione, a un confronto sicuro,
veniamo alla particolarità della imitazione dell’antico
che si riscontra in alcuni disegni di Giusto.
C’è in essi, dice l’A., l’umanista che copia. No, c’è
un artista di valore che ritrae un bassorilievo neo-attico
co’ suoi mezzi raffinati, ma anche con le sue deficienze
nel disegno. Veda il signor von Schlosser come sono
disegnate le estremità delle figure copiate dall’antico,
le grosse dita senza nodi, segnate calligraficamente; e
ci dica se un quattrocentista del tempo di Andrea del
Castagno le avrebbe fatte a quel modo. Se il von
Schlosser invece di ragionare astrattamente, avesse
messo gli occhi con ogni attenzione su i disegni di
Giusto avrebbe veduto forme nuove tra forme arcai-
che così da non ingiovanir di troppo i disegni stessi.
Che i trecentisti abbiano riflessa in altro modo la
impressione delle opere antiche è vero; ma si noti che
i disegni di Giusto sarebbero degli ultimi anni del se-
colo xiv, all’alba cioè di una vita nuova, quando le
forme giottesche cadono in disuso, e a Padova, con i
fratelli delle Masegne, con l’Avanzi e l’Altichiero si
inizia una nuova ricerca della verità della vita.
Si aggiunga che Giusto con la sua punta d’argento
e con la sua penna fine ha dimostrato già nel codice
la sua potenza a ritrarre uomini e cose: perchè non
avrebbe potuto segnare con giustezza il corpo d’una
figura quale gli si presentava nel marmo innanzi agli
occhi? Nel parallelismo de’tratti, ne’capelli, nelle
pieghe cadenti a spira ne’ contorni, nelle estremità poco
mobili, c’è il trecentista che pure avendo imparato
molto e sapendo vedere, non si libera da tutte le con-
venzioni, dalle inveterate abitudini della mano. Non
è un umanista che copia, ma un artista sullo scorcio
del Trecento che interpreta l’antico, senza dimenticare
la sua propria maniera. Vedasi come disegna la testa
di HARHVS coi capelli cadenti, come se fossero rac-
colti in una reticella, e con il lungo sopracciglio del-
l’occhio mandorlato, e con il naso curvo e il mento
tondo. Sono i lineamenti che troviamo in altre teste
delle figure del codice, e che non corrispondono a
quelli del modello antico copiato dall’artista. Certa-
mente, ragionando senza studiare addentro lo stile di
un’opera d’arte, e non sentendo la bellezza straordi-
naria dei disegni del codice, così da crederli derivati
dal debole Leonardo da Besozzo, non si può giudicarli
e classificarli.
L’A., che era caduto in un gravissimo errore, cioè
a credere evidente la relazione di brutte miniature, le
quali non seppe neppure determinare secondo il luogo
d’origine, con gli affreschi padovani di Giusto; e che
anzi scriveva : « Der enge Zusammenhang zwìschen den
PaduanerFresken des Giusto... und den Miniaturbldttern
in Wien und Florenz ist augenscheinlich) », mi accusa di
aver messo in relazione con quegli affreschi disegni
veramente belli e grandi che mi vanto d’avere sco-
perto. E poi si lamenta di non essere stato inteso, di
avergli io fatto affermare cose non dette mai, e cioè
che quelle brutte miniature di cui sopra, fossero copie
0 i modelli di Giusto. Il signor von Schlosser certa-
mente non ha letto bene quanto scrissi circa la ipotesi
ch’egli fece di aver ritrovata la copia degli affreschi
di Giusto nelle miniature di Vienna e di Firenze. E
si che a pag. 7 del suo estratto scriveva: «Es ist ein
ganz besonderer GLùcksfall, dass nicht nur die ausfùrh-
liche Beschreibung Schedel’s ciuf uns gekommen ist,
sondern dass sich sogar die Composition des grossten
und bedeutendsten Theìles der Fresken Giusto’ s erhalten
fiat». Dunque, se per il signor von Schlosser era una
felicità di aver ritrovato non solo le descrizioni dello
Schedel, ma anche le composizioni delle più grandi e
importanti parti degli affreschi di Giusto, noi dovevamo
ritenere che le brutte miniature, che riproducevano, se-
condo lui, le composizioni degli affreschi di Giusto, fos-
sero per il von Schlosser delle copie, imperfette sì, ma
copie. Altrimenti in che consisteva il vanto, la felicità
del signor von Schlosser? Il fatto ha dimostrato che
le brutte miniature non riproducevano neppure le com-
posizioni di Giusto. E il von Schlosser corre alla difesa
scrivendo, inesattamente, contrariamente al vero, che
10 gli ho fatto dire che le miniature sieno copie, oppure
gli studi di Giusto. E veramente non ho scritto così.
Probabilmente l’A. ha frainteso: a pag. 375, voi. IV
de Le Gallerie nazionali italiane, osservai che erro-
neamente Julius von Schlosser suppose che entrambi
1 codicetti miniati appartenessero alla meridionale piut-
tosto che all’alta Italia, mentre che essi sembrano affini
nell’arte a Niccolò da Bologna. Quindi, senza più rife-
rirmi alle ipotesi del signor von Schlosser, scrissi:
«Nè può credersi che le miniature de’ due codici, o
11 prototipo da cui forse derivarono, servissero d’esem-
plare agli affreschi di Giusto, perchè esse si dimostrano
a evidenza una forma compendiata, riassuntiva, scor-
retta de’ disegni nostri ». Il signor von Schlosser che
aveva ammesso la stretta relazione tra gli affreschi e le
miniature ha ritenuto a lui dedicata quell’osservazione.
In fondo poteva prenderla come sua, senza notare
che io gli ho fatto dire cose non affermate mai. Avrebbe
fatto meglio a confessare il suo errore, perdonabile
in un lavoro accurato, degno, dotto, come il suo.
BIBLIOGRAFIA ARTISTICA
maginare che sullo scorcio del Trecento, a Padova, un
artista continui a stampare le sue forme prime, si rac-
chiuda nella convenzione dello stile della sua giovi-
nezza, è poco verosimile, e lo è meno poi, quando si
pensi che Giusto lasciò nella cappella di Sant’Agostino
un’opera ricordata, esaltata dallo Scardeone, dal Savo-
narola, dal Michiel, ecc. I frammenti scoperti, dice l’A.,
ci mostrano il giottesco alquanto progredito. Dunque
Giusto non è da giudicarsi alla stregua del quadretto
del 1367; e i due frammenti stessi ci mostrano il mae-
stro ben più largo e grandioso che non ci appaia a
Londra. Ma, lasciando a parte questo giudizio che po-
trebbe parer soggettivo, non prestandosi quei fram-
menti, per la loro condizione, a un confronto sicuro,
veniamo alla particolarità della imitazione dell’antico
che si riscontra in alcuni disegni di Giusto.
C’è in essi, dice l’A., l’umanista che copia. No, c’è
un artista di valore che ritrae un bassorilievo neo-attico
co’ suoi mezzi raffinati, ma anche con le sue deficienze
nel disegno. Veda il signor von Schlosser come sono
disegnate le estremità delle figure copiate dall’antico,
le grosse dita senza nodi, segnate calligraficamente; e
ci dica se un quattrocentista del tempo di Andrea del
Castagno le avrebbe fatte a quel modo. Se il von
Schlosser invece di ragionare astrattamente, avesse
messo gli occhi con ogni attenzione su i disegni di
Giusto avrebbe veduto forme nuove tra forme arcai-
che così da non ingiovanir di troppo i disegni stessi.
Che i trecentisti abbiano riflessa in altro modo la
impressione delle opere antiche è vero; ma si noti che
i disegni di Giusto sarebbero degli ultimi anni del se-
colo xiv, all’alba cioè di una vita nuova, quando le
forme giottesche cadono in disuso, e a Padova, con i
fratelli delle Masegne, con l’Avanzi e l’Altichiero si
inizia una nuova ricerca della verità della vita.
Si aggiunga che Giusto con la sua punta d’argento
e con la sua penna fine ha dimostrato già nel codice
la sua potenza a ritrarre uomini e cose: perchè non
avrebbe potuto segnare con giustezza il corpo d’una
figura quale gli si presentava nel marmo innanzi agli
occhi? Nel parallelismo de’tratti, ne’capelli, nelle
pieghe cadenti a spira ne’ contorni, nelle estremità poco
mobili, c’è il trecentista che pure avendo imparato
molto e sapendo vedere, non si libera da tutte le con-
venzioni, dalle inveterate abitudini della mano. Non
è un umanista che copia, ma un artista sullo scorcio
del Trecento che interpreta l’antico, senza dimenticare
la sua propria maniera. Vedasi come disegna la testa
di HARHVS coi capelli cadenti, come se fossero rac-
colti in una reticella, e con il lungo sopracciglio del-
l’occhio mandorlato, e con il naso curvo e il mento
tondo. Sono i lineamenti che troviamo in altre teste
delle figure del codice, e che non corrispondono a
quelli del modello antico copiato dall’artista. Certa-
mente, ragionando senza studiare addentro lo stile di
un’opera d’arte, e non sentendo la bellezza straordi-
naria dei disegni del codice, così da crederli derivati
dal debole Leonardo da Besozzo, non si può giudicarli
e classificarli.
L’A., che era caduto in un gravissimo errore, cioè
a credere evidente la relazione di brutte miniature, le
quali non seppe neppure determinare secondo il luogo
d’origine, con gli affreschi padovani di Giusto; e che
anzi scriveva : « Der enge Zusammenhang zwìschen den
PaduanerFresken des Giusto... und den Miniaturbldttern
in Wien und Florenz ist augenscheinlich) », mi accusa di
aver messo in relazione con quegli affreschi disegni
veramente belli e grandi che mi vanto d’avere sco-
perto. E poi si lamenta di non essere stato inteso, di
avergli io fatto affermare cose non dette mai, e cioè
che quelle brutte miniature di cui sopra, fossero copie
0 i modelli di Giusto. Il signor von Schlosser certa-
mente non ha letto bene quanto scrissi circa la ipotesi
ch’egli fece di aver ritrovata la copia degli affreschi
di Giusto nelle miniature di Vienna e di Firenze. E
si che a pag. 7 del suo estratto scriveva: «Es ist ein
ganz besonderer GLùcksfall, dass nicht nur die ausfùrh-
liche Beschreibung Schedel’s ciuf uns gekommen ist,
sondern dass sich sogar die Composition des grossten
und bedeutendsten Theìles der Fresken Giusto’ s erhalten
fiat». Dunque, se per il signor von Schlosser era una
felicità di aver ritrovato non solo le descrizioni dello
Schedel, ma anche le composizioni delle più grandi e
importanti parti degli affreschi di Giusto, noi dovevamo
ritenere che le brutte miniature, che riproducevano, se-
condo lui, le composizioni degli affreschi di Giusto, fos-
sero per il von Schlosser delle copie, imperfette sì, ma
copie. Altrimenti in che consisteva il vanto, la felicità
del signor von Schlosser? Il fatto ha dimostrato che
le brutte miniature non riproducevano neppure le com-
posizioni di Giusto. E il von Schlosser corre alla difesa
scrivendo, inesattamente, contrariamente al vero, che
10 gli ho fatto dire che le miniature sieno copie, oppure
gli studi di Giusto. E veramente non ho scritto così.
Probabilmente l’A. ha frainteso: a pag. 375, voi. IV
de Le Gallerie nazionali italiane, osservai che erro-
neamente Julius von Schlosser suppose che entrambi
1 codicetti miniati appartenessero alla meridionale piut-
tosto che all’alta Italia, mentre che essi sembrano affini
nell’arte a Niccolò da Bologna. Quindi, senza più rife-
rirmi alle ipotesi del signor von Schlosser, scrissi:
«Nè può credersi che le miniature de’ due codici, o
11 prototipo da cui forse derivarono, servissero d’esem-
plare agli affreschi di Giusto, perchè esse si dimostrano
a evidenza una forma compendiata, riassuntiva, scor-
retta de’ disegni nostri ». Il signor von Schlosser che
aveva ammesso la stretta relazione tra gli affreschi e le
miniature ha ritenuto a lui dedicata quell’osservazione.
In fondo poteva prenderla come sua, senza notare
che io gli ho fatto dire cose non affermate mai. Avrebbe
fatto meglio a confessare il suo errore, perdonabile
in un lavoro accurato, degno, dotto, come il suo.