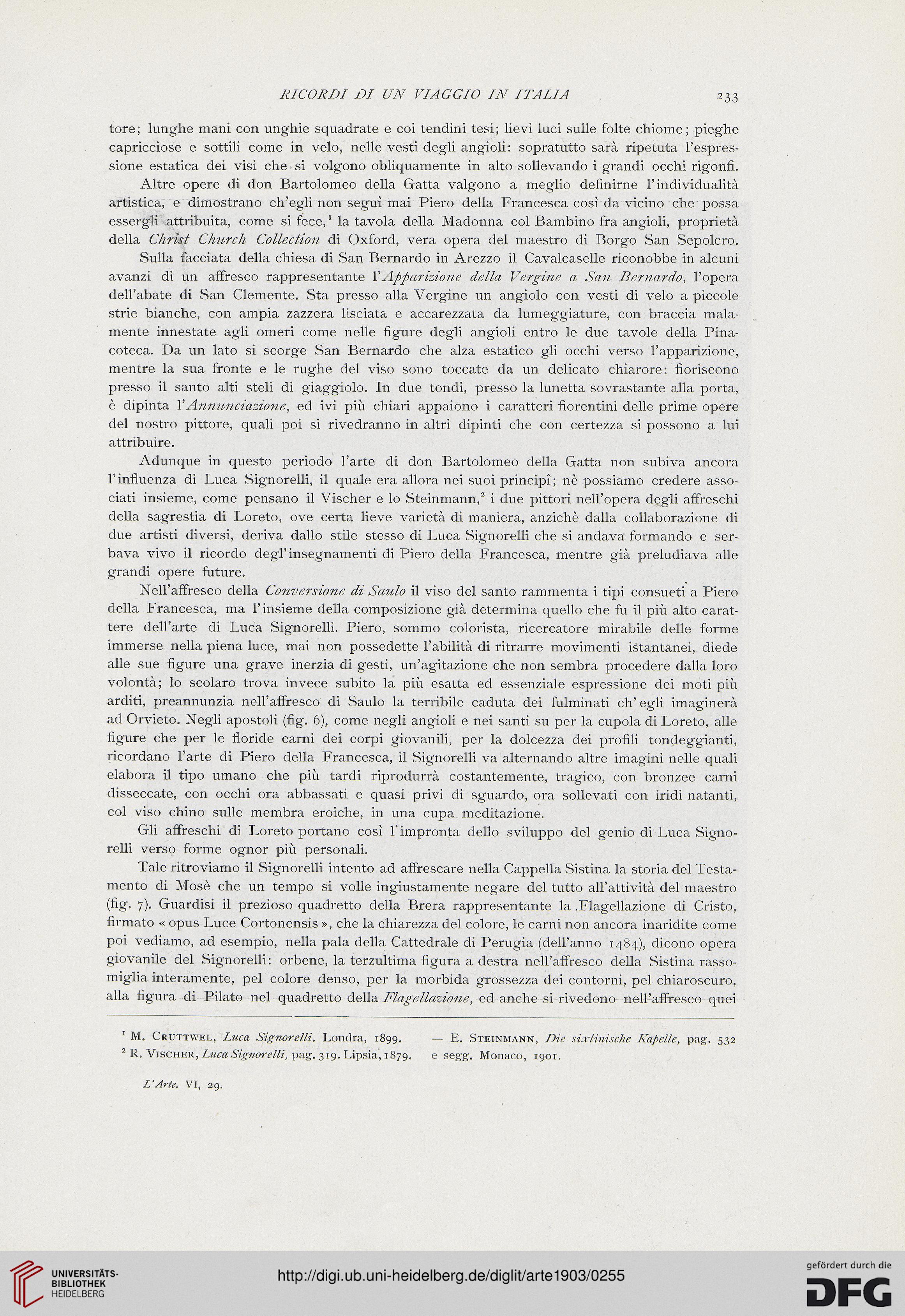RICORDI DI UN VIAGGIO IN ITALIA
233
tore; lunghe mani con unghie squadrate e coi tendini tesi; lievi luci sulle folte chiome; pieghe
capricciose e sottili come in velo, nelle vesti degli angioli: sopratutto sarà ripetuta l’espres-
sione estatica dei visi che si volgono obliquamente in alto sollevando i grandi occhi rigonfi.
Altre opere di don Bartolomeo della Gatta valgono a meglio definirne l’individualità
artistica, e dimostrano ch’egli non segui mai Piero della Francesca così da vicino che possa
essergli attribuita, come si fece,1 2 la tavola della Madonna col Bambino fra angioli, proprietà
della Chrlst Church Collection di Oxford, vera opera del maestro di Borgo San Sepolcro.
Sulla facciata della chiesa di San Bernardo in Arezzo il Cavalcasene riconobbe in alcuni
avanzi di un affresco rappresentante VApparizione della Vergine a San Bernardo, l’opera
dell’abate di San Clemente. Sta presso alla Vergine un angiolo con vesti di velo a piccole
strie bianche, con ampia zazzera lisciata e accarezzata da lumeggiature, con braccia mala-
mente innestate agli omeri come nelle figure degli angioli entro le due tavole della Pina-
coteca. Da un lato si scorge San Bernardo che alza estatico gli occhi verso l’apparizione,
mentre la sua fronte e le rughe del viso sono toccate da un delicato chiarore: fioriscono
presso il santo alti steli di giaggiolo. In due tondi, pressò la lunetta sovrastante alla porta,
è dipinta VAnnunciazione, ed ivi più chiari appaiono i caratteri fiorentini delle prime opere
del nostro pittore, quali poi si rivedranno in altri dipinti che con certezza si possono a lui
attribuire.
Adunque in questo periodo l’arte di don Bartolomeo della Gatta non subiva ancora
l’influenza di Luca Signorelli, il quale era allora nei suoi principi; nè possiamo credere asso-
ciati insieme, come pensano il Vischer e lo Steinmann,” i due pittori nell’opera degli affreschi
della sagrestia di Loreto, ove certa lieve varietà di maniera, anziché dalla collaborazione di
due artisti diversi, deriva dallo stile stesso di Luca Signorelli che si andava formando e ser-
bava vivo il ricordo degl’insegnamenti di Piero della Francesca, mentre già preludiava alle
grandi opere future.
Nell’affresco della Conversione di Saulo il viso del santo rammenta i tipi consueti a Piero
della Francesca, ma l’insieme della composizione già determina quello che fu il più alto carat-
tere dell’arte di Luca Signorelli. Piero, sommo colorista, ricercatore mirabile delle forme
immerse nella piena luce, mai non possedette l’abilità di ritrarre movimenti istantanei, diede
alle sue figure una grave inerzia di gesti, un’agitazione che non sembra procedere dalla loro
volontà; lo scolaro trova invece subito la più esatta ed essenziale espressione dei moti più
arditi, preannunzia nell’affresco di Saulo la terribile caduta dei fulminati eh’ egli imaginerà
ad Orvieto. Negli apostoli (fig. 6), come negli angioli e nei santi su per la cupola di Loreto, alle
figure che per le floride carni dei corpi giovanili, per la dolcezza dei profili tondeggianti,
ricordano l’arte di Piero della Francesca, il Signorelli va alternando altre imagini nelle quali
elabora il tipo umano che più tardi riprodurrà costantemente, tragico, con bronzee carni
disseccate, con occhi ora abbassati e quasi privi di sguardo, ora sollevati con iridi natanti,
col viso chino sulle membra eroiche, in una cupa meditazione.
Gli affreschi di Loreto portano così l'impronta dello sviluppo del genio di Luca Signo-
relli verso forme ognor più personali.
Tale ritroviamo il Signorelli intento ad affrescare nella Cappella Sistina la storia del Testa-
mento di Mosè che un tempo si volle ingiustamente negare del tutto all’attività del maestro
(fig- !)• Guardisi il prezioso quadretto della Brera rappresentante la .Flagellazione di Cristo,
firmato « opus Luce Cortonensis », che la chiarezza del colore, le carni non ancora inaridite come
poi vediamo, ad esempio, nella pala della Cattedrale di Perugia (dell’anno 1484), dicono opera
giovanile del Signorelli: orbene, la terzultima figura a destra nell’affresco della Sistina rasso-
miglia interamente, pel colore denso, per la morbida grossezza dei contorni, pel chiaroscuro,
alla figura di Pilato nel quadretto della Flagellazione, ed anche si rivedono nell’affresco quei
1 M. Cruttwel, Luca Signorelli. Londra, 1899. — E. Steinmann, Die sixtinìsche Kapelle, pag, 532
2 R. Vischer, Luca Signorelli, pag. 319. Lipsia, 1879. e segg. Monaco, 1901.
L’Arte, VI, 29.
233
tore; lunghe mani con unghie squadrate e coi tendini tesi; lievi luci sulle folte chiome; pieghe
capricciose e sottili come in velo, nelle vesti degli angioli: sopratutto sarà ripetuta l’espres-
sione estatica dei visi che si volgono obliquamente in alto sollevando i grandi occhi rigonfi.
Altre opere di don Bartolomeo della Gatta valgono a meglio definirne l’individualità
artistica, e dimostrano ch’egli non segui mai Piero della Francesca così da vicino che possa
essergli attribuita, come si fece,1 2 la tavola della Madonna col Bambino fra angioli, proprietà
della Chrlst Church Collection di Oxford, vera opera del maestro di Borgo San Sepolcro.
Sulla facciata della chiesa di San Bernardo in Arezzo il Cavalcasene riconobbe in alcuni
avanzi di un affresco rappresentante VApparizione della Vergine a San Bernardo, l’opera
dell’abate di San Clemente. Sta presso alla Vergine un angiolo con vesti di velo a piccole
strie bianche, con ampia zazzera lisciata e accarezzata da lumeggiature, con braccia mala-
mente innestate agli omeri come nelle figure degli angioli entro le due tavole della Pina-
coteca. Da un lato si scorge San Bernardo che alza estatico gli occhi verso l’apparizione,
mentre la sua fronte e le rughe del viso sono toccate da un delicato chiarore: fioriscono
presso il santo alti steli di giaggiolo. In due tondi, pressò la lunetta sovrastante alla porta,
è dipinta VAnnunciazione, ed ivi più chiari appaiono i caratteri fiorentini delle prime opere
del nostro pittore, quali poi si rivedranno in altri dipinti che con certezza si possono a lui
attribuire.
Adunque in questo periodo l’arte di don Bartolomeo della Gatta non subiva ancora
l’influenza di Luca Signorelli, il quale era allora nei suoi principi; nè possiamo credere asso-
ciati insieme, come pensano il Vischer e lo Steinmann,” i due pittori nell’opera degli affreschi
della sagrestia di Loreto, ove certa lieve varietà di maniera, anziché dalla collaborazione di
due artisti diversi, deriva dallo stile stesso di Luca Signorelli che si andava formando e ser-
bava vivo il ricordo degl’insegnamenti di Piero della Francesca, mentre già preludiava alle
grandi opere future.
Nell’affresco della Conversione di Saulo il viso del santo rammenta i tipi consueti a Piero
della Francesca, ma l’insieme della composizione già determina quello che fu il più alto carat-
tere dell’arte di Luca Signorelli. Piero, sommo colorista, ricercatore mirabile delle forme
immerse nella piena luce, mai non possedette l’abilità di ritrarre movimenti istantanei, diede
alle sue figure una grave inerzia di gesti, un’agitazione che non sembra procedere dalla loro
volontà; lo scolaro trova invece subito la più esatta ed essenziale espressione dei moti più
arditi, preannunzia nell’affresco di Saulo la terribile caduta dei fulminati eh’ egli imaginerà
ad Orvieto. Negli apostoli (fig. 6), come negli angioli e nei santi su per la cupola di Loreto, alle
figure che per le floride carni dei corpi giovanili, per la dolcezza dei profili tondeggianti,
ricordano l’arte di Piero della Francesca, il Signorelli va alternando altre imagini nelle quali
elabora il tipo umano che più tardi riprodurrà costantemente, tragico, con bronzee carni
disseccate, con occhi ora abbassati e quasi privi di sguardo, ora sollevati con iridi natanti,
col viso chino sulle membra eroiche, in una cupa meditazione.
Gli affreschi di Loreto portano così l'impronta dello sviluppo del genio di Luca Signo-
relli verso forme ognor più personali.
Tale ritroviamo il Signorelli intento ad affrescare nella Cappella Sistina la storia del Testa-
mento di Mosè che un tempo si volle ingiustamente negare del tutto all’attività del maestro
(fig- !)• Guardisi il prezioso quadretto della Brera rappresentante la .Flagellazione di Cristo,
firmato « opus Luce Cortonensis », che la chiarezza del colore, le carni non ancora inaridite come
poi vediamo, ad esempio, nella pala della Cattedrale di Perugia (dell’anno 1484), dicono opera
giovanile del Signorelli: orbene, la terzultima figura a destra nell’affresco della Sistina rasso-
miglia interamente, pel colore denso, per la morbida grossezza dei contorni, pel chiaroscuro,
alla figura di Pilato nel quadretto della Flagellazione, ed anche si rivedono nell’affresco quei
1 M. Cruttwel, Luca Signorelli. Londra, 1899. — E. Steinmann, Die sixtinìsche Kapelle, pag, 532
2 R. Vischer, Luca Signorelli, pag. 319. Lipsia, 1879. e segg. Monaco, 1901.
L’Arte, VI, 29.