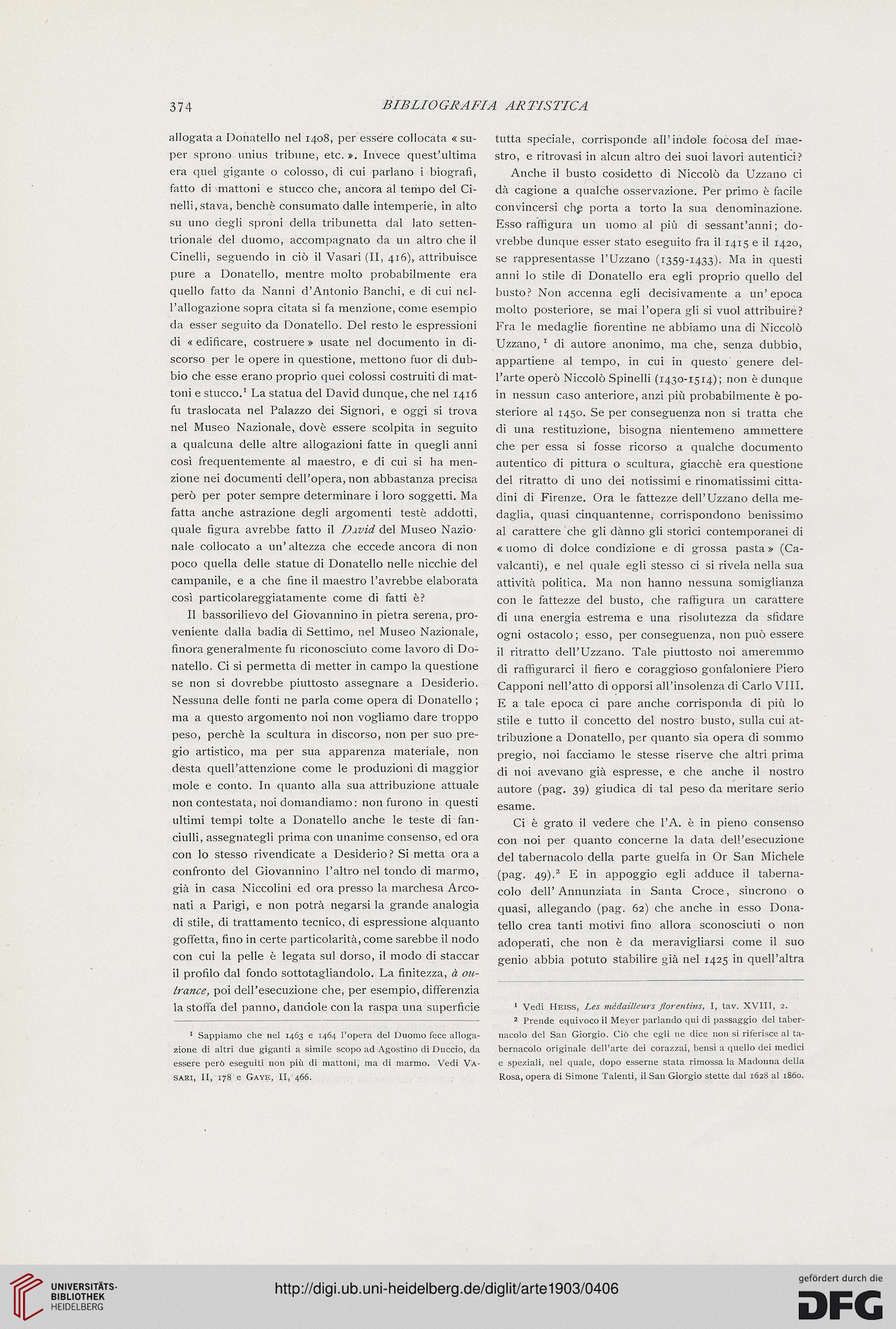374
BIBLIOGRAFIA ARTISTICA
allogata a Donatello nel 1408, per essere collocata « su-
per sprono ùnius tribune, etc. ». Invece quest’ultima
era quel gigante o colosso, di cui parlano i biografi,
fatto di mattoni e stucco che, ancora al tempo del Ci-
nedi, stava, benché consumato dalle intemperie, in alto
su uno degli sproni della tribunetta dal lato setten-
trionale del duomo, accompagnato da un altro che il
Cinedi, seguendo in ciò il Vasari (II, 416), attribuisce
pure a Donatello, mentre molto probabilmente era
quello fatto da Nanni d’Antonio Banchi, e di cui nel-
l’allogazione sopra citata si fa menzione, come esempio
da esser seguito da Donatello. Del resto le espressioni
di «edificare, costruere » usate nel documento in di-
scorso per le opere in questione, mettono fuor di dub-
bio che esse erano proprio quei colossi costruiti di mat-
toni e stucco.1 La statua del David dunque, che nel 1416
fu traslocata nel Palazzo dei Signori, e oggi si trova
nel Museo Nazionale, dovè essere scolpita in seguito
a qualcuna delle altre allogazioni fatte in quegli anni
così frequentemente al maestro, e di cui si ha men-
zione nei documenti dell’opera, non abbastanza precisa
però per poter sempre determinare i loro soggetti. Ma
fatta anche astrazione degli argomenti testé addotti,
quale figura avrebbe fatto il Divid del Museo Nazio-
nale collocato a un’ altezza che eccede ancora di non
poco quella delle statue di Donatello nelle nicchie del
campanile, e a che fine il maestro l’avrebbe elaborata
così particolareggiatamente come di fatti è?
Il bassorilievo del Giovannino in pietra serena, pro-
veniente dalla badia di Settimo, nel Museo Nazionale,
finora generalmente fu riconosciuto come lavoro di Do-
natello. Ci si permetta di metter in campo la questione
se non si dovrebbe piuttosto assegnare a Desiderio.
Nessuna delle fonti ne parla come opera di Donatello ;
ma a questo argomento noi non vogliamo dare troppo
peso, perchè la scultura in discorso, non per suo pre-
gio artistico, ma per sua apparenza materiale, non
désta quell’attenzione come le produzioni di maggior
mole e conto. In quanto alla sua attribuzione attuale
non contestata, noi domandiamo : non furono in questi
ultimi tempi tolte a Donatello anche le teste di fan-
ciulli, assegnategli prima con unanime consenso, ed ora
con lo stesso rivendicate a Desiderio ? Si metta ora a
confronto del Giovannino l’altro nel tondo di marmo,
già in casa Niccolini ed ora presso la marchesa Arco-
nati a Parigi, e non potrà negarsi la grande analogia
di stile, di trattamento tecnico, di espressione alquanto
gofifetta, fino in certe particolarità, come sarebbe il nodo
con cui la pelle è legata sul dorso, il modo di staccar
il profilo dal fondo sottotagliandolo. La finitezza, à ou-
trance, poi dell’esecuzione che, per esempio, differenzia
la stoffa del panno, dandole con la raspa una superficie
1 Sappiamo che nel 1463 e 1464 l’opera del Duomo fece alloga-
zione di altri due giganti a simile scopo ad Agostino di Duccio, da
essere però eseguiti non più di mattoni, ma di marmo. Vedi Va-
sari, II, 178 e Gaye, II, 466.
tutta speciale, corrisponde all’indole focosa del mae-
stro, e ritrovasi in alcun altro dei suoi lavori autentici?
Anche il busto cosidetto di Niccolò da Uzzano ci
dà cagione a qualche osservazione. Per primo è facile
convincersi chp porta a torto la sua denominazione.
Esso raffigura un uomo al più di sessantanni ; do-
vrebbe dunque esser stato eseguito fra il 1415 e il 1420,
se rappresentasse l’Uzzano (1359-1433). Ma in questi
anni lo stile di Donatello era egli proprio quello del
busto? Non accenna egli decisivamente a un’epoca
molto posteriore, se mai l’opera gli si vuol attribuire?
Fra le medaglie fiorentine ne abbiamo una di Niccolò
Uzzano, 1 di autore anonimo, ma che, senza dubbio,
appartiene al tempo, in cui in questo' genere del-
l’arte operò Niccolò Spinelli (1430-1514); non è dunque
in nessun caso anteriore, anzi più probabilmente è po-
steriore al 1450. Se per conseguenza non si tratta che
di una restituzione, bisogna nientemeno ammettere
che per essa si fosse ricorso a qualche documento
autentico di pittura o scultura, giacché era questione
del ritratto di uno dei notissimi e rinomatissimi citta-
dini di Firenze. Ora le fattezze dell’Uzzano della me-
daglia, quasi cinquantenne, corrispondono benissimo
al carattere che gli danno gli storici contemporanei di
« uomo di dolce condizione e di grossa pasta » (Ca-
valcanti), e nel quale egli stesso ci si rivela nella sua
attività politica. Ma non hanno nessuna somiglianza
con le fattezze del busto, che raffigura un carattere
di una energia estrema e una risolutezza da sfidare
ogni ostacolo; esso, per conseguenza, non può essere
il ritratto dell’Uzzano. Tale piuttosto noi ameremmo
di raffigurarci il fiero e coraggioso gonfaloniere Piero
Capponi nell’atto di opporsi all’insolenza di Carlo Vili.
E a tale epoca ci pare anche corrisponda di più lo
stile e tutto il concetto del nostro busto, sulla cui at-
tribuzione a Donatello, per quanto sia opera di sommo
pregio, noi facciamo le stesse riserve che altri prima
di noi avevano già espresse, e che anche il nostro
autore (pag. 39) giudica di tal peso da meritare serio
esame.
Ci è grato il vedere che l’A. è in pieno consenso
con noi per quanto concerne la data dell’esecuzione
del tabernacolo della parte guelfa in Or San Michele
(pag. 49).2 E in appoggio egli adduce il taberna-
colo dell’ Annunziata in Santa Croce, sincrono o
quasi, allegando (pag. 62) che anche in esso Dona-
tello crea tanti motivi fino allora sconosciuti o non
adoperati, che non è da meravigliarsi come il suo
genio abbia potuto stabilire già nel 1425 in quell’altra
1 Vedi Heiss, Les mèdailleurs florentins, I, tav. XVIII, 2.
2 Prende equivoco il Meyer parlando qui di passaggio del taber-
nacolo del San Giorgio. Ciò che egli ne dice non si riferisce al ta-
bernacolo originale dell’arte dei corazzai, bensì a quello dei medici
e speziali, nel quale, dopo esserne stata rimossa la Madonna della
Rosa, opera di Simone Talenti, il San Giorgio stette dal 1628 al 1860.
BIBLIOGRAFIA ARTISTICA
allogata a Donatello nel 1408, per essere collocata « su-
per sprono ùnius tribune, etc. ». Invece quest’ultima
era quel gigante o colosso, di cui parlano i biografi,
fatto di mattoni e stucco che, ancora al tempo del Ci-
nedi, stava, benché consumato dalle intemperie, in alto
su uno degli sproni della tribunetta dal lato setten-
trionale del duomo, accompagnato da un altro che il
Cinedi, seguendo in ciò il Vasari (II, 416), attribuisce
pure a Donatello, mentre molto probabilmente era
quello fatto da Nanni d’Antonio Banchi, e di cui nel-
l’allogazione sopra citata si fa menzione, come esempio
da esser seguito da Donatello. Del resto le espressioni
di «edificare, costruere » usate nel documento in di-
scorso per le opere in questione, mettono fuor di dub-
bio che esse erano proprio quei colossi costruiti di mat-
toni e stucco.1 La statua del David dunque, che nel 1416
fu traslocata nel Palazzo dei Signori, e oggi si trova
nel Museo Nazionale, dovè essere scolpita in seguito
a qualcuna delle altre allogazioni fatte in quegli anni
così frequentemente al maestro, e di cui si ha men-
zione nei documenti dell’opera, non abbastanza precisa
però per poter sempre determinare i loro soggetti. Ma
fatta anche astrazione degli argomenti testé addotti,
quale figura avrebbe fatto il Divid del Museo Nazio-
nale collocato a un’ altezza che eccede ancora di non
poco quella delle statue di Donatello nelle nicchie del
campanile, e a che fine il maestro l’avrebbe elaborata
così particolareggiatamente come di fatti è?
Il bassorilievo del Giovannino in pietra serena, pro-
veniente dalla badia di Settimo, nel Museo Nazionale,
finora generalmente fu riconosciuto come lavoro di Do-
natello. Ci si permetta di metter in campo la questione
se non si dovrebbe piuttosto assegnare a Desiderio.
Nessuna delle fonti ne parla come opera di Donatello ;
ma a questo argomento noi non vogliamo dare troppo
peso, perchè la scultura in discorso, non per suo pre-
gio artistico, ma per sua apparenza materiale, non
désta quell’attenzione come le produzioni di maggior
mole e conto. In quanto alla sua attribuzione attuale
non contestata, noi domandiamo : non furono in questi
ultimi tempi tolte a Donatello anche le teste di fan-
ciulli, assegnategli prima con unanime consenso, ed ora
con lo stesso rivendicate a Desiderio ? Si metta ora a
confronto del Giovannino l’altro nel tondo di marmo,
già in casa Niccolini ed ora presso la marchesa Arco-
nati a Parigi, e non potrà negarsi la grande analogia
di stile, di trattamento tecnico, di espressione alquanto
gofifetta, fino in certe particolarità, come sarebbe il nodo
con cui la pelle è legata sul dorso, il modo di staccar
il profilo dal fondo sottotagliandolo. La finitezza, à ou-
trance, poi dell’esecuzione che, per esempio, differenzia
la stoffa del panno, dandole con la raspa una superficie
1 Sappiamo che nel 1463 e 1464 l’opera del Duomo fece alloga-
zione di altri due giganti a simile scopo ad Agostino di Duccio, da
essere però eseguiti non più di mattoni, ma di marmo. Vedi Va-
sari, II, 178 e Gaye, II, 466.
tutta speciale, corrisponde all’indole focosa del mae-
stro, e ritrovasi in alcun altro dei suoi lavori autentici?
Anche il busto cosidetto di Niccolò da Uzzano ci
dà cagione a qualche osservazione. Per primo è facile
convincersi chp porta a torto la sua denominazione.
Esso raffigura un uomo al più di sessantanni ; do-
vrebbe dunque esser stato eseguito fra il 1415 e il 1420,
se rappresentasse l’Uzzano (1359-1433). Ma in questi
anni lo stile di Donatello era egli proprio quello del
busto? Non accenna egli decisivamente a un’epoca
molto posteriore, se mai l’opera gli si vuol attribuire?
Fra le medaglie fiorentine ne abbiamo una di Niccolò
Uzzano, 1 di autore anonimo, ma che, senza dubbio,
appartiene al tempo, in cui in questo' genere del-
l’arte operò Niccolò Spinelli (1430-1514); non è dunque
in nessun caso anteriore, anzi più probabilmente è po-
steriore al 1450. Se per conseguenza non si tratta che
di una restituzione, bisogna nientemeno ammettere
che per essa si fosse ricorso a qualche documento
autentico di pittura o scultura, giacché era questione
del ritratto di uno dei notissimi e rinomatissimi citta-
dini di Firenze. Ora le fattezze dell’Uzzano della me-
daglia, quasi cinquantenne, corrispondono benissimo
al carattere che gli danno gli storici contemporanei di
« uomo di dolce condizione e di grossa pasta » (Ca-
valcanti), e nel quale egli stesso ci si rivela nella sua
attività politica. Ma non hanno nessuna somiglianza
con le fattezze del busto, che raffigura un carattere
di una energia estrema e una risolutezza da sfidare
ogni ostacolo; esso, per conseguenza, non può essere
il ritratto dell’Uzzano. Tale piuttosto noi ameremmo
di raffigurarci il fiero e coraggioso gonfaloniere Piero
Capponi nell’atto di opporsi all’insolenza di Carlo Vili.
E a tale epoca ci pare anche corrisponda di più lo
stile e tutto il concetto del nostro busto, sulla cui at-
tribuzione a Donatello, per quanto sia opera di sommo
pregio, noi facciamo le stesse riserve che altri prima
di noi avevano già espresse, e che anche il nostro
autore (pag. 39) giudica di tal peso da meritare serio
esame.
Ci è grato il vedere che l’A. è in pieno consenso
con noi per quanto concerne la data dell’esecuzione
del tabernacolo della parte guelfa in Or San Michele
(pag. 49).2 E in appoggio egli adduce il taberna-
colo dell’ Annunziata in Santa Croce, sincrono o
quasi, allegando (pag. 62) che anche in esso Dona-
tello crea tanti motivi fino allora sconosciuti o non
adoperati, che non è da meravigliarsi come il suo
genio abbia potuto stabilire già nel 1425 in quell’altra
1 Vedi Heiss, Les mèdailleurs florentins, I, tav. XVIII, 2.
2 Prende equivoco il Meyer parlando qui di passaggio del taber-
nacolo del San Giorgio. Ciò che egli ne dice non si riferisce al ta-
bernacolo originale dell’arte dei corazzai, bensì a quello dei medici
e speziali, nel quale, dopo esserne stata rimossa la Madonna della
Rosa, opera di Simone Talenti, il San Giorgio stette dal 1628 al 1860.