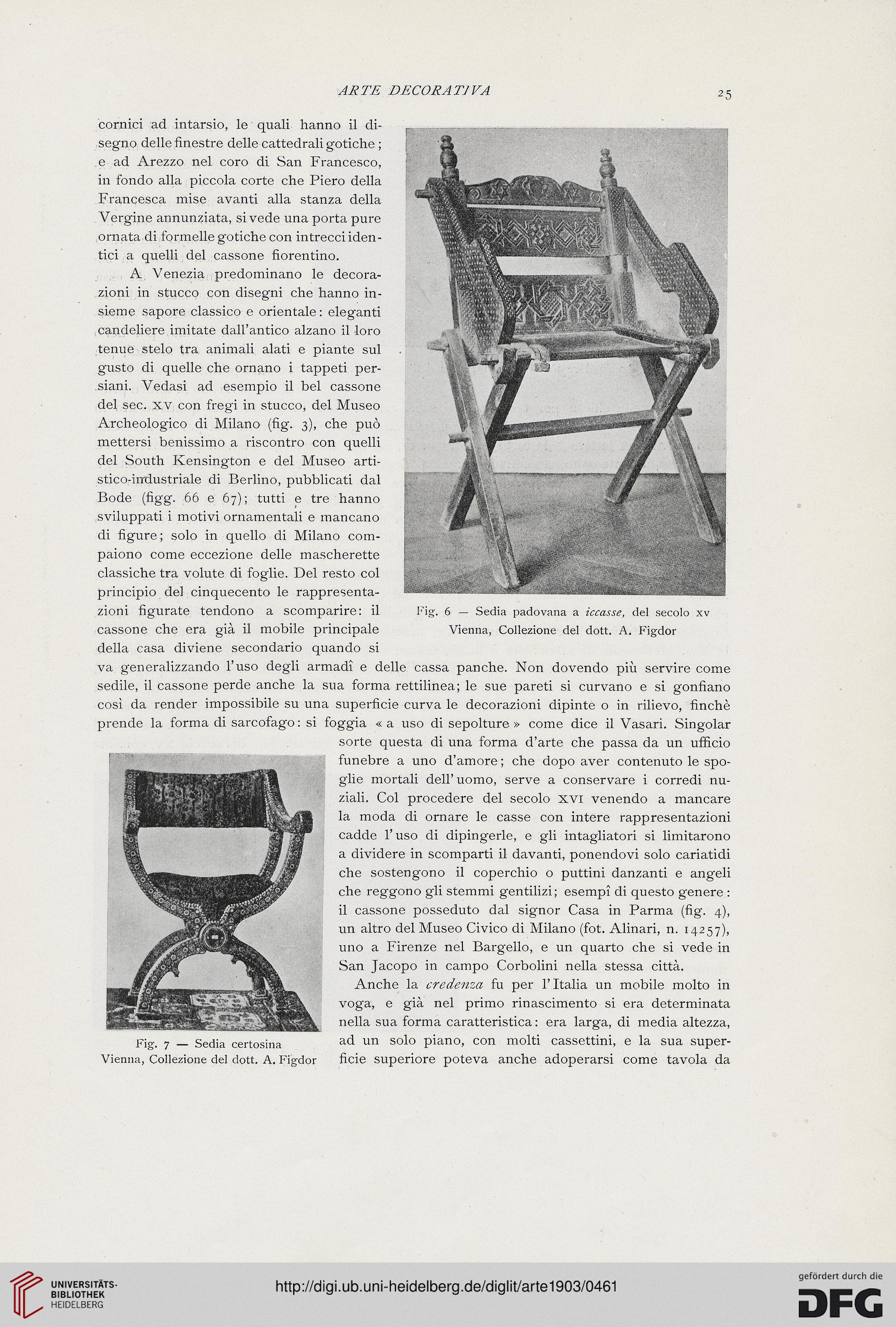ARTE DECORATJVA
25
cornici ad intarsio, le quali hanno il di-
segno, delle finestre delle cattedrali gotiche ;
e ad Arezzo nel coro di San Francesco,
in fondo alla piccola corte che Piero della
Francesca mise avanti alla stanza della
Vergine annunziata, si vede una porta pure
ornata di formelle gotiche con intrecci iden-
tici a quelli del cassone fiorentino.
A Venezia predominano le decora-
zioni in stucco con disegni che hanno in-
sieme sapore classico e orientale: eleganti
candeliere imitate dall’antico alzano il loro
tenue stelo tra animali alati e piante sul
gusto di quelle che ornano i tappeti per-
siani. Vedasi ad esempio il bel cassone
del sec. XV; con fregi in stucco, del Museo
Archeologico di Milano (fig. 3), che può
mettersi benissimo a riscontro con quelli
del South Kensington e del Museo arti-
stico-irrdustriale di Berlino, pubblicati dal
Bode (figg. 66 e 67); tutti e tre hanno
sviluppati i motivi ornamentali e mancano
di figure ; solo in quello di Milano com-
paiono come eccezione delle mascherette
classiche tra volute di foglie. Del resto col
principio del cinquecento le rappresenta-
zioni figurate tendono a scomparire: il Fig. 6 — Sedia padovana a iccasse, del secolo xv
cassone che era già il mobile principale Vienna, Collezione del dott. A. Figdor
della casa diviene secondario quando si
va generalizzando l’uso degli armadi e delle cassa panche. Non dovendo più servire come
sedile, il cassone perde anche la sua forma rettilinea; le sue pareti si curvano e si gonfiano
così da render impossibile su una superficie curva le decorazioni dipinte o in rilievo, finché
prende la forma di sarcofago : si foggia «a uso di sepolture » come dice il Vasari. Singoiar
sorte questa di una forma d’arte che passa da un ufficio
funebre a uno d’amore ; che dopo aver contenuto le spo-
glie mortali dell’uomo, serve a conservare i corredi nu-
ziali. Col procedere del secolo XVI venendo a mancare
la moda di ornare le casse con intere rappresentazioni
cadde l’uso di dipingerle, e gli intagliatori si limitarono
a dividere in scomparti il davanti, ponendovi solo cariatidi
che sostengono il coperchio o puttini danzanti e angeli
che reggono gli stemmi gentilizi; esempi di questo genere :
il cassone posseduto dal signor Casa in Parma (fig. 4),
un altro del Museo Civico di Milano (fot. Alinari, n. 14257),
uno a Firenze nel Bargello, e un quarto che si vede in
San Jacopo in campo Corbolini nella stessa città.
Anche la credenza fu per l’Italia un mobile molto in
voga, e già nel primo rinascimento si era determinata
nella sua forma caratteristica : era larga, di media altezza,
Fig. 7 — Sedia certosina ad un solo piano, con molti cassettini, e la sua super-
Vienna, Collezione del dott. A. Figdor ficie superiore poteva anche adoperarsi come tavola da
25
cornici ad intarsio, le quali hanno il di-
segno, delle finestre delle cattedrali gotiche ;
e ad Arezzo nel coro di San Francesco,
in fondo alla piccola corte che Piero della
Francesca mise avanti alla stanza della
Vergine annunziata, si vede una porta pure
ornata di formelle gotiche con intrecci iden-
tici a quelli del cassone fiorentino.
A Venezia predominano le decora-
zioni in stucco con disegni che hanno in-
sieme sapore classico e orientale: eleganti
candeliere imitate dall’antico alzano il loro
tenue stelo tra animali alati e piante sul
gusto di quelle che ornano i tappeti per-
siani. Vedasi ad esempio il bel cassone
del sec. XV; con fregi in stucco, del Museo
Archeologico di Milano (fig. 3), che può
mettersi benissimo a riscontro con quelli
del South Kensington e del Museo arti-
stico-irrdustriale di Berlino, pubblicati dal
Bode (figg. 66 e 67); tutti e tre hanno
sviluppati i motivi ornamentali e mancano
di figure ; solo in quello di Milano com-
paiono come eccezione delle mascherette
classiche tra volute di foglie. Del resto col
principio del cinquecento le rappresenta-
zioni figurate tendono a scomparire: il Fig. 6 — Sedia padovana a iccasse, del secolo xv
cassone che era già il mobile principale Vienna, Collezione del dott. A. Figdor
della casa diviene secondario quando si
va generalizzando l’uso degli armadi e delle cassa panche. Non dovendo più servire come
sedile, il cassone perde anche la sua forma rettilinea; le sue pareti si curvano e si gonfiano
così da render impossibile su una superficie curva le decorazioni dipinte o in rilievo, finché
prende la forma di sarcofago : si foggia «a uso di sepolture » come dice il Vasari. Singoiar
sorte questa di una forma d’arte che passa da un ufficio
funebre a uno d’amore ; che dopo aver contenuto le spo-
glie mortali dell’uomo, serve a conservare i corredi nu-
ziali. Col procedere del secolo XVI venendo a mancare
la moda di ornare le casse con intere rappresentazioni
cadde l’uso di dipingerle, e gli intagliatori si limitarono
a dividere in scomparti il davanti, ponendovi solo cariatidi
che sostengono il coperchio o puttini danzanti e angeli
che reggono gli stemmi gentilizi; esempi di questo genere :
il cassone posseduto dal signor Casa in Parma (fig. 4),
un altro del Museo Civico di Milano (fot. Alinari, n. 14257),
uno a Firenze nel Bargello, e un quarto che si vede in
San Jacopo in campo Corbolini nella stessa città.
Anche la credenza fu per l’Italia un mobile molto in
voga, e già nel primo rinascimento si era determinata
nella sua forma caratteristica : era larga, di media altezza,
Fig. 7 — Sedia certosina ad un solo piano, con molti cassettini, e la sua super-
Vienna, Collezione del dott. A. Figdor ficie superiore poteva anche adoperarsi come tavola da