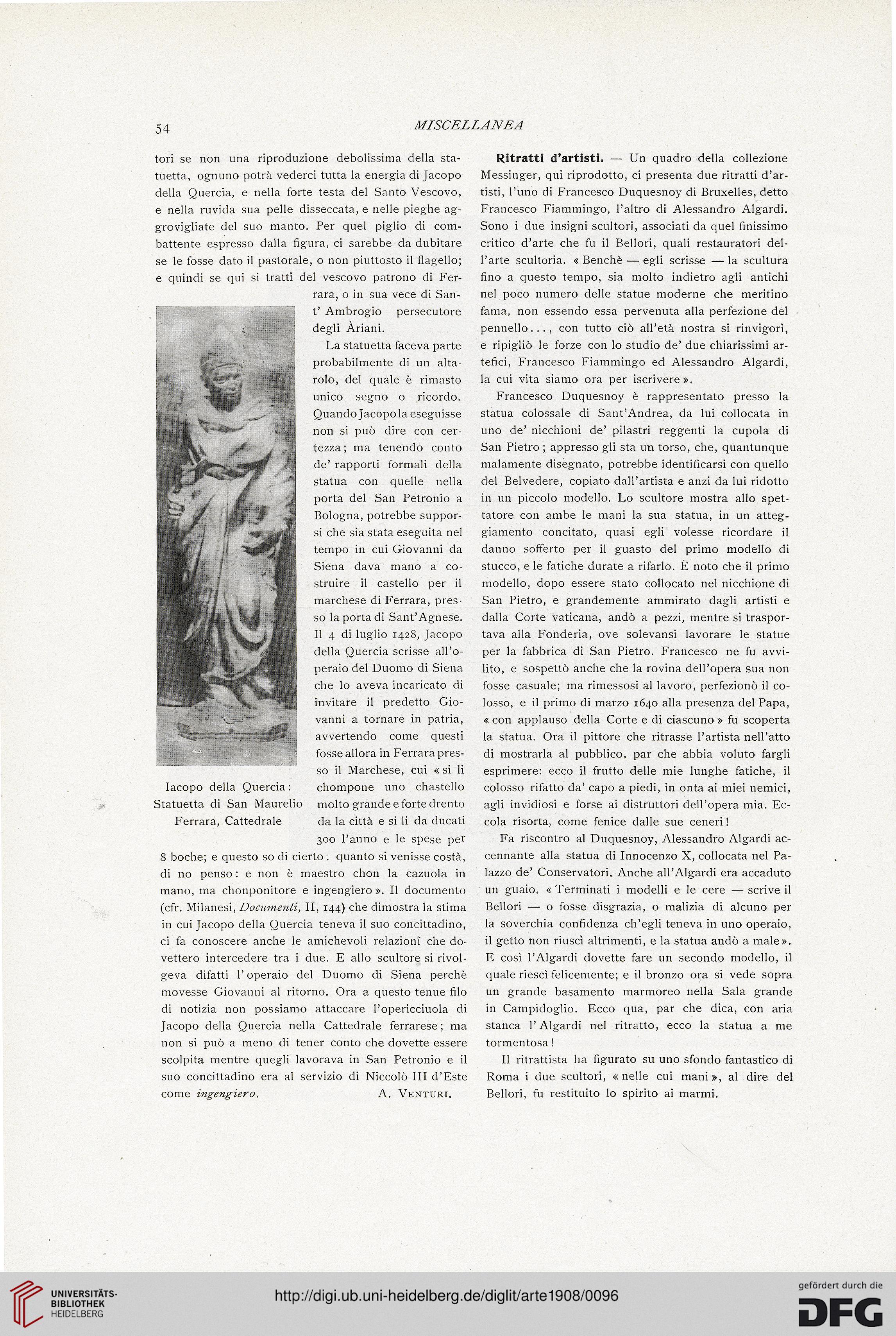54
MISCELLANEA
tori se non una riproduzione debolissima della sta-
tuetta, ognuno potrà vederci tutta la energia di Jacopo
della Quercia, e nella forte testa del Santo Vescovo,
e nella ruvida sua pelle disseccata, e nelle pieghe ag-
grovigliate del suo manto. Per quel piglio di com-
battente espresso dalla figura, ci sarebbe da dubitare
se le fosse dato il pastorale, o non piuttosto il flagello;
e quindi se qui si tratti del vescovo patrono di Fer-
rara, o in sua vece di San-
t’ Ambrogio persecutore
degli Ariani.
La statuetta faceva parte
probabilmente di un alta-
rolo, del quale è rimasto
unico segno o ricordo.
Quando Jacopola eseguisse
non si può dire con cer-
tezza ; ma tenendo conto
de’ rapporti formali della
statua con quelle nella
porta del San Petronio a
Bologna, potrebbe suppor-
si che sia stata eseguita nel
tempo in cui Giovanni da
Siena dava mano a co-
struire il castello per il
marchese di Ferrara, pres-
so la porta di Sant’Agnese.
11 4 di luglio 1428, Jacopo
della Quercia scrisse all’o-
peraio del Duomo di Siena
che lo aveva incaricato di
invitare il predetto Gio-
vanni a tornare in patria,
avvertendo come questi
fosse allora in Ferrara pres-
so il Marchese, cui «si li
Iacopo della Quercia : chompone uno chastello
Statuetta di San Maurelio molto grande e forte drento
Ferrara, Cattedrale da la città e si li da ducati
300 l’anno e le spese per
8 boche; e questo so di cierto : quanto si venisse costà,
di no penso : e non è maestro chon la cazuola in
mano, ma chonponitore e ingengiero». Il documento
(cfr. Milanesi, Documenti, II, 144) che dimostra la stima
in cui Jacopo della Quercia teneva il suo concittadino,
ci fa conoscere anche le amichevoli relazioni che do-
vettero intercedere tra i due. E allo scultore si rivol-
geva difatti l’operaio del Duomo di Siena perchè
movesse Giovanni al ritorno. Ora a questo tenue filo
di notizia non possiamo attaccare l’opericciuola di
Jacopo della Quercia nella Cattedrale ferrarese; ma
non si può a meno di tener conto che dovette essere
scolpita mentre quegli lavorava in San Petronio e il
suo concittadino era al servizio di Niccolò III d’Este
come ingengiero. A. Venturi.
Ritratti d’artisti. — Un quadro della collezione
Messinger, qui riprodotto, ci presenta due ritratti d’ar-
tisti, l’uno di Francesco Duquesnoy di Bruxelles, detto
Francesco Fiammingo, l’altro di Alessandro Algardi.
Sono i due insigni scultori, associati da quel finissimo
critico d’arte che fu il Bellori, quali restauratori del-
l’arte scultoria. « Benché — egli scrisse — la scultura
fino a questo tempo, sia molto indietro agli antichi
nel poco numero delle statue moderne che meritino
fama, non essendo essa pervenuta alla perfezione del
pennello..., con tutto ciò all’età nostra si rinvigorì,
e ripigliò le forze con lo studio de’ due chiarissimi ar-
tefici, Francesco Fiammingo ed Alessandro Algardi,
la cui vita siamo ora per iscrivere».
Francesco Duquesnoy è rappresentato presso la
statua colossale di Sant’Andrea, da lui collocata in
uno de’ nicchioni de’ pilastri reggenti la cupola di
San Pietro ; appresso gli sta un torso, che, quantunque
malamente disegnato, potrebbe identificarsi con quello
del Belvedere, copiato dall’artista e anzi da lui ridotto
in un piccolo modello. Lo scultore mostra allo spet-
tatore con ambe le mani la sua statua, in un atteg-
giamento concitato, quasi egli volesse ricordare il
danno sofferto per il guasto del primo modello di
stucco, e le fatiche durate a rifarlo. È noto che il primo
modello, dopo essere stato collocato nel nicchione di
San Pietro, e grandemente ammirato dagli artisti e
dalla Corte vaticana, andò a pezzi, mentre si traspor-
tava alla Fonderia, ove solevansi lavorare le statue
per la fabbrica di San Pietro. Francesco ne fu avvi-
lito, e sospettò anche che la rovina dell’opera sua non
fosse casuale; ma rimessosi al lavoro, perfezionò il co-
losso, e il primo di marzo 1640 alla presenza del Papa,
« con applauso della Corte e di ciascuno » fu scoperta
la statua. Ora il pittore che ritrasse l’artista nell’atto
di mostrarla al pubblico, par che abbia voluto fargli
esprimere: ecco il frutto delle mie lunghe fatiche, il
colosso rifatto da’ capo a piedi, in onta ai miei nemici,
agli invidiosi e forse ai distruttori dell’opera mia. Ec-
cola risorta, come fenice dalle sue ceneri !
Fa riscontro al Duquesnoy, Alessandro Algardi ac-
cennante alla statua di Innocenzo X, collocata nel Pa-
lazzo de’ Conservatori. Anche all’Algardi era accaduto
un guaio. «Terminati i modelli e le cere —scrive il
Bellori — o fosse disgrazia, o malizia di alcuno per
la soverchia confidenza ch’egli teneva in uno operaio,
il getto non riuscì altrimenti, e la statua andò a male».
E così l’Algardi dovette fare un secondo modello, il
quale riesci felicemente; e il bronzo ora si vede sopra
un grande basamento marmoreo nella Sala grande
in Campidoglio. Ecco qua, par che dica, con aria
stanca l’Algardi nel ritratto, ecco la statua a me
tormentosa !
Il ritrattista ha figurato su uno sfondo fantastico di
Roma i due scultori, «nelle cui mani», al dire del
Bellori, fu restituito lo spirito ai marmi.
MISCELLANEA
tori se non una riproduzione debolissima della sta-
tuetta, ognuno potrà vederci tutta la energia di Jacopo
della Quercia, e nella forte testa del Santo Vescovo,
e nella ruvida sua pelle disseccata, e nelle pieghe ag-
grovigliate del suo manto. Per quel piglio di com-
battente espresso dalla figura, ci sarebbe da dubitare
se le fosse dato il pastorale, o non piuttosto il flagello;
e quindi se qui si tratti del vescovo patrono di Fer-
rara, o in sua vece di San-
t’ Ambrogio persecutore
degli Ariani.
La statuetta faceva parte
probabilmente di un alta-
rolo, del quale è rimasto
unico segno o ricordo.
Quando Jacopola eseguisse
non si può dire con cer-
tezza ; ma tenendo conto
de’ rapporti formali della
statua con quelle nella
porta del San Petronio a
Bologna, potrebbe suppor-
si che sia stata eseguita nel
tempo in cui Giovanni da
Siena dava mano a co-
struire il castello per il
marchese di Ferrara, pres-
so la porta di Sant’Agnese.
11 4 di luglio 1428, Jacopo
della Quercia scrisse all’o-
peraio del Duomo di Siena
che lo aveva incaricato di
invitare il predetto Gio-
vanni a tornare in patria,
avvertendo come questi
fosse allora in Ferrara pres-
so il Marchese, cui «si li
Iacopo della Quercia : chompone uno chastello
Statuetta di San Maurelio molto grande e forte drento
Ferrara, Cattedrale da la città e si li da ducati
300 l’anno e le spese per
8 boche; e questo so di cierto : quanto si venisse costà,
di no penso : e non è maestro chon la cazuola in
mano, ma chonponitore e ingengiero». Il documento
(cfr. Milanesi, Documenti, II, 144) che dimostra la stima
in cui Jacopo della Quercia teneva il suo concittadino,
ci fa conoscere anche le amichevoli relazioni che do-
vettero intercedere tra i due. E allo scultore si rivol-
geva difatti l’operaio del Duomo di Siena perchè
movesse Giovanni al ritorno. Ora a questo tenue filo
di notizia non possiamo attaccare l’opericciuola di
Jacopo della Quercia nella Cattedrale ferrarese; ma
non si può a meno di tener conto che dovette essere
scolpita mentre quegli lavorava in San Petronio e il
suo concittadino era al servizio di Niccolò III d’Este
come ingengiero. A. Venturi.
Ritratti d’artisti. — Un quadro della collezione
Messinger, qui riprodotto, ci presenta due ritratti d’ar-
tisti, l’uno di Francesco Duquesnoy di Bruxelles, detto
Francesco Fiammingo, l’altro di Alessandro Algardi.
Sono i due insigni scultori, associati da quel finissimo
critico d’arte che fu il Bellori, quali restauratori del-
l’arte scultoria. « Benché — egli scrisse — la scultura
fino a questo tempo, sia molto indietro agli antichi
nel poco numero delle statue moderne che meritino
fama, non essendo essa pervenuta alla perfezione del
pennello..., con tutto ciò all’età nostra si rinvigorì,
e ripigliò le forze con lo studio de’ due chiarissimi ar-
tefici, Francesco Fiammingo ed Alessandro Algardi,
la cui vita siamo ora per iscrivere».
Francesco Duquesnoy è rappresentato presso la
statua colossale di Sant’Andrea, da lui collocata in
uno de’ nicchioni de’ pilastri reggenti la cupola di
San Pietro ; appresso gli sta un torso, che, quantunque
malamente disegnato, potrebbe identificarsi con quello
del Belvedere, copiato dall’artista e anzi da lui ridotto
in un piccolo modello. Lo scultore mostra allo spet-
tatore con ambe le mani la sua statua, in un atteg-
giamento concitato, quasi egli volesse ricordare il
danno sofferto per il guasto del primo modello di
stucco, e le fatiche durate a rifarlo. È noto che il primo
modello, dopo essere stato collocato nel nicchione di
San Pietro, e grandemente ammirato dagli artisti e
dalla Corte vaticana, andò a pezzi, mentre si traspor-
tava alla Fonderia, ove solevansi lavorare le statue
per la fabbrica di San Pietro. Francesco ne fu avvi-
lito, e sospettò anche che la rovina dell’opera sua non
fosse casuale; ma rimessosi al lavoro, perfezionò il co-
losso, e il primo di marzo 1640 alla presenza del Papa,
« con applauso della Corte e di ciascuno » fu scoperta
la statua. Ora il pittore che ritrasse l’artista nell’atto
di mostrarla al pubblico, par che abbia voluto fargli
esprimere: ecco il frutto delle mie lunghe fatiche, il
colosso rifatto da’ capo a piedi, in onta ai miei nemici,
agli invidiosi e forse ai distruttori dell’opera mia. Ec-
cola risorta, come fenice dalle sue ceneri !
Fa riscontro al Duquesnoy, Alessandro Algardi ac-
cennante alla statua di Innocenzo X, collocata nel Pa-
lazzo de’ Conservatori. Anche all’Algardi era accaduto
un guaio. «Terminati i modelli e le cere —scrive il
Bellori — o fosse disgrazia, o malizia di alcuno per
la soverchia confidenza ch’egli teneva in uno operaio,
il getto non riuscì altrimenti, e la statua andò a male».
E così l’Algardi dovette fare un secondo modello, il
quale riesci felicemente; e il bronzo ora si vede sopra
un grande basamento marmoreo nella Sala grande
in Campidoglio. Ecco qua, par che dica, con aria
stanca l’Algardi nel ritratto, ecco la statua a me
tormentosa !
Il ritrattista ha figurato su uno sfondo fantastico di
Roma i due scultori, «nelle cui mani», al dire del
Bellori, fu restituito lo spirito ai marmi.