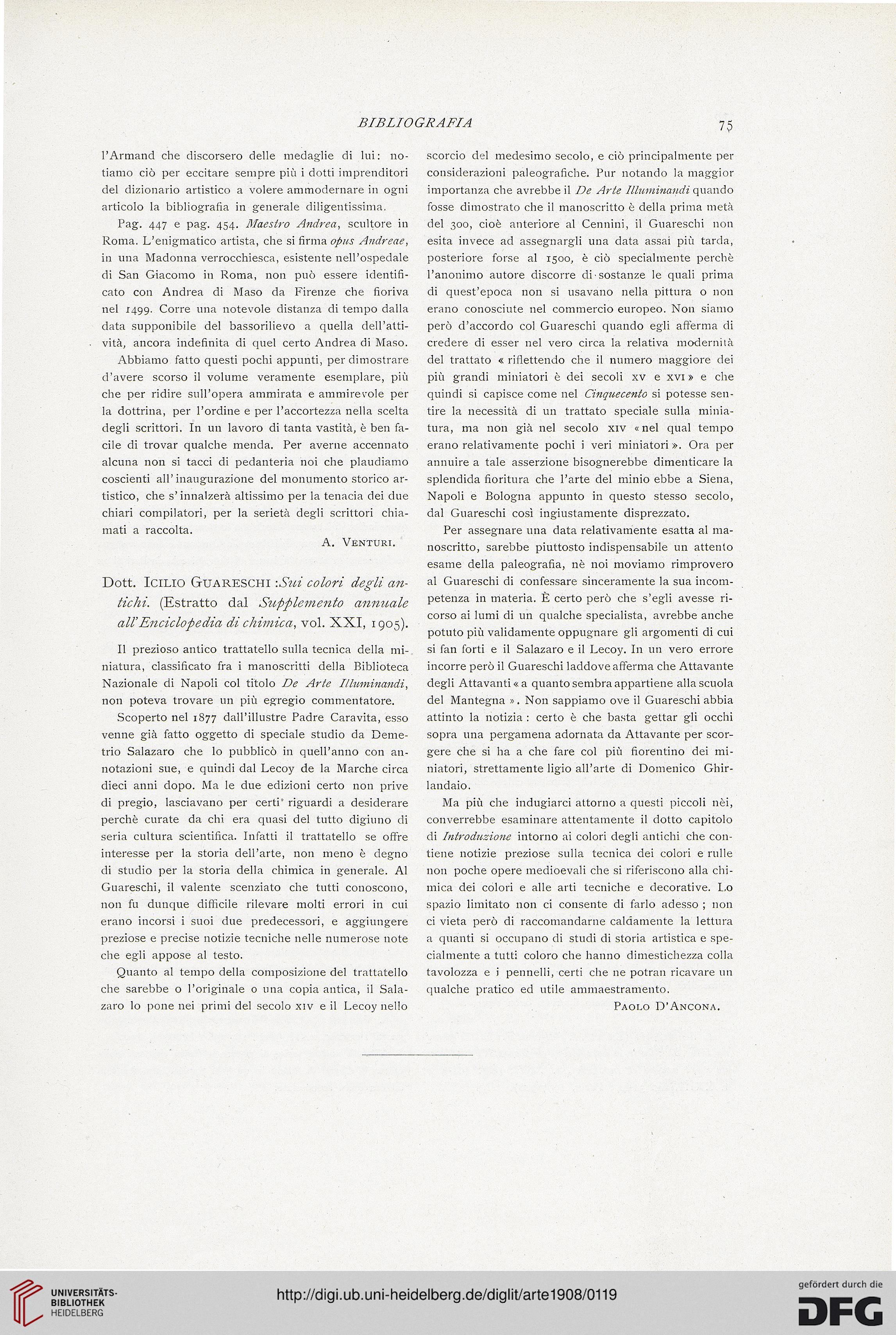BIBLIOGRAFIA
75
l’Armand che discorsero delle medaglie di lui: no-
tiamo ciò per eccitare sempre più i dotti imprenditori
del dizionario artistico a volere ammodernare in ogni
articolo la bibliografia in generale diligentissima.
Pag. 447 e pag. 454. Maestro Andrea, scultore in
Roma. L’enigmatico artista, che si firma opus Andreae,
in una Madonna verrocchiesca, esistente nell’ospedale
di San Giacomo in Roma, non può essere identifi-
cato con Andrea di Maso da Firenze che fioriva
nel 1499. Corre una notevole distanza di tempo dalla
data supponibile del bassorilievo a quella dell’atti-
vità, ancora indefinita di quel certo Andrea di Maso.
Abbiamo fatto questi pochi appunti, per dimostrare
d’avere scorso il volume veramente esemplare, più
che per ridire sull’opera ammirata e ammirevole per
la dottrina, per l’ordine e per l’accortezza nella scelta
degli scrittori. In un lavoro di tanta vastità, è ben fa-
cile di trovar qualche menda. Per averne accennato
alcuna non si tacci di pedanteria noi che plaudiamo
coscienti all’inaugurazione del monumento storico ar-
tistico, che s’innalzerà altissimo per la tenacia dei due
chiari compilatori, per la serietà degli scrittori chia-
mati a raccolta.
A. Venturi.
Dott. Icilio Guareschi -.Sui colori degli an-
tichi. (Estratto dal Supplemento annuale
all’Enciclopedia di chimica, voi. XXI, 1905).
Il prezioso antico trattatello sulla tecnica della mi-
niatura, classificato fra i manoscritti della Biblioteca
Nazionale di Napoli col titolo De Arte Illuminandi,
non poteva trovare un più egregio commentatore.
Scoperto nel 1877 dall’illustre Padre Caravita, esso
venne già fatto oggetto di speciale studio da Deme-
trio Salazaro che lo pubblicò in quell’anno con an-
notazioni sue, e quindi dal Lecoy de la Marche circa
dieci anni dopo. Ma le due edizioni certo non prive
di pregio, lasciavano per certi’ riguardi a desiderare
perchè curate da chi era quasi del tutto digiuno di
seria cultura scientifica. Infatti il trattatello se offre
interesse per la storia dell’arte, non meno è degno
di studio per la storia della chimica in generale. Al
Guareschi, il valente scenziato che tutti conoscono,
non fu dunque difficile rilevare molti errori in cui
erano incorsi i suoi due predecessori, e aggiungere
preziose e precise notizie tecniche nelle numerose note
che egli appose al testo.
Quanto al tempo della composizione del trattatello
che sarebbe o l’originale o una copia antica, il Sala-
zaro lo pone nei primi del secolo xiv e il Lecoy nello
scorcio del medesimo secolo, e ciò principalmente per
considerazioni paleografiche. Pur notando la maggior
importanza che avrebbe il De Arte Illuminandi quando
fosse dimostrato che il manoscritto è della prima metà
del 300, cioè anteriore al Cennini, il Guareschi non
esita invece ad assegnargli una data assai più tarda,
posteriore forse al 1500, è ciò specialmente perchè
l’anonimo autore discorre di sostanze le quali prima
di quest’epoca non si usavano nella pittura o non
erano conosciute nel commercio europeo. Non siamo
però d’accordo col Guareschi quando egli afferma di
credere di esser nel vero circa la relativa modernità
del trattato « riflettendo che il numero maggiore dei
più grandi miniatori è dei secoli xv e xvi » e che
quindi si capisce come nel Cinquecento si potesse sen-
tire la necessità di un trattato speciale sulla minia-
tura, ma non già nel secolo xiv « nel qual tempo
erano relativamente pochi i veri miniatori ». Ora per
annuire a tale asserzione bisognerebbe dimenticare la
splendida fioritura che l’arte del minio ebbe a Siena,
Napoli e Bologna appunto in questo stesso secolo,
dal Guareschi così ingiustamente disprezzato.
Per assegnare una data relativamente esatta al ma-
noscritto, sarebbe piuttosto indispensabile un attento
esame della paleografia, nè noi moviamo rimprovero
al Guareschi di confessare sinceramente la sua incom-
petenza in materia. È certo però che s’egli avesse ri-
corso ai lumi di un qualche specialista, avrebbe anche
potuto più validamente oppugnare gli argomenti di cui
si fan forti e il Salazaro e il Lecoy. In un vero errore
incorre però il Guareschi laddove afferma che Attavante
degli Attavanti « a quanto sembra appartiene alla scuola
del Mantegna ». Non sappiamo ove il Guareschi abbia
attinto la notizia : certo è che basta gettar gli occhi
sopra una pergamena adornata da Attavante per scor-
gere che si ha a che fare col più fiorentino dei mi-
niatori, strettamente ligio all’arte di Domenico Ghir-
landaio.
Ma più che indugiarci attorno a questi piccoli nèi,
converrebbe esaminare attentamente il dotto capitolo
di Introduzione intorno ai colori degli antichi che con-
tiene notizie preziose sulla tecnica dei colori e ralle
non poche opere medioevali che si riferiscono alla chi-
mica dei colori e alle arti tecniche e decorative. Lo
spazio limitato non ci consente di farlo adesso ; non
ci vieta però di raccomandarne caldamente la lettura
a quanti si occupano di studi di storia artistica e spe-
cialmente a tutti coloro che hanno dimestichezza colla
tavolozza e i pennelli, certi che ne potran ricavare un
qualche pratico ed utile ammaestramento.
Paolo D’Ancona.
75
l’Armand che discorsero delle medaglie di lui: no-
tiamo ciò per eccitare sempre più i dotti imprenditori
del dizionario artistico a volere ammodernare in ogni
articolo la bibliografia in generale diligentissima.
Pag. 447 e pag. 454. Maestro Andrea, scultore in
Roma. L’enigmatico artista, che si firma opus Andreae,
in una Madonna verrocchiesca, esistente nell’ospedale
di San Giacomo in Roma, non può essere identifi-
cato con Andrea di Maso da Firenze che fioriva
nel 1499. Corre una notevole distanza di tempo dalla
data supponibile del bassorilievo a quella dell’atti-
vità, ancora indefinita di quel certo Andrea di Maso.
Abbiamo fatto questi pochi appunti, per dimostrare
d’avere scorso il volume veramente esemplare, più
che per ridire sull’opera ammirata e ammirevole per
la dottrina, per l’ordine e per l’accortezza nella scelta
degli scrittori. In un lavoro di tanta vastità, è ben fa-
cile di trovar qualche menda. Per averne accennato
alcuna non si tacci di pedanteria noi che plaudiamo
coscienti all’inaugurazione del monumento storico ar-
tistico, che s’innalzerà altissimo per la tenacia dei due
chiari compilatori, per la serietà degli scrittori chia-
mati a raccolta.
A. Venturi.
Dott. Icilio Guareschi -.Sui colori degli an-
tichi. (Estratto dal Supplemento annuale
all’Enciclopedia di chimica, voi. XXI, 1905).
Il prezioso antico trattatello sulla tecnica della mi-
niatura, classificato fra i manoscritti della Biblioteca
Nazionale di Napoli col titolo De Arte Illuminandi,
non poteva trovare un più egregio commentatore.
Scoperto nel 1877 dall’illustre Padre Caravita, esso
venne già fatto oggetto di speciale studio da Deme-
trio Salazaro che lo pubblicò in quell’anno con an-
notazioni sue, e quindi dal Lecoy de la Marche circa
dieci anni dopo. Ma le due edizioni certo non prive
di pregio, lasciavano per certi’ riguardi a desiderare
perchè curate da chi era quasi del tutto digiuno di
seria cultura scientifica. Infatti il trattatello se offre
interesse per la storia dell’arte, non meno è degno
di studio per la storia della chimica in generale. Al
Guareschi, il valente scenziato che tutti conoscono,
non fu dunque difficile rilevare molti errori in cui
erano incorsi i suoi due predecessori, e aggiungere
preziose e precise notizie tecniche nelle numerose note
che egli appose al testo.
Quanto al tempo della composizione del trattatello
che sarebbe o l’originale o una copia antica, il Sala-
zaro lo pone nei primi del secolo xiv e il Lecoy nello
scorcio del medesimo secolo, e ciò principalmente per
considerazioni paleografiche. Pur notando la maggior
importanza che avrebbe il De Arte Illuminandi quando
fosse dimostrato che il manoscritto è della prima metà
del 300, cioè anteriore al Cennini, il Guareschi non
esita invece ad assegnargli una data assai più tarda,
posteriore forse al 1500, è ciò specialmente perchè
l’anonimo autore discorre di sostanze le quali prima
di quest’epoca non si usavano nella pittura o non
erano conosciute nel commercio europeo. Non siamo
però d’accordo col Guareschi quando egli afferma di
credere di esser nel vero circa la relativa modernità
del trattato « riflettendo che il numero maggiore dei
più grandi miniatori è dei secoli xv e xvi » e che
quindi si capisce come nel Cinquecento si potesse sen-
tire la necessità di un trattato speciale sulla minia-
tura, ma non già nel secolo xiv « nel qual tempo
erano relativamente pochi i veri miniatori ». Ora per
annuire a tale asserzione bisognerebbe dimenticare la
splendida fioritura che l’arte del minio ebbe a Siena,
Napoli e Bologna appunto in questo stesso secolo,
dal Guareschi così ingiustamente disprezzato.
Per assegnare una data relativamente esatta al ma-
noscritto, sarebbe piuttosto indispensabile un attento
esame della paleografia, nè noi moviamo rimprovero
al Guareschi di confessare sinceramente la sua incom-
petenza in materia. È certo però che s’egli avesse ri-
corso ai lumi di un qualche specialista, avrebbe anche
potuto più validamente oppugnare gli argomenti di cui
si fan forti e il Salazaro e il Lecoy. In un vero errore
incorre però il Guareschi laddove afferma che Attavante
degli Attavanti « a quanto sembra appartiene alla scuola
del Mantegna ». Non sappiamo ove il Guareschi abbia
attinto la notizia : certo è che basta gettar gli occhi
sopra una pergamena adornata da Attavante per scor-
gere che si ha a che fare col più fiorentino dei mi-
niatori, strettamente ligio all’arte di Domenico Ghir-
landaio.
Ma più che indugiarci attorno a questi piccoli nèi,
converrebbe esaminare attentamente il dotto capitolo
di Introduzione intorno ai colori degli antichi che con-
tiene notizie preziose sulla tecnica dei colori e ralle
non poche opere medioevali che si riferiscono alla chi-
mica dei colori e alle arti tecniche e decorative. Lo
spazio limitato non ci consente di farlo adesso ; non
ci vieta però di raccomandarne caldamente la lettura
a quanti si occupano di studi di storia artistica e spe-
cialmente a tutti coloro che hanno dimestichezza colla
tavolozza e i pennelli, certi che ne potran ricavare un
qualche pratico ed utile ammaestramento.
Paolo D’Ancona.