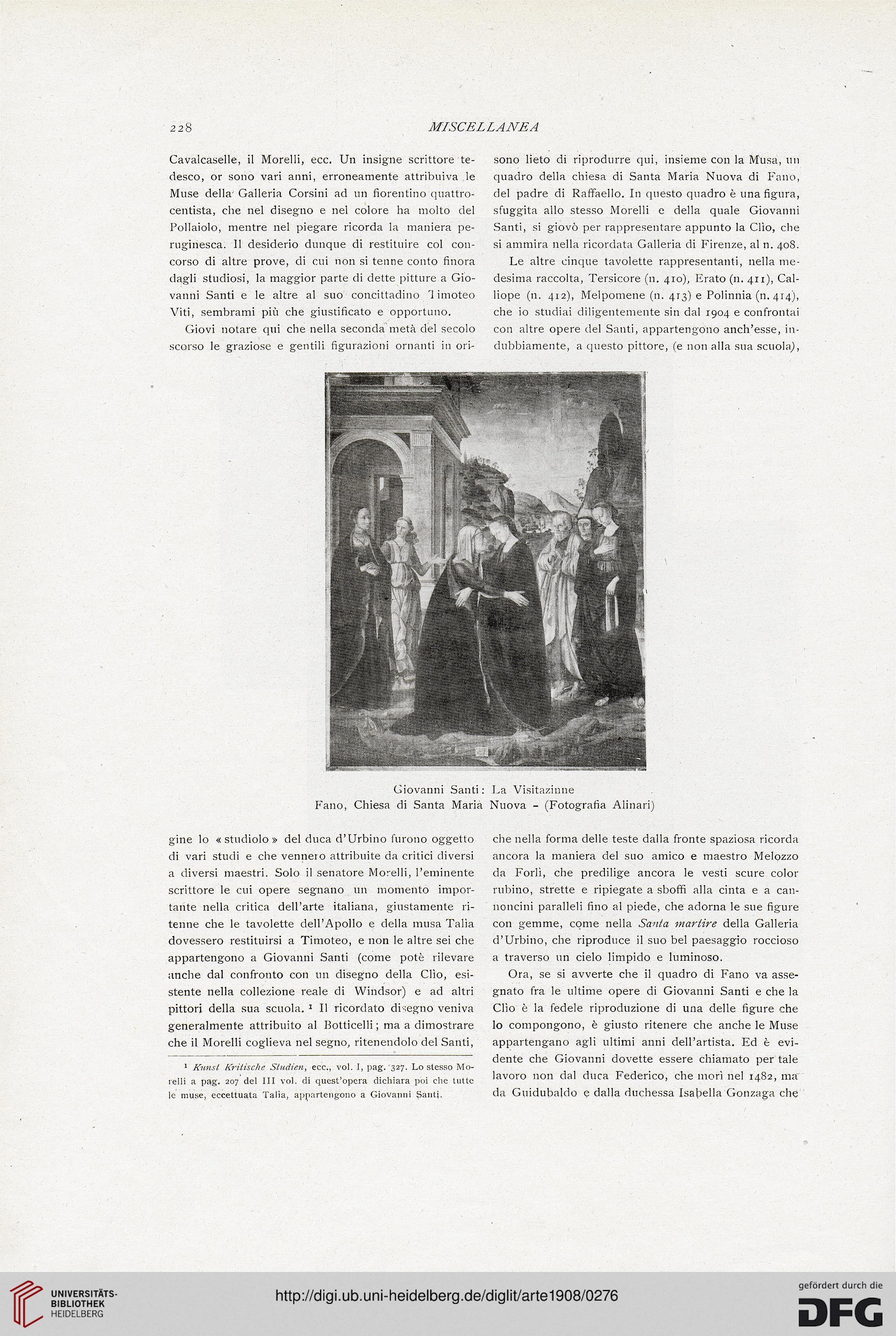228
MISCELLANEA
Cavalcasene, il Morelli, ecc. Un insigne scrittore te-
desco, or sono vari anni, erroneamente attribuiva le
Muse della Galleria Corsini ad un fiorentino quattro-
centista, che nel disegno e nel colore ha molto del
Pollaiolo, mentre nel piegare ricorda la maniera pe-
ruginesca. 11 desiderio dunque di restituire col con-
corso di altre prove, di cui non si tenne conto finora
dagli studiosi, la maggior parte di dette pitture a Gio-
vanni Santi e le altre al suo concittadino 1 imoteo
Viti, sembrami più che giustificato e opportuno.
Giovi notare qui che nella seconda metà del secolo
scorso le graziose e gentili figurazioni ornanti in ori-
sono lieto di riprodurre qui, insieme con la Musa, un
quadro della chiesa di Santa Maria Nuova di Fano,
del padre di Raffaello. In questo quadro è una figura,
sfuggita allo stesso Morelli e della quale Giovanni
Santi, si giovò per rappresentare appunto la Clio, che
si ammira nella ricordata Galleria di Firenze, al n. 408.
Le altre cinque tavolette rappresentanti, nella me-
desima raccolta, Tersicore (n. 410), Erato (n. 411), Cal-
liope (n. 412), Melpomene (n. 413) e Polinnia (n. 414),
che io studiai diligentemente sin dal 1904 e confrontai
con altre opere del Santi, appartengono anch’esse, in-
dubbiamente, a questo pittore, (e non alla sua scuola),
Giovanni Santi : La Visitazione
Fano, Chiesa di Santa Maria Nuova - (Fotografia Alinari)
gine lo «studiolo» del duca d’Urbino furono oggetto
di vari studi e che vennero attribuite da critici diversi
a diversi maestri. Solo il senatore Morelli, l’eminente
scrittore le cui opere segnano un momento impor-
tante nella critica dell’arte italiana, giustamente ri-
tenne che le tavolette dell’Apollo e della musa Talia
dovessero restituirsi a Timoteo, e non le altre sei che
appartengono a Giovanni Santi (come potè rilevare
anche dal confronto con un disegno della Clio, esi-
stente nella collezione reale di Windsor) e ad altri
pittori della sua scuola. 1 II ricordato disegno veniva
generalmente attribuito al Botticelli ; ma a dimostrare
che il Morelli coglieva nel segno, ritenendolo del Santi,
J Kunst Kritischè Studicn, ecc., voi. I, pag. 327. Lo stesso Mo-
rei 1 i a pag. 207 del III voi. di quest’opera dichiara poi che tutte
le muse, eccettuata Talìa, appartengono a Giovanni Santi.
che nella forma delle teste dalla fronte spaziosa ricorda
ancora la maniera del suo amico e maestro Melozzo
da Forlì, che predilige ancora le vesti scure color
rubino, strette e ripiegate a sboffi alla cinta e a can-
noncini paralleli fino al piede, che adorna le sue figure
con gemme, come nella Santa martire della Galleria
d’Urbino, che riproduce il suo bel paesaggio roccioso
a traverso un cielo limpido e luminoso.
Ora, se si avverte che il quadro di Fano va asse-
gnato fra le ultime opere di Giovanni Santi e che la
Clio è la fedele riproduzione di una delle figure che
lo compongono, è giusto ritenere che anche le Muse
appartengano agli ultimi anni dell’artista. Ed è evi-
dente che Giovanni dovette essere chiamato per tale
lavoro non dal duca Federico, che mori nel 1482, ma
da Guidubaldo e dalla duchessa Isabella Gonzaga che
MISCELLANEA
Cavalcasene, il Morelli, ecc. Un insigne scrittore te-
desco, or sono vari anni, erroneamente attribuiva le
Muse della Galleria Corsini ad un fiorentino quattro-
centista, che nel disegno e nel colore ha molto del
Pollaiolo, mentre nel piegare ricorda la maniera pe-
ruginesca. 11 desiderio dunque di restituire col con-
corso di altre prove, di cui non si tenne conto finora
dagli studiosi, la maggior parte di dette pitture a Gio-
vanni Santi e le altre al suo concittadino 1 imoteo
Viti, sembrami più che giustificato e opportuno.
Giovi notare qui che nella seconda metà del secolo
scorso le graziose e gentili figurazioni ornanti in ori-
sono lieto di riprodurre qui, insieme con la Musa, un
quadro della chiesa di Santa Maria Nuova di Fano,
del padre di Raffaello. In questo quadro è una figura,
sfuggita allo stesso Morelli e della quale Giovanni
Santi, si giovò per rappresentare appunto la Clio, che
si ammira nella ricordata Galleria di Firenze, al n. 408.
Le altre cinque tavolette rappresentanti, nella me-
desima raccolta, Tersicore (n. 410), Erato (n. 411), Cal-
liope (n. 412), Melpomene (n. 413) e Polinnia (n. 414),
che io studiai diligentemente sin dal 1904 e confrontai
con altre opere del Santi, appartengono anch’esse, in-
dubbiamente, a questo pittore, (e non alla sua scuola),
Giovanni Santi : La Visitazione
Fano, Chiesa di Santa Maria Nuova - (Fotografia Alinari)
gine lo «studiolo» del duca d’Urbino furono oggetto
di vari studi e che vennero attribuite da critici diversi
a diversi maestri. Solo il senatore Morelli, l’eminente
scrittore le cui opere segnano un momento impor-
tante nella critica dell’arte italiana, giustamente ri-
tenne che le tavolette dell’Apollo e della musa Talia
dovessero restituirsi a Timoteo, e non le altre sei che
appartengono a Giovanni Santi (come potè rilevare
anche dal confronto con un disegno della Clio, esi-
stente nella collezione reale di Windsor) e ad altri
pittori della sua scuola. 1 II ricordato disegno veniva
generalmente attribuito al Botticelli ; ma a dimostrare
che il Morelli coglieva nel segno, ritenendolo del Santi,
J Kunst Kritischè Studicn, ecc., voi. I, pag. 327. Lo stesso Mo-
rei 1 i a pag. 207 del III voi. di quest’opera dichiara poi che tutte
le muse, eccettuata Talìa, appartengono a Giovanni Santi.
che nella forma delle teste dalla fronte spaziosa ricorda
ancora la maniera del suo amico e maestro Melozzo
da Forlì, che predilige ancora le vesti scure color
rubino, strette e ripiegate a sboffi alla cinta e a can-
noncini paralleli fino al piede, che adorna le sue figure
con gemme, come nella Santa martire della Galleria
d’Urbino, che riproduce il suo bel paesaggio roccioso
a traverso un cielo limpido e luminoso.
Ora, se si avverte che il quadro di Fano va asse-
gnato fra le ultime opere di Giovanni Santi e che la
Clio è la fedele riproduzione di una delle figure che
lo compongono, è giusto ritenere che anche le Muse
appartengano agli ultimi anni dell’artista. Ed è evi-
dente che Giovanni dovette essere chiamato per tale
lavoro non dal duca Federico, che mori nel 1482, ma
da Guidubaldo e dalla duchessa Isabella Gonzaga che