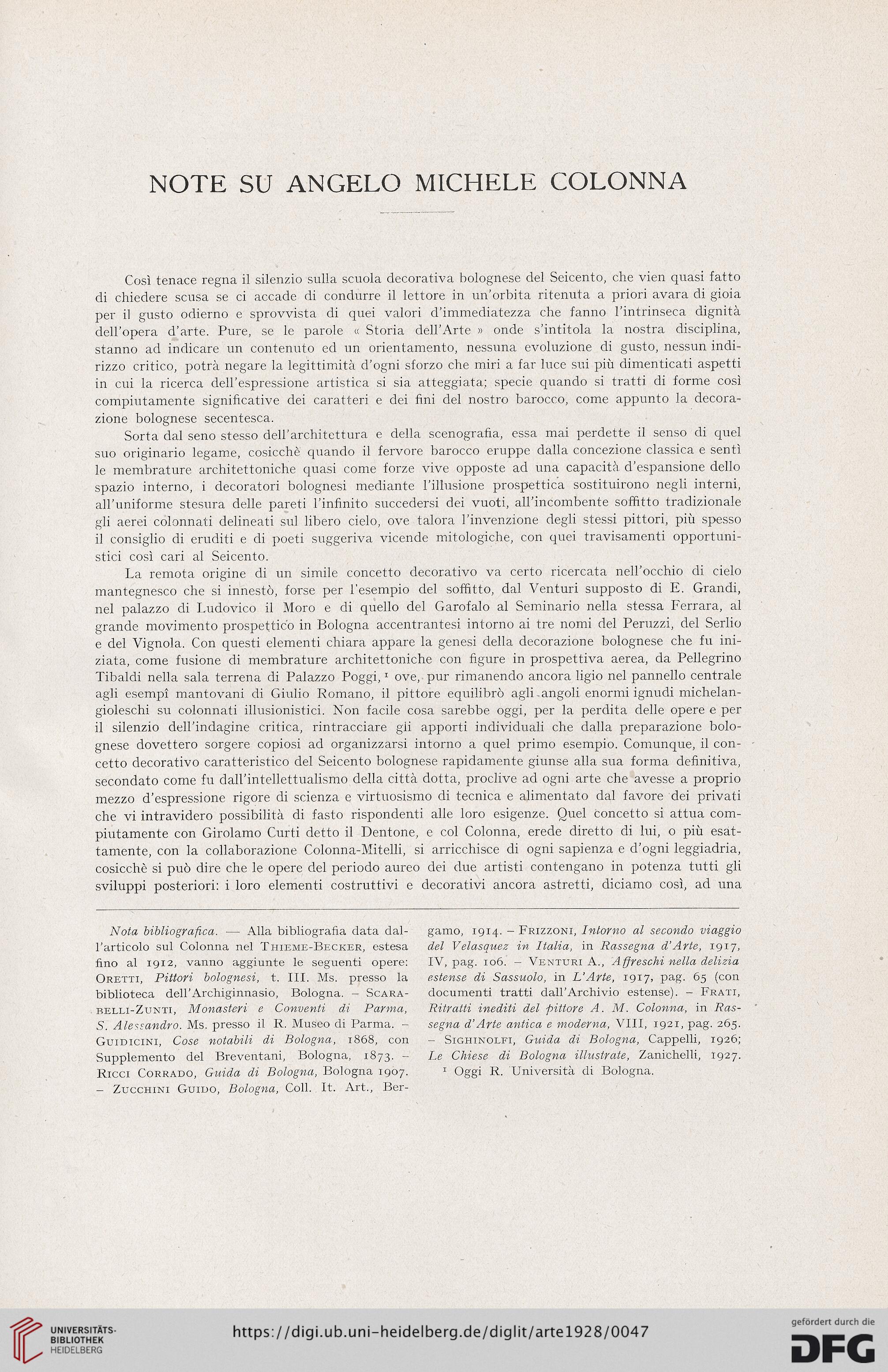NOTE SU ANGELO MICHELE COLONNA
Così tenace regna il silenzio sulla scuola decorativa bolognese del Seicento, che vien quasi fatto
di chiedere scusa se ci accade di condurre il lettore in un’orbita ritenuta a priori avara di gioia
per il gusto odierno e sprovvista di quei valori d’immediatezza che fanno l’intrinseca dignità
dell’opera d’arte. Pure, se le parole « Storia dell’Arte » onde s’intitola la nostra disciplina,
stanno ad indicare un contenuto ed un orientamento, nessuna evoluzione di gusto, nessun indi-
rizzo critico, potrà negare la legittimità d’ogni sforzo che miri a far luce sui più dimenticati aspetti
in cui la ricerca dell’espressione artistica si sia atteggiata; specie quando si tratti di forme così
compiutamente significative dei caratteri e dei fini del nostro barocco, come appunto la decora-
zione bolognese secentesca.
Sorta dal seno stesso dell’architettura e della scenografia, essa mai perdette il senso di quel
suo originario legame, cosicché quando il fervore barocco eruppe dalla concezione classica e sentì
le membrature architettoniche quasi come forze vive opposte ad una capacità d’espansione dello
spazio interno, i decoratori bolognesi mediante l’illusione prospettica sostituirono negli interni,
all’uniforme stesura delle pareti l’infinito succedersi dei vuoti, all’incombente soffitto tradizionale
gli aerei colonnati delineati sul libero cielo, ove talora l’invenzione degli stessi pittori, più spesso
il consiglio di eruditi e di poeti suggeriva vicende mitologiche, con quei travisamenti opportuni-
stici così cari al Seicento.
La remota origine di un simile concetto decorativo va certo ricercata nell’occhio di cielo
mantegnesco che si innestò, forse per l’esempio del soffitto, dal Venturi supposto di E. Grandi,
nel palazzo di Ludovico il Moro e di quello del Garofalo al Seminario nella stessa Ferrara, al
grande movimento prospettico in Bologna accentrantesi intorno ai tre nomi del Peruzzi, del Serlio
e del Vignola. Con questi elementi chiara appare la genesi della decorazione bolognese che fu ini-
ziata, come fusione di membrature architettoniche con figure in prospettiva aerea, da Pellegrino
Tibaldi nella sala terrena di Palazzo Poggi,1 ove, pur rimanendo ancora ligio nel pannello centrale
agli esempi mantovani di Giulio Romano, il pittore equilibrò agli angoli enormi ignudi michelan-
gioleschi su colonnati illusionistici. Non facile cosa sarebbe oggi, per la perdita delle opere e per
il silenzio dell’indagine critica, rintracciare gii apporti individuali che dalla preparazione bolo-
gnese dovettero sorgere copiosi ad organizzarsi intorno a quel primo esempio. Comunque, il con-
cetto decorativo caratteristico del Seicento bolognese rapidamente giunse alla sua forma definitiva,
secondato come fu dall’intellettualismo della città dotta, proclive ad ogni arte che avesse a proprio
mezzo d’espressione rigore di scienza e virtuosismo di tecnica e alimentato dal favore dei privati
che vi intravidero possibilità di fasto rispondenti alle loro esigenze. Quel Concetto si attua com-
piutamente con Girolamo Curti detto il Dentone, e col Colonna, erede diretto di lui, o più esat-
tamente, con la collaborazione Colonna-Mitelli, si arricchisce di ogni sapienza e d’ogni leggiadria,
cosicché si può dire che le opere del periodo aureo dei due artisti contengano in potenza tutti gli
sviluppi posteriori: i loro elementi costruttivi e decorativi ancora astretti, diciamo così, ad una
Nota bibliografica. — Alla bibliografìa data dal-
l’articolo sul Colonna nel Thieme-Becker, estesa
fino al 1912, vanno aggiunte le seguenti opere:
Gretti, Pittori bolognesi, t. III. Ms. presso la
biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna. - Scara-
belli-Zunti, Monasteri e Conventi di Parma,
S. Alessandro. Ms. presso il R. Museo di Parma. -
Guidicini, Cose notabili di Bologna, 1868, con
Supplemento del Breventani, Bologna, 1873. -
Ricci Corrado, Guida di Bologna, Bologna 1907.
- Zucchini Guido, Bologna, Coll. It. Art., Ber-
gamo, 1914. - Frizzoni, Intorno al secondo viaggio
del Velasquez in Italia, in Rassegna d'Arte, 1917,
IV, pag. 106. - Venturi A., Affreschi nella delizia
estense di Sassuolo, in L'Arte, 1917, pag. 65 (con
documenti tratti dall’Archivio estense). - Frati,
Ritratti inediti del pittore A. M. Colonna, in Ras-
segna d’Arte antica e moderna, Vili, 1921, pag. 265.
- Sighinoi.fi, Guida di Bologna, Cappelli, 1926;
Le Chiese di Bologna illustrate, Zanichelli, 1927.
1 Oggi R. Università di Bologna.
Così tenace regna il silenzio sulla scuola decorativa bolognese del Seicento, che vien quasi fatto
di chiedere scusa se ci accade di condurre il lettore in un’orbita ritenuta a priori avara di gioia
per il gusto odierno e sprovvista di quei valori d’immediatezza che fanno l’intrinseca dignità
dell’opera d’arte. Pure, se le parole « Storia dell’Arte » onde s’intitola la nostra disciplina,
stanno ad indicare un contenuto ed un orientamento, nessuna evoluzione di gusto, nessun indi-
rizzo critico, potrà negare la legittimità d’ogni sforzo che miri a far luce sui più dimenticati aspetti
in cui la ricerca dell’espressione artistica si sia atteggiata; specie quando si tratti di forme così
compiutamente significative dei caratteri e dei fini del nostro barocco, come appunto la decora-
zione bolognese secentesca.
Sorta dal seno stesso dell’architettura e della scenografia, essa mai perdette il senso di quel
suo originario legame, cosicché quando il fervore barocco eruppe dalla concezione classica e sentì
le membrature architettoniche quasi come forze vive opposte ad una capacità d’espansione dello
spazio interno, i decoratori bolognesi mediante l’illusione prospettica sostituirono negli interni,
all’uniforme stesura delle pareti l’infinito succedersi dei vuoti, all’incombente soffitto tradizionale
gli aerei colonnati delineati sul libero cielo, ove talora l’invenzione degli stessi pittori, più spesso
il consiglio di eruditi e di poeti suggeriva vicende mitologiche, con quei travisamenti opportuni-
stici così cari al Seicento.
La remota origine di un simile concetto decorativo va certo ricercata nell’occhio di cielo
mantegnesco che si innestò, forse per l’esempio del soffitto, dal Venturi supposto di E. Grandi,
nel palazzo di Ludovico il Moro e di quello del Garofalo al Seminario nella stessa Ferrara, al
grande movimento prospettico in Bologna accentrantesi intorno ai tre nomi del Peruzzi, del Serlio
e del Vignola. Con questi elementi chiara appare la genesi della decorazione bolognese che fu ini-
ziata, come fusione di membrature architettoniche con figure in prospettiva aerea, da Pellegrino
Tibaldi nella sala terrena di Palazzo Poggi,1 ove, pur rimanendo ancora ligio nel pannello centrale
agli esempi mantovani di Giulio Romano, il pittore equilibrò agli angoli enormi ignudi michelan-
gioleschi su colonnati illusionistici. Non facile cosa sarebbe oggi, per la perdita delle opere e per
il silenzio dell’indagine critica, rintracciare gii apporti individuali che dalla preparazione bolo-
gnese dovettero sorgere copiosi ad organizzarsi intorno a quel primo esempio. Comunque, il con-
cetto decorativo caratteristico del Seicento bolognese rapidamente giunse alla sua forma definitiva,
secondato come fu dall’intellettualismo della città dotta, proclive ad ogni arte che avesse a proprio
mezzo d’espressione rigore di scienza e virtuosismo di tecnica e alimentato dal favore dei privati
che vi intravidero possibilità di fasto rispondenti alle loro esigenze. Quel Concetto si attua com-
piutamente con Girolamo Curti detto il Dentone, e col Colonna, erede diretto di lui, o più esat-
tamente, con la collaborazione Colonna-Mitelli, si arricchisce di ogni sapienza e d’ogni leggiadria,
cosicché si può dire che le opere del periodo aureo dei due artisti contengano in potenza tutti gli
sviluppi posteriori: i loro elementi costruttivi e decorativi ancora astretti, diciamo così, ad una
Nota bibliografica. — Alla bibliografìa data dal-
l’articolo sul Colonna nel Thieme-Becker, estesa
fino al 1912, vanno aggiunte le seguenti opere:
Gretti, Pittori bolognesi, t. III. Ms. presso la
biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna. - Scara-
belli-Zunti, Monasteri e Conventi di Parma,
S. Alessandro. Ms. presso il R. Museo di Parma. -
Guidicini, Cose notabili di Bologna, 1868, con
Supplemento del Breventani, Bologna, 1873. -
Ricci Corrado, Guida di Bologna, Bologna 1907.
- Zucchini Guido, Bologna, Coll. It. Art., Ber-
gamo, 1914. - Frizzoni, Intorno al secondo viaggio
del Velasquez in Italia, in Rassegna d'Arte, 1917,
IV, pag. 106. - Venturi A., Affreschi nella delizia
estense di Sassuolo, in L'Arte, 1917, pag. 65 (con
documenti tratti dall’Archivio estense). - Frati,
Ritratti inediti del pittore A. M. Colonna, in Ras-
segna d’Arte antica e moderna, Vili, 1921, pag. 265.
- Sighinoi.fi, Guida di Bologna, Cappelli, 1926;
Le Chiese di Bologna illustrate, Zanichelli, 1927.
1 Oggi R. Università di Bologna.