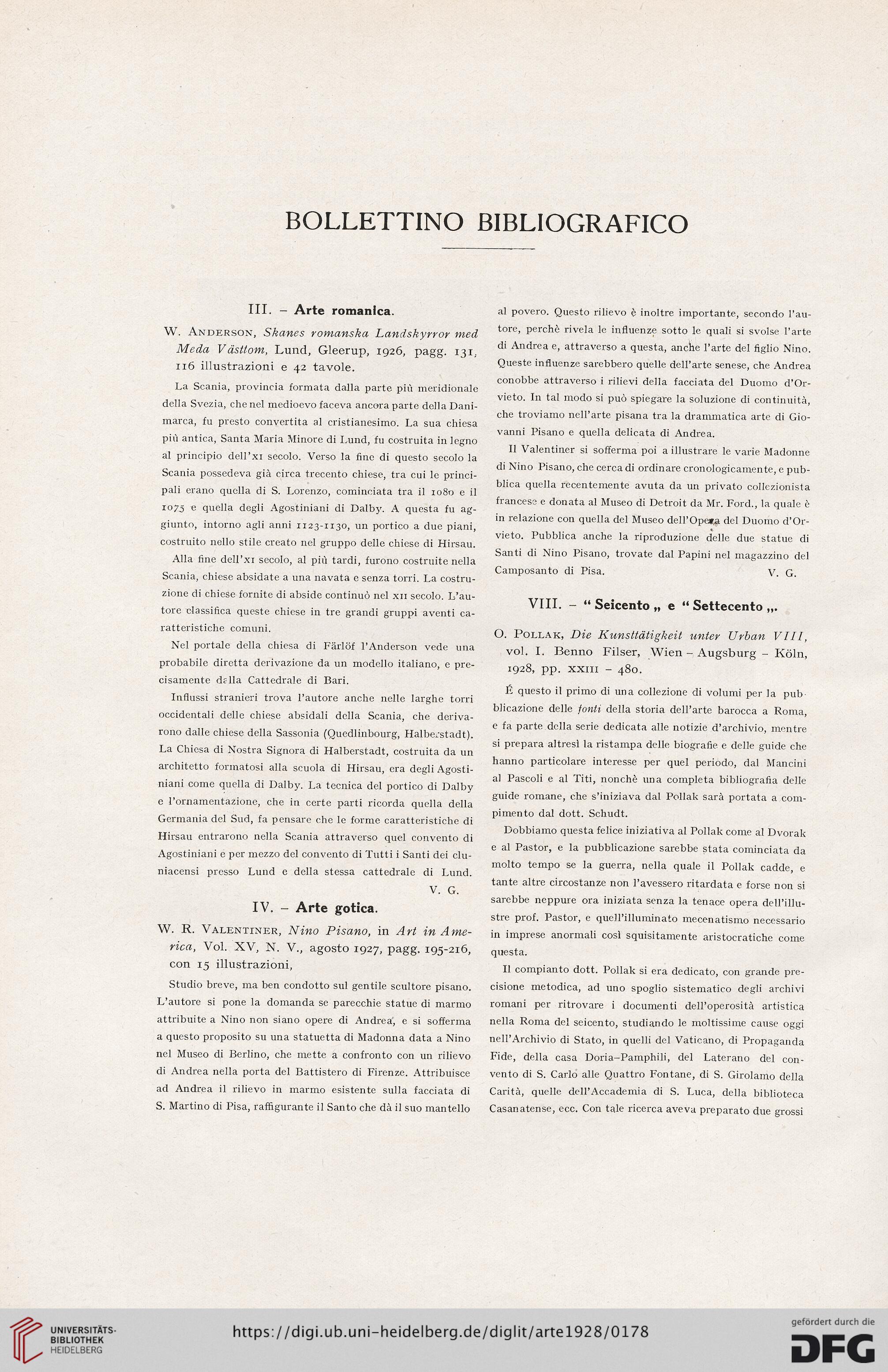BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
III. - Arte romanica.
W. Anderson, Skanes romanska Landskyrror med
Meda Vàsttom, Lund, Gleerup, 1926, pagg. 131,
116 illustrazioni e 42 tavole.
La Scania, provincia formata dalla parte più meridionale
della Svezia, che nel medioevo faceva ancora parte della Dani-
marca, fu presto convertita al cristianesimo. La sua chiesa
più antica, Santa Maria Minore di Lund, fu costruita in legno
al principio dell’xi secolo. Verso la fine di questo secolo la
Scania possedeva già circa trecento chiese, tra cui le princi-
pali erano quella di S. Lorenzo, cominciata tra il 1080 e il
ioZ5 « quella degli Agostiniani di Dalby. A questa fu ag-
giunto, intorno agli anni 1123-1130, un portico a due piani,
costruito nello stile creato nel gruppo delle chiese di Hirsau.
Alla fine dell’xi secolo, al più tardi, furono costruite nella
Scania, chiese absidate a una navata e senza torri. La costru-
zione di chiese fornite di abside continuò nel xn secolo. L’au-
tore classifica queste chiese in tre grandi gruppi aventi ca-
ratteristiche comuni.
Nel portale della chiesa di Fàrlòf l’Anderson vede una
probabile diretta derivazione da un modello italiano, e pre-
cisamente dalla Cattedrale di Bari.
Influssi stranieri trova l’autore anche nelle larghe torri
occidentali delle chiese absidali della Scania, che deriva-
rono dalle chiese della Sassonia (Quedlinbourg, Halberstadt).
La Chiesa di Nostra Signora di Halberstadt, costruita da un
architetto formatosi alla scuola di Hirsau, era degli Agosti-
niani come quella di Dalby. La tecnica del portico di Dalby
e l’ornamentazione, che in certe parti ricorda quella della
Germania del Sud, fa pensare che le forme caratteristiche di
Hirsau entrarono nella Scania attraverso quel convento di
Agostiniani e per mezzo del convento di Tutti i Santi dei clu-
niacensi presso Lund e della stessa cattedrale di Lund.
V. G.
IV. - Arte gotica.
W. R. Valentiner, Nino Pisano, in Art in Ame-
rica, Voi. XV, N. V., agosto 1927, pagg. 195-216,
con 15 illustrazioni,
Studio breve, ma ben condotto sul gentile scultore pisano.
L’autore si pone la domanda se parecchie statue di marmo
attribuite a Nino non siano opere di Andrea', e si sofferma
a questo proposito su una statuetta di Madonna data a Nino
nel Museo di Berlino, che mette a confronto con un rilievo
di Andrea nella porta del Battistero di Firenze. Attribuisce
ad Andrea il rilievo in marmo esistente sulla facciata di
S. Martino di Pisa, raffigurante il Santo che dà il suo mantello
al povero. Questo rilievo è inoltre importante, secondo l’au-
tore, perchè rivela le influenze sotto le quali si svolse l’arte
di Andrea e, attraverso a questa, anche l’arte del figlio Nino.
Queste influenze sarebbero quelle dell’arte senese, che Andrea
conobbe attraverso i rilievi della facciata del Duomo d’Or-
vieto. In tal modo si può spiegare la soluzione di continuità,
che troviamo nell’arte pisana tra la drammatica arte di Gio-
vanni Pisano e quella delicata di Andrea.
Il Valentiner si sofferma poi a illustrare le varie Madonne
di Nino Pisano, che cerca di ordinare cronologicamente, e pub-
blica quella recentemente avuta da un privato collezionista
francese e donata al Museo di Detroit da Mr. Ford., la quale è
in relazione con quella del Museo dell’Ope*^ del Duomo d’Or-
vieto. Pubblica anche la riproduzione delle due statue di
Santi di Nino Pisano, trovate dal Papini nel magazzino del
Camposanto di Pisa. V. G.
Vili. - “ Seicento „ e “ Settecento „.
O. Pollak, Die Kunsttdtigkeit unter Urban Vili,
voi. I. Benno Filser, Wien - Augsburg - Kóln,
1928, pp. xxiii - 480.
É questo il primo di una collezione di volumi per la pub
blicazione delle fonti della storia dell’arte barocca a Roma,
e fa parte.della serie dedicata alle notizie d’archivio, mentre
si prepara altresì la ristampa delle biografie e delle guide che
hanno particolare interesse per quel periodo, dal Mancini
al Pascoli e al Titi, nonché una completa bibliografia delle
guide romane, che s’iniziava dal Pollak sarà portata a com-
pimento dal dott. Schudt.
Dobbiamo questa felice iniziativa al Pollak come al Dvorak
e al Pastor, e la pubblicazione sarebbe stata cominciata da
molto tempo se la guerra, nella quale il Pollak cadde, e
tante altre circostanze non l’avessero ritardata e forse non si
sarebbe neppure ora iniziata senza la tenace opera dell’illu-
stre prof. Pastor, e queU’illuminato mecenatismo necessario
in imprese anormali cosi squisitamente aristocratiche come
questa.
Il compianto dott. Pollak si era dedicato, con grande pre-
cisione metodica, ad uno spoglio sistematico degli archivi
romani per ritrovare i documenti dell’operosità artistica
nella Roma del seicento, studiando le moltissime cause oggi
nell’Archivio di Stato, in quelli del Vaticano, di Propaganda
Fide, della casa Doria-Pamphili, del Luterano del con-
vento di S. Carlo alle Quattro Fontane, di S. Girolamo della
Carità, quelle dell’Accademia di S. Luca, della biblioteca
Casanatense, ecc. Con tale ricerca aveva preparato due grossi
III. - Arte romanica.
W. Anderson, Skanes romanska Landskyrror med
Meda Vàsttom, Lund, Gleerup, 1926, pagg. 131,
116 illustrazioni e 42 tavole.
La Scania, provincia formata dalla parte più meridionale
della Svezia, che nel medioevo faceva ancora parte della Dani-
marca, fu presto convertita al cristianesimo. La sua chiesa
più antica, Santa Maria Minore di Lund, fu costruita in legno
al principio dell’xi secolo. Verso la fine di questo secolo la
Scania possedeva già circa trecento chiese, tra cui le princi-
pali erano quella di S. Lorenzo, cominciata tra il 1080 e il
ioZ5 « quella degli Agostiniani di Dalby. A questa fu ag-
giunto, intorno agli anni 1123-1130, un portico a due piani,
costruito nello stile creato nel gruppo delle chiese di Hirsau.
Alla fine dell’xi secolo, al più tardi, furono costruite nella
Scania, chiese absidate a una navata e senza torri. La costru-
zione di chiese fornite di abside continuò nel xn secolo. L’au-
tore classifica queste chiese in tre grandi gruppi aventi ca-
ratteristiche comuni.
Nel portale della chiesa di Fàrlòf l’Anderson vede una
probabile diretta derivazione da un modello italiano, e pre-
cisamente dalla Cattedrale di Bari.
Influssi stranieri trova l’autore anche nelle larghe torri
occidentali delle chiese absidali della Scania, che deriva-
rono dalle chiese della Sassonia (Quedlinbourg, Halberstadt).
La Chiesa di Nostra Signora di Halberstadt, costruita da un
architetto formatosi alla scuola di Hirsau, era degli Agosti-
niani come quella di Dalby. La tecnica del portico di Dalby
e l’ornamentazione, che in certe parti ricorda quella della
Germania del Sud, fa pensare che le forme caratteristiche di
Hirsau entrarono nella Scania attraverso quel convento di
Agostiniani e per mezzo del convento di Tutti i Santi dei clu-
niacensi presso Lund e della stessa cattedrale di Lund.
V. G.
IV. - Arte gotica.
W. R. Valentiner, Nino Pisano, in Art in Ame-
rica, Voi. XV, N. V., agosto 1927, pagg. 195-216,
con 15 illustrazioni,
Studio breve, ma ben condotto sul gentile scultore pisano.
L’autore si pone la domanda se parecchie statue di marmo
attribuite a Nino non siano opere di Andrea', e si sofferma
a questo proposito su una statuetta di Madonna data a Nino
nel Museo di Berlino, che mette a confronto con un rilievo
di Andrea nella porta del Battistero di Firenze. Attribuisce
ad Andrea il rilievo in marmo esistente sulla facciata di
S. Martino di Pisa, raffigurante il Santo che dà il suo mantello
al povero. Questo rilievo è inoltre importante, secondo l’au-
tore, perchè rivela le influenze sotto le quali si svolse l’arte
di Andrea e, attraverso a questa, anche l’arte del figlio Nino.
Queste influenze sarebbero quelle dell’arte senese, che Andrea
conobbe attraverso i rilievi della facciata del Duomo d’Or-
vieto. In tal modo si può spiegare la soluzione di continuità,
che troviamo nell’arte pisana tra la drammatica arte di Gio-
vanni Pisano e quella delicata di Andrea.
Il Valentiner si sofferma poi a illustrare le varie Madonne
di Nino Pisano, che cerca di ordinare cronologicamente, e pub-
blica quella recentemente avuta da un privato collezionista
francese e donata al Museo di Detroit da Mr. Ford., la quale è
in relazione con quella del Museo dell’Ope*^ del Duomo d’Or-
vieto. Pubblica anche la riproduzione delle due statue di
Santi di Nino Pisano, trovate dal Papini nel magazzino del
Camposanto di Pisa. V. G.
Vili. - “ Seicento „ e “ Settecento „.
O. Pollak, Die Kunsttdtigkeit unter Urban Vili,
voi. I. Benno Filser, Wien - Augsburg - Kóln,
1928, pp. xxiii - 480.
É questo il primo di una collezione di volumi per la pub
blicazione delle fonti della storia dell’arte barocca a Roma,
e fa parte.della serie dedicata alle notizie d’archivio, mentre
si prepara altresì la ristampa delle biografie e delle guide che
hanno particolare interesse per quel periodo, dal Mancini
al Pascoli e al Titi, nonché una completa bibliografia delle
guide romane, che s’iniziava dal Pollak sarà portata a com-
pimento dal dott. Schudt.
Dobbiamo questa felice iniziativa al Pollak come al Dvorak
e al Pastor, e la pubblicazione sarebbe stata cominciata da
molto tempo se la guerra, nella quale il Pollak cadde, e
tante altre circostanze non l’avessero ritardata e forse non si
sarebbe neppure ora iniziata senza la tenace opera dell’illu-
stre prof. Pastor, e queU’illuminato mecenatismo necessario
in imprese anormali cosi squisitamente aristocratiche come
questa.
Il compianto dott. Pollak si era dedicato, con grande pre-
cisione metodica, ad uno spoglio sistematico degli archivi
romani per ritrovare i documenti dell’operosità artistica
nella Roma del seicento, studiando le moltissime cause oggi
nell’Archivio di Stato, in quelli del Vaticano, di Propaganda
Fide, della casa Doria-Pamphili, del Luterano del con-
vento di S. Carlo alle Quattro Fontane, di S. Girolamo della
Carità, quelle dell’Accademia di S. Luca, della biblioteca
Casanatense, ecc. Con tale ricerca aveva preparato due grossi