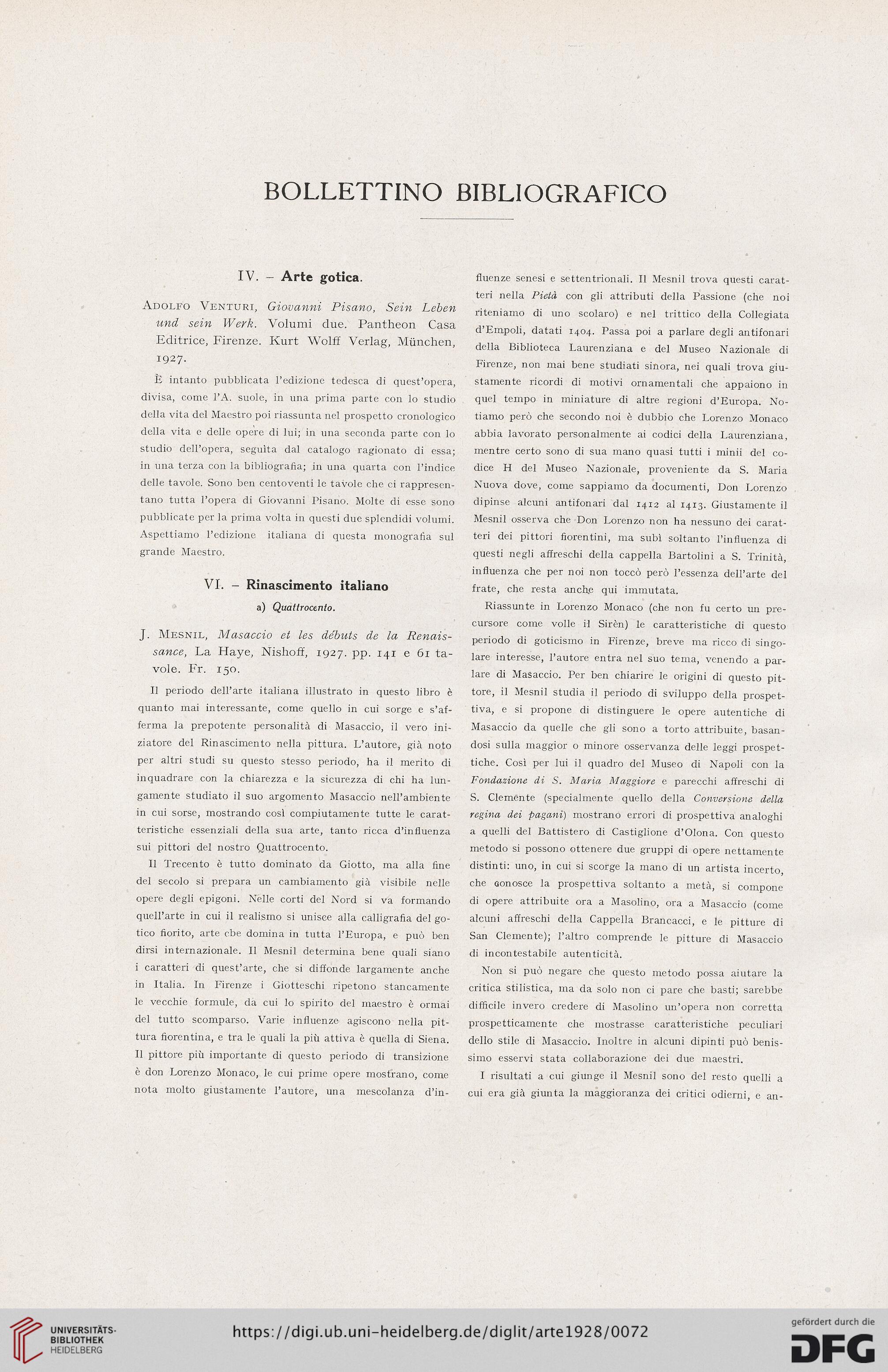BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
IV. - Arte gotica.
Adolfo Venturi, Giovanni Pisano, Sein Leben
und sein Werk. Volumi due. Pantheon Casa
Editrice, Firenze. Kurt Wolff Verlag, Munchen,
1927.
È intanto pubblicata l’edizione tedesca di quest’opera,
divisa, come l’A. suole, in una prima parte con lo studio
della vita del Maestro poi riassunta nel prospetto cronologico
della vita e delle opere di lui; in una seconda parte con lo
studio dell’opera, seguita dal catalogo ragionato di essa;
in una terza con la bibliografia; in una quarta con l’indice
delle tavole. Sono ben centoventi le tavole che ci rappresen-
tano tutta l’opera di Giovanni Pisano. Molte di esse sono
pubblicate per la prima volta in questi due splendidi volumi.
Aspettiamo l’edizione italiana di questa monografia sul
grande Maestro.
VI. - Rinascimento italiano
a) Quattrocento.
J. Mesnil, Masaccio et les débuts de la Renais-
sance, La Haye, Nishoif, 1927. pp. 141 e 61 ta-
vole. Fr. 150.
Il periodo dell’arte italiana illustrato in questo libro è
quanto mai interessante, come quello in cui sorge e s’af-
ferma la prepotente personalità di Masaccio, il vero ini-
ziatore del Rinascimento nella pittura. L’autore, già noto
per altri studi su questo stesso periodo, ha il merito di
inquadrare con la chiarezza e la sicurezza di chi ha lun-
gamente studiato il suo argomento Masaccio nell’ambiente
in cui sorse, mostrando così compiutamente tutte le carat-
teristiche essenziali della sua arte, tanto ricca d’influenza
sui pittori del nostro Quattrocento.
Il Trecento è tutto dominato da Giotto, ma alla fine
del secolo si prepara un cambiamento già visibile nelle
opere degli epigoni. Nelle corti del Nord si va formando
quell’arte in cui il realismo si unisce alla calligrafia del go-
tico fiorito, arte cbe domina in tutta l’Europa, e può ben
dirsi internazionale. Il Mesnil determina bene quali siano
i caratteri di quest’arte, che si diffonde largamente anche
in Italia. In Firenze i Giotteschi ripetono stancamente
le vecchie formule, da cui lo spirito del maestro è ormai
del tutto scomparso. Varie influenze agiscono nella pit-
tura fiorentina, e tra le quali la più attiva è quella di Siena.
Il pittore più importante di questo periodo di transizione
è don Lorenzo Monaco, le cui prime opere mostrano, come
nota molto giustamente l’autore, una mescolanza d’in-
fluenze senesi e settentrionali. Il Mesnil trova questi carat-
teri nella Pietà con gli attributi della Passione (che noi
riteniamo di uno scolaro) e nel trittico della Collegiata
d’Empoli, datati 1404. Passa poi a parlare degli antifonari
della Biblioteca Laurenziana e del Museo Nazionale di
Firenze, non mai bene studiati sinora, nei quali trova giu-
stamente ricordi di motivi ornamentali che appaiono in
quel tempo in miniature di altre regioni d’Europa. No-
tiamo però che secondo noi è dubbio che Lorenzo Monaco
abbia lavorato personalmente ai codici della Laurenziana,
mentre certo sono di sua mano quasi tutti i minii del co-
dice H del Museo Nazionale, proveniente da S. Maria
Nuova dove, come sappiamo da documenti, Don Lorenzo
dipinse alcuni antifonari dal 1412 al 1413. Giustamente il
Mesnil osserva che Don Lorenzo non ha nessuno dei carat-
teri dei pittori fiorentini, ma subì soltanto l’influenza di
questi negli affreschi della cappella Bartolini a S. Trinità,
influenza che per noi non toccò però l’essenza dell’arte del
frate, che resta anche qui immutata.
Riassunte in Lorenzo Monaco (che non fu certo un pre-
cursore come volle il Sirèn) le caratteristiche di questo
periodo di goticismo in Firenze, breve ma ricco di singo-
lare interesse, l’autore entra nel suo tema, venendo a par-
lare di MaSaccio. Per ben chiarire le origini di questo pit-
tore, il Mesnil studia il periodo di sviluppo della prospet-
tiva, e si propone di distinguere le opere autentiche di
Masaccio da quelle che gli sono a torto attribuite, basan-
dosi sulla maggior o minore osservanza delle leggi prospet-
tiche. Così per lui il quadro del Museo di Napoli con la
Fondazione di S. Maria Maggiore e parecchi affreschi di
S. Clemente (specialmente quello della Conversione della,
regina dei pagani) mostrano errori di prospettiva analoghi
a quelli del Battistero di Castiglione d’Olona. Con questo
metodo si possono ottenere due gruppi di opere nettamente
distinti: uno, in cui si scorge la mano di un artista incerto,
che conosce la prospettiva soltanto a metà, si compone
di opere attribuite ora a Masolino, ora a Masaccio (come
alcuni affreschi della Cappella Brancacci, e le pitture di
San Clemente); l’altro comprende le pitture di Masaccio
di incontestabile autenticità.
Non si può negare che questo metodo possa aiutare la
critica stilistica, ma da solo non ci pare che basti; sarebbe
difficile invero credere di Masolino un’opera non corretta
prospetticamente che mostrasse caratteristiche peculiari
dello stile di Masaccio. Inoltre in alcuni dipinti può benis-
simo esservi stata collaborazione dei due maestri.
I risultati a cui giunge il Mesnil sono del resto quelli a
cui era già giunta la maggioranza dei critici odierni, e an-
IV. - Arte gotica.
Adolfo Venturi, Giovanni Pisano, Sein Leben
und sein Werk. Volumi due. Pantheon Casa
Editrice, Firenze. Kurt Wolff Verlag, Munchen,
1927.
È intanto pubblicata l’edizione tedesca di quest’opera,
divisa, come l’A. suole, in una prima parte con lo studio
della vita del Maestro poi riassunta nel prospetto cronologico
della vita e delle opere di lui; in una seconda parte con lo
studio dell’opera, seguita dal catalogo ragionato di essa;
in una terza con la bibliografia; in una quarta con l’indice
delle tavole. Sono ben centoventi le tavole che ci rappresen-
tano tutta l’opera di Giovanni Pisano. Molte di esse sono
pubblicate per la prima volta in questi due splendidi volumi.
Aspettiamo l’edizione italiana di questa monografia sul
grande Maestro.
VI. - Rinascimento italiano
a) Quattrocento.
J. Mesnil, Masaccio et les débuts de la Renais-
sance, La Haye, Nishoif, 1927. pp. 141 e 61 ta-
vole. Fr. 150.
Il periodo dell’arte italiana illustrato in questo libro è
quanto mai interessante, come quello in cui sorge e s’af-
ferma la prepotente personalità di Masaccio, il vero ini-
ziatore del Rinascimento nella pittura. L’autore, già noto
per altri studi su questo stesso periodo, ha il merito di
inquadrare con la chiarezza e la sicurezza di chi ha lun-
gamente studiato il suo argomento Masaccio nell’ambiente
in cui sorse, mostrando così compiutamente tutte le carat-
teristiche essenziali della sua arte, tanto ricca d’influenza
sui pittori del nostro Quattrocento.
Il Trecento è tutto dominato da Giotto, ma alla fine
del secolo si prepara un cambiamento già visibile nelle
opere degli epigoni. Nelle corti del Nord si va formando
quell’arte in cui il realismo si unisce alla calligrafia del go-
tico fiorito, arte cbe domina in tutta l’Europa, e può ben
dirsi internazionale. Il Mesnil determina bene quali siano
i caratteri di quest’arte, che si diffonde largamente anche
in Italia. In Firenze i Giotteschi ripetono stancamente
le vecchie formule, da cui lo spirito del maestro è ormai
del tutto scomparso. Varie influenze agiscono nella pit-
tura fiorentina, e tra le quali la più attiva è quella di Siena.
Il pittore più importante di questo periodo di transizione
è don Lorenzo Monaco, le cui prime opere mostrano, come
nota molto giustamente l’autore, una mescolanza d’in-
fluenze senesi e settentrionali. Il Mesnil trova questi carat-
teri nella Pietà con gli attributi della Passione (che noi
riteniamo di uno scolaro) e nel trittico della Collegiata
d’Empoli, datati 1404. Passa poi a parlare degli antifonari
della Biblioteca Laurenziana e del Museo Nazionale di
Firenze, non mai bene studiati sinora, nei quali trova giu-
stamente ricordi di motivi ornamentali che appaiono in
quel tempo in miniature di altre regioni d’Europa. No-
tiamo però che secondo noi è dubbio che Lorenzo Monaco
abbia lavorato personalmente ai codici della Laurenziana,
mentre certo sono di sua mano quasi tutti i minii del co-
dice H del Museo Nazionale, proveniente da S. Maria
Nuova dove, come sappiamo da documenti, Don Lorenzo
dipinse alcuni antifonari dal 1412 al 1413. Giustamente il
Mesnil osserva che Don Lorenzo non ha nessuno dei carat-
teri dei pittori fiorentini, ma subì soltanto l’influenza di
questi negli affreschi della cappella Bartolini a S. Trinità,
influenza che per noi non toccò però l’essenza dell’arte del
frate, che resta anche qui immutata.
Riassunte in Lorenzo Monaco (che non fu certo un pre-
cursore come volle il Sirèn) le caratteristiche di questo
periodo di goticismo in Firenze, breve ma ricco di singo-
lare interesse, l’autore entra nel suo tema, venendo a par-
lare di MaSaccio. Per ben chiarire le origini di questo pit-
tore, il Mesnil studia il periodo di sviluppo della prospet-
tiva, e si propone di distinguere le opere autentiche di
Masaccio da quelle che gli sono a torto attribuite, basan-
dosi sulla maggior o minore osservanza delle leggi prospet-
tiche. Così per lui il quadro del Museo di Napoli con la
Fondazione di S. Maria Maggiore e parecchi affreschi di
S. Clemente (specialmente quello della Conversione della,
regina dei pagani) mostrano errori di prospettiva analoghi
a quelli del Battistero di Castiglione d’Olona. Con questo
metodo si possono ottenere due gruppi di opere nettamente
distinti: uno, in cui si scorge la mano di un artista incerto,
che conosce la prospettiva soltanto a metà, si compone
di opere attribuite ora a Masolino, ora a Masaccio (come
alcuni affreschi della Cappella Brancacci, e le pitture di
San Clemente); l’altro comprende le pitture di Masaccio
di incontestabile autenticità.
Non si può negare che questo metodo possa aiutare la
critica stilistica, ma da solo non ci pare che basti; sarebbe
difficile invero credere di Masolino un’opera non corretta
prospetticamente che mostrasse caratteristiche peculiari
dello stile di Masaccio. Inoltre in alcuni dipinti può benis-
simo esservi stata collaborazione dei due maestri.
I risultati a cui giunge il Mesnil sono del resto quelli a
cui era già giunta la maggioranza dei critici odierni, e an-