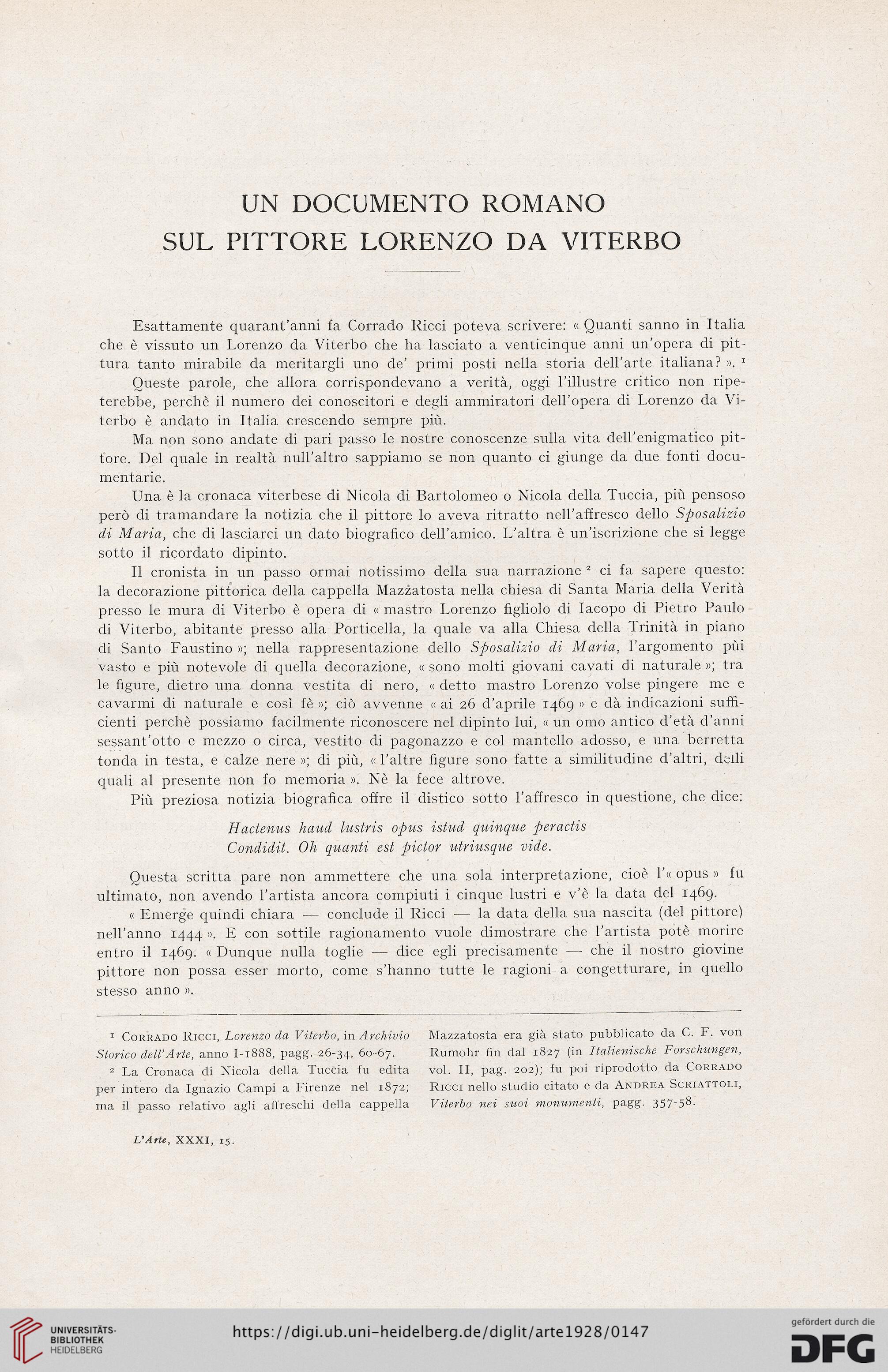UN DOCUMENTO ROMANO
SUL PITTORE LORENZO DA VITERBO
Esattamente quarantanni fa Corrado Ricci poteva scrivere: « Quanti sanno in Italia
che è vissuto un Lorenzo da Viterbo che ha lasciato a venticinque anni un’opera di pit-
tura tanto mirabile da meritargli uno de’ primi posti nella storia dell’arte italiana? ». 1
Queste parole, che allora corrispondevano a verità, oggi l’illustre critico non ripe-
terebbe, perchè il numero dei conoscitori e degli ammiratori dell’opera di Lorenzo da Vi-
terbo è andato in Italia crescendo sempre più.
Ma non sono andate di pari passo le nostre conoscenze sulla vita dell’enigmatico pit-
tore. Del quale in realtà null’altro sappiamo se non quanto ci giunge da due fonti docu-
mentarie.
Una è la cronaca viterbese di Nicola di Bartolomeo o Nicola della Tuccia, più pensoso
però di tramandare la notizia che il pittore lo aveva ritratto nell’affresco dello Sposalizio
di Maria, che di lasciarci un dato biografico dell’amico. L’altra è un’iscrizione che si legge
sotto il ricordato dipinto.
Il cronista in un passo ormai notissimo della sua narrazione 2 ci fa sapere questo:
la decorazione pittorica della cappella Mazzatosta nella chiesa di Santa Maria della Verità
presso le mura di Viterbo è opera di « mastro Lorenzo figliolo di Iacopo di Pietro Paulo
di Viterbo, abitante presso alla Porticella, la quale va alla Chiesa della Trinità in piano
di Santo Faustino »; nella rappresentazione dello Sposalizio di Maria, l’argomento pùi
vasto e più notevole di quella decorazione, « sono molti giovani cavati di naturale »; tra
le figure, dietro una donna vestita di nero, « detto mastro Lorenzo volse pingere me e
cavarmi di naturale e così fè »; ciò avvenne « ai 26 d’aprile 1469 » e dà indicazioni suffi-
cienti perchè possiamo facilmente riconoscere nel dipinto lui, « un omo antico d’età d’anni
sessant’otto e mezzo o circa, vestito di pagonazzo e col mantello adosso, e una berretta
tonda in testa, e calze nere »; di più, « l’altre figure sono fatte a similitudine d’altri, dalli
quali al presente non fo memoria ». Nè la fece altrove.
Più preziosa notizia biografica offre il distico sotto l’affresco in questione, che dice:
Hactenus haud lustris opus istud quinque peractis
Condidit. Oh quanti est pictor utriusque vide.
Questa scritta pare non ammettere che una sola interpretazione, cioè l’« opus » fu
ultimato, non avendo l’artista ancora compiuti i cinque lustri e v’è la data del 1469.
« Emerge quindi chiara — conclude il Ricci — la data della sua nascita (del pittore)
nell’anno 1444 ». E con sottile ragionamento vuole dimostrare che l’artista potè morire
entro il 1469. « Dunque nulla toglie — dice egli precisamente — che il nostro giovine
pittore non possa esser morto, come s’hanno tutte le ragioni a congetturare, in quello
stesso anno ».
1 Corrado Ricci, Lorenzo da Viterbo, in Archivio
Storico dell’Arte, anno I-1888, pagg. 26-34, 60-67.
2 La Cronaca di Nicola della Tuccia fu edita
per intero da Ignazio Campi a Firenze nel 1872;
ma il passo relativo agli affreschi della cappella
Mazzatosta era già stato pubblicato da C. F. von
Rumohr fin dal 1827 (in Italienische Forschungen,
voi. II, pag. 202); fu poi riprodotto da Corrado
Ricci nello studio citato e da Andrea Scriattoli,
Viterbo nei suoi monumenti, pagg. 357’58-
L'Arte, XXXI, 15.
SUL PITTORE LORENZO DA VITERBO
Esattamente quarantanni fa Corrado Ricci poteva scrivere: « Quanti sanno in Italia
che è vissuto un Lorenzo da Viterbo che ha lasciato a venticinque anni un’opera di pit-
tura tanto mirabile da meritargli uno de’ primi posti nella storia dell’arte italiana? ». 1
Queste parole, che allora corrispondevano a verità, oggi l’illustre critico non ripe-
terebbe, perchè il numero dei conoscitori e degli ammiratori dell’opera di Lorenzo da Vi-
terbo è andato in Italia crescendo sempre più.
Ma non sono andate di pari passo le nostre conoscenze sulla vita dell’enigmatico pit-
tore. Del quale in realtà null’altro sappiamo se non quanto ci giunge da due fonti docu-
mentarie.
Una è la cronaca viterbese di Nicola di Bartolomeo o Nicola della Tuccia, più pensoso
però di tramandare la notizia che il pittore lo aveva ritratto nell’affresco dello Sposalizio
di Maria, che di lasciarci un dato biografico dell’amico. L’altra è un’iscrizione che si legge
sotto il ricordato dipinto.
Il cronista in un passo ormai notissimo della sua narrazione 2 ci fa sapere questo:
la decorazione pittorica della cappella Mazzatosta nella chiesa di Santa Maria della Verità
presso le mura di Viterbo è opera di « mastro Lorenzo figliolo di Iacopo di Pietro Paulo
di Viterbo, abitante presso alla Porticella, la quale va alla Chiesa della Trinità in piano
di Santo Faustino »; nella rappresentazione dello Sposalizio di Maria, l’argomento pùi
vasto e più notevole di quella decorazione, « sono molti giovani cavati di naturale »; tra
le figure, dietro una donna vestita di nero, « detto mastro Lorenzo volse pingere me e
cavarmi di naturale e così fè »; ciò avvenne « ai 26 d’aprile 1469 » e dà indicazioni suffi-
cienti perchè possiamo facilmente riconoscere nel dipinto lui, « un omo antico d’età d’anni
sessant’otto e mezzo o circa, vestito di pagonazzo e col mantello adosso, e una berretta
tonda in testa, e calze nere »; di più, « l’altre figure sono fatte a similitudine d’altri, dalli
quali al presente non fo memoria ». Nè la fece altrove.
Più preziosa notizia biografica offre il distico sotto l’affresco in questione, che dice:
Hactenus haud lustris opus istud quinque peractis
Condidit. Oh quanti est pictor utriusque vide.
Questa scritta pare non ammettere che una sola interpretazione, cioè l’« opus » fu
ultimato, non avendo l’artista ancora compiuti i cinque lustri e v’è la data del 1469.
« Emerge quindi chiara — conclude il Ricci — la data della sua nascita (del pittore)
nell’anno 1444 ». E con sottile ragionamento vuole dimostrare che l’artista potè morire
entro il 1469. « Dunque nulla toglie — dice egli precisamente — che il nostro giovine
pittore non possa esser morto, come s’hanno tutte le ragioni a congetturare, in quello
stesso anno ».
1 Corrado Ricci, Lorenzo da Viterbo, in Archivio
Storico dell’Arte, anno I-1888, pagg. 26-34, 60-67.
2 La Cronaca di Nicola della Tuccia fu edita
per intero da Ignazio Campi a Firenze nel 1872;
ma il passo relativo agli affreschi della cappella
Mazzatosta era già stato pubblicato da C. F. von
Rumohr fin dal 1827 (in Italienische Forschungen,
voi. II, pag. 202); fu poi riprodotto da Corrado
Ricci nello studio citato e da Andrea Scriattoli,
Viterbo nei suoi monumenti, pagg. 357’58-
L'Arte, XXXI, 15.