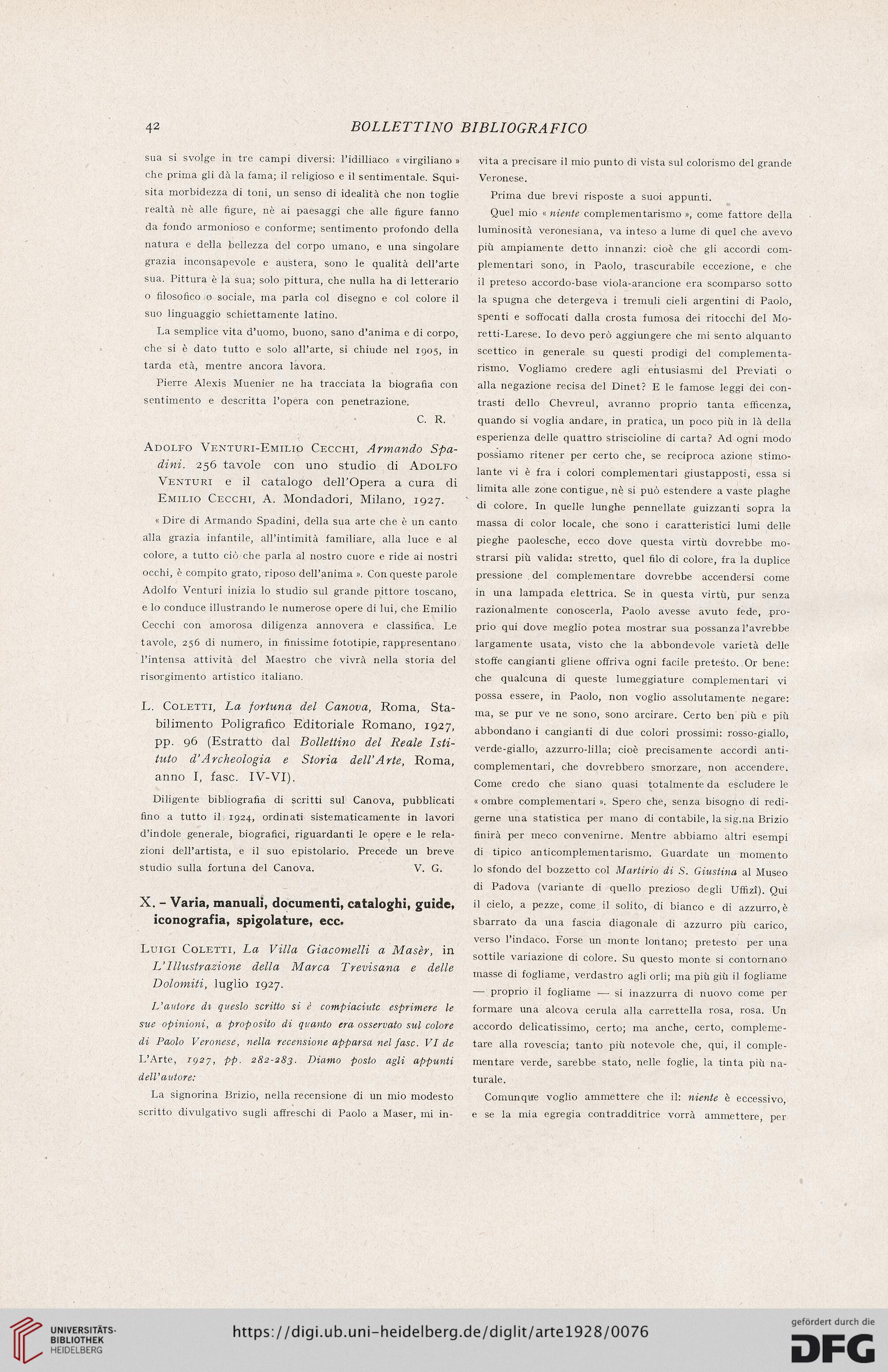42
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
sua si svolge in tre campi diversi: l’idilliaco « virgiliano »
che prima gli dà la fama; il religioso e il sentimentale. Squi-
sita morbidezza di toni, un senso di idealità che non toglie
realtà nè alle figure, nè ai paesaggi che alle figure fanno
da fondo armonioso e conforme; sentimento profondo della
natura e della bellezza del corpo umano, e una singolare
grazia inconsapevole e austera, sono le qualità dell’arte
sua. Pittura è la sua; solo pittura, che nulla ha di letterario
o filosofico ;0 sociale, ma parla col disegno e col colore il
suo linguaggio schiettamente latino.
La semplice vita d’uomo, buono, sano d’anima e di corpo,
che si è dato tutto e solo all’arte, si chiude nel 1905, in
tarda età, mentre ancora lavora.
Pierre Alexis Muenier ne ha tracciata la biografia con
sentimento e descritta l’opera con penetrazione.
C. R.
Adolfo Venturi-Emilio Cecchi, Armando Spa-
dini. 256 tavole con uno studio di Adolfo
Venturi e il catalogo dell’opera a cura di
Emilio Cecchi, A. Mondadori, Milano, 1927.
« Dire di Armando Spadini, della sua arte che è un canto
alla grazia infantile, all’intimità familiare, alla luce e al
colore, a tutto ciò, che parla al nostro cuore e ride ai nostri
occhi, è compito grato/riposo dell’anima ». Con queste parole
Adolfo Venturi inizia lo studio sul grande pittore toscano,
e lo conduce illustrando le numerose opere di lui, che Emilio
Cecchi con amorosa diligenza annovera e classifica. Le
tavole, 256 di numero, in finissime fototipie, rappresentano
l’intensa attività del Maestro che vivrà nella storia del
risorgimento artistico italiano.
L. Coletti, La fortuna del Canova, Roma, Sta-
bilimento Poligrafico Editoriale Romano, 1927,
pp. 96 (Estratto dal Bollettino del Reale Isti-
tuto d’Archeologia e Storia dell'Arte, Roma,
anno I, fase. IV-VI).
Diligente bibliografia di scritti sul Canova, pubblicati
fino a tutto il 1924, ordinati sistematicamente in lavori
d’indole generale, biografici, riguardanti le opere e le rela-
zioni dell’artista, e il suo epistolario. Precede un breve
studio sulla fortuna del Canova. V. G.
X. - Varia, manuali, documenti, cataloghi, guide,
iconografia, spigolature, ecc-
Luigi Coletti, La Villa Giacomelli a Maser, in
L’Illustrazione della Marca Trevisana e delle
Dolomiti, luglio 1927.
L'autore di questo scritto si è compiaciute esprimere le
sue opinioni, a proposito di quanto era osservato sul colore
di Paolo Veronese, nella recensione apparsa nel fase. VI de
L’Arte, 2927, pp. 282-283. Diamo posto agli appunti
dell'autore:
La signorina Brizio, nella recensione di un mio modesto
scritto divulgativo sugli affreschi di Paolo a Maser, mi in-
vita a precisare il mio punto di vista sul colorismo del grande
Veronese.
Prima due brevi risposte a suoi appunti.
Quel mio « niente complementarismo », come fattore della
luminosità veronesiana, va inteso a lume di quel che avevo
più ampiamente detto innanzi: cioè che gli accordi com-
plementari sono, in Paolo, trascurabile eccezione, e che
il preteso accordo-base viola-arancione era scomparso sotto
la spugna che detergeva i tremuli cieli argentini di Paolo,
spenti e soffocati dalla crosta fumosa dei ritocchi del Mo-
retti-Larese. Io devo però aggiungere che mi sento alquanto
scettico in generale su questi prodigi del complementa-
rismo. Vogliamo credere agli entusiasmi del Previati o
alla negazione recisa del Dinet? E le famose leggi dei con-
trasti dello Chevreul, avranno proprio tanta efficenza,
quando si voglia andare, in pratica, un poco più in là della
esperienza delle quattro striscioline di carta? Ad ogni modo
possiamo ritener per certo che, se reciproca azione stimo-
lante vi è fra i colori complementari giustapposti, essa si
limita alle zone contigue, nè si può estendere a vaste plaghe
di colore. In quelle lunghe pennellate guizzanti sopra la
massa di color locale, che sono i caratteristici lumi delle
pieghe paolesche, ecco dove questa virtù dovrebbe mo-
strarsi più valida: stretto, quel filo di colore, fra la duplice
pressione . del complementare dovrebbe accendersi come
in una lampada elettrica. Se in questa virtù, pur senza
razionalmente conoscerla, Paolo avesse avuto fede, /pro-
prio qui dove meglio potea mostrar sua possanza l’avrebbe
largamente usata, visto che la abbondevole varietà delle
stoffe cangianti gliene offriva ogni facile pretesto. Or bene:
che qualcuna di queste lumeggiature complementari vi
possa essere, in Paolo, non voglio assolutamente negare:
ma, se pur ve ne sono, sono arcirare. Certo ben' più e più
abbondano i cangianti di due colori prossimi: rosso-giallo,
verde-giallo, azzurro-lilla; cioè precisamente accordi anti-
complementari, che dovrebbero smorzare, non accendere.
Come credo che siano quasi totalmente da escludere le
« ombre complementari ». Spero che, senza bisogno di redi-
gerne una statistica per mano di contabile, la sig.na Brizio
finirà per meco convenirne. Mentre abbiamo altri esempi
di tipico anticomplementarismo. Guardate un momento
10 sfondo del bozzetto col Martirio di S. Giustina al Museo
di Padova (variante di quello prezioso degli Uffìzi). Qui
11 cielo, a pezze, come il solito, di bianco e di azzurro, è
sbarrato da una fascia diagonale di azzurro più carico,
verso l’indaco. Forse un monte lontano; pretesto per una
sottile variazione di colore. Su questo monte si contornano
masse di fogliame, verdastro agli orli; ma più giù il fogliame
— proprio il fogliame — si inazzurra di nuovo come per
formare una alcova cerula alla carrettella rosa, rosa. Un
accordo delicatissimo, certo; ma anche, certo, compleme-
tare alla rovescia; tanto più notevole che, qui, il comple-
mentare verde, sarebbe stato, nelle foglie, la tinta più na-
turale.
Comunque voglio ammettere che il: niente è eccessivo,
e se la mia egregia contradditrice vorrà ammettere, per
BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
sua si svolge in tre campi diversi: l’idilliaco « virgiliano »
che prima gli dà la fama; il religioso e il sentimentale. Squi-
sita morbidezza di toni, un senso di idealità che non toglie
realtà nè alle figure, nè ai paesaggi che alle figure fanno
da fondo armonioso e conforme; sentimento profondo della
natura e della bellezza del corpo umano, e una singolare
grazia inconsapevole e austera, sono le qualità dell’arte
sua. Pittura è la sua; solo pittura, che nulla ha di letterario
o filosofico ;0 sociale, ma parla col disegno e col colore il
suo linguaggio schiettamente latino.
La semplice vita d’uomo, buono, sano d’anima e di corpo,
che si è dato tutto e solo all’arte, si chiude nel 1905, in
tarda età, mentre ancora lavora.
Pierre Alexis Muenier ne ha tracciata la biografia con
sentimento e descritta l’opera con penetrazione.
C. R.
Adolfo Venturi-Emilio Cecchi, Armando Spa-
dini. 256 tavole con uno studio di Adolfo
Venturi e il catalogo dell’opera a cura di
Emilio Cecchi, A. Mondadori, Milano, 1927.
« Dire di Armando Spadini, della sua arte che è un canto
alla grazia infantile, all’intimità familiare, alla luce e al
colore, a tutto ciò, che parla al nostro cuore e ride ai nostri
occhi, è compito grato/riposo dell’anima ». Con queste parole
Adolfo Venturi inizia lo studio sul grande pittore toscano,
e lo conduce illustrando le numerose opere di lui, che Emilio
Cecchi con amorosa diligenza annovera e classifica. Le
tavole, 256 di numero, in finissime fototipie, rappresentano
l’intensa attività del Maestro che vivrà nella storia del
risorgimento artistico italiano.
L. Coletti, La fortuna del Canova, Roma, Sta-
bilimento Poligrafico Editoriale Romano, 1927,
pp. 96 (Estratto dal Bollettino del Reale Isti-
tuto d’Archeologia e Storia dell'Arte, Roma,
anno I, fase. IV-VI).
Diligente bibliografia di scritti sul Canova, pubblicati
fino a tutto il 1924, ordinati sistematicamente in lavori
d’indole generale, biografici, riguardanti le opere e le rela-
zioni dell’artista, e il suo epistolario. Precede un breve
studio sulla fortuna del Canova. V. G.
X. - Varia, manuali, documenti, cataloghi, guide,
iconografia, spigolature, ecc-
Luigi Coletti, La Villa Giacomelli a Maser, in
L’Illustrazione della Marca Trevisana e delle
Dolomiti, luglio 1927.
L'autore di questo scritto si è compiaciute esprimere le
sue opinioni, a proposito di quanto era osservato sul colore
di Paolo Veronese, nella recensione apparsa nel fase. VI de
L’Arte, 2927, pp. 282-283. Diamo posto agli appunti
dell'autore:
La signorina Brizio, nella recensione di un mio modesto
scritto divulgativo sugli affreschi di Paolo a Maser, mi in-
vita a precisare il mio punto di vista sul colorismo del grande
Veronese.
Prima due brevi risposte a suoi appunti.
Quel mio « niente complementarismo », come fattore della
luminosità veronesiana, va inteso a lume di quel che avevo
più ampiamente detto innanzi: cioè che gli accordi com-
plementari sono, in Paolo, trascurabile eccezione, e che
il preteso accordo-base viola-arancione era scomparso sotto
la spugna che detergeva i tremuli cieli argentini di Paolo,
spenti e soffocati dalla crosta fumosa dei ritocchi del Mo-
retti-Larese. Io devo però aggiungere che mi sento alquanto
scettico in generale su questi prodigi del complementa-
rismo. Vogliamo credere agli entusiasmi del Previati o
alla negazione recisa del Dinet? E le famose leggi dei con-
trasti dello Chevreul, avranno proprio tanta efficenza,
quando si voglia andare, in pratica, un poco più in là della
esperienza delle quattro striscioline di carta? Ad ogni modo
possiamo ritener per certo che, se reciproca azione stimo-
lante vi è fra i colori complementari giustapposti, essa si
limita alle zone contigue, nè si può estendere a vaste plaghe
di colore. In quelle lunghe pennellate guizzanti sopra la
massa di color locale, che sono i caratteristici lumi delle
pieghe paolesche, ecco dove questa virtù dovrebbe mo-
strarsi più valida: stretto, quel filo di colore, fra la duplice
pressione . del complementare dovrebbe accendersi come
in una lampada elettrica. Se in questa virtù, pur senza
razionalmente conoscerla, Paolo avesse avuto fede, /pro-
prio qui dove meglio potea mostrar sua possanza l’avrebbe
largamente usata, visto che la abbondevole varietà delle
stoffe cangianti gliene offriva ogni facile pretesto. Or bene:
che qualcuna di queste lumeggiature complementari vi
possa essere, in Paolo, non voglio assolutamente negare:
ma, se pur ve ne sono, sono arcirare. Certo ben' più e più
abbondano i cangianti di due colori prossimi: rosso-giallo,
verde-giallo, azzurro-lilla; cioè precisamente accordi anti-
complementari, che dovrebbero smorzare, non accendere.
Come credo che siano quasi totalmente da escludere le
« ombre complementari ». Spero che, senza bisogno di redi-
gerne una statistica per mano di contabile, la sig.na Brizio
finirà per meco convenirne. Mentre abbiamo altri esempi
di tipico anticomplementarismo. Guardate un momento
10 sfondo del bozzetto col Martirio di S. Giustina al Museo
di Padova (variante di quello prezioso degli Uffìzi). Qui
11 cielo, a pezze, come il solito, di bianco e di azzurro, è
sbarrato da una fascia diagonale di azzurro più carico,
verso l’indaco. Forse un monte lontano; pretesto per una
sottile variazione di colore. Su questo monte si contornano
masse di fogliame, verdastro agli orli; ma più giù il fogliame
— proprio il fogliame — si inazzurra di nuovo come per
formare una alcova cerula alla carrettella rosa, rosa. Un
accordo delicatissimo, certo; ma anche, certo, compleme-
tare alla rovescia; tanto più notevole che, qui, il comple-
mentare verde, sarebbe stato, nelle foglie, la tinta più na-
turale.
Comunque voglio ammettere che il: niente è eccessivo,
e se la mia egregia contradditrice vorrà ammettere, per