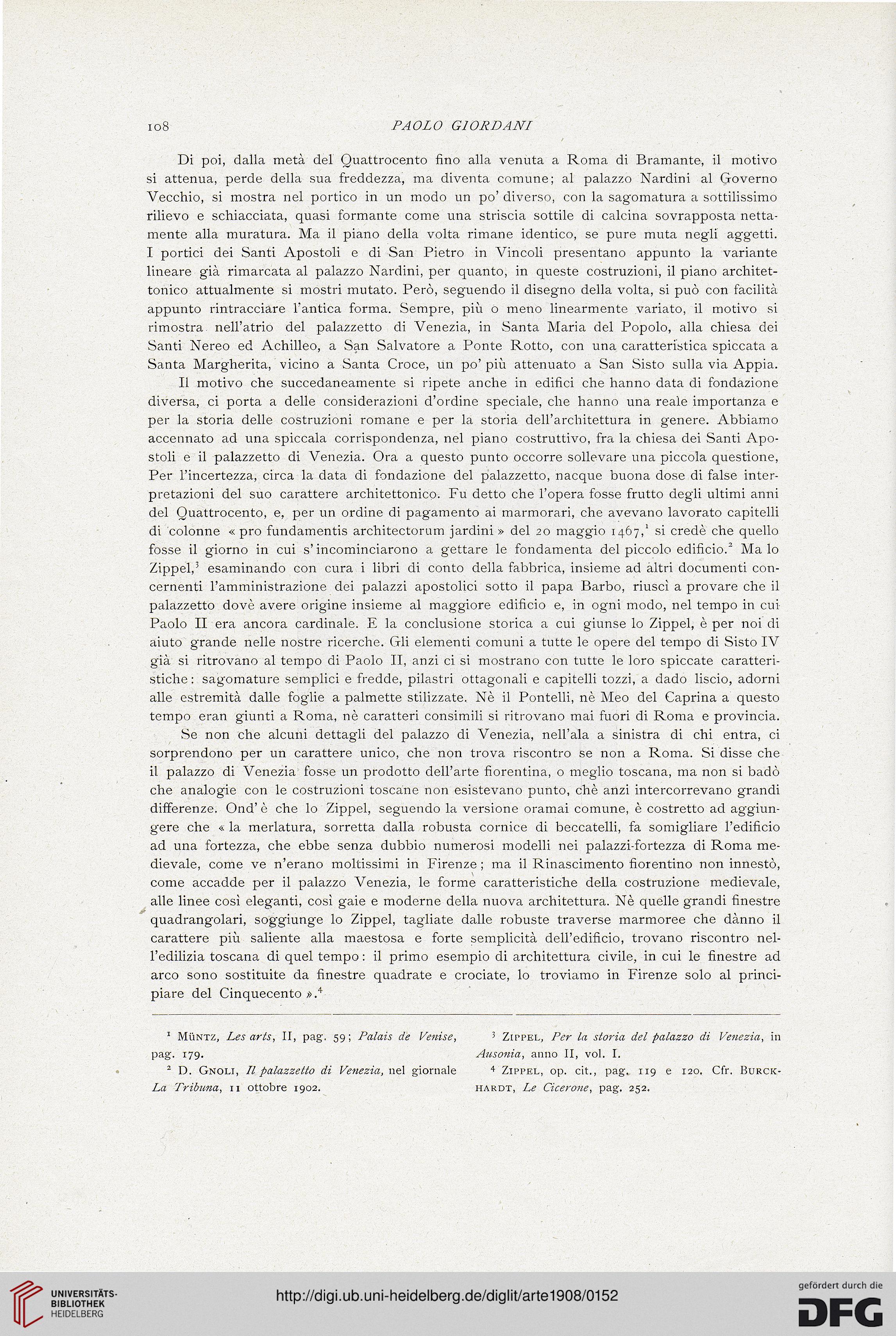io8
PAOLO GIORDANI
Di poi, dalla metà del Quattrocento fino alla venuta a Roma di Bramante, il motivo
si attenua, perde della sua freddezza, ma diventa comune; al palazzo Nardini al Governo
Vecchio, si mostra nel portico in un modo un po’ diverso, con la sagomatura a sottilissimo
rilievo e schiacciata, quasi formante come una striscia sottile di calcina sovrapposta netta-
mente alla muratura. Ma il piano della volta rimane identico, se pure muta negli aggetti.
I portici dei Santi Apostoli e di San Pietro in Vincoli presentano appunto la variante
lineare già rimarcata al palazzo Nardini, per quanto, in queste costruzioni, il piano architet-
tonico attualmente si mostri mutato. Però, seguendo il disegno della volta, si può con facilità
appunto rintracciare l'antica forma. Sempre, più o meno linearmente variato, il motivo si
rimostra nell’atrio del palazzetto di Venezia, in Santa Maria del Popolo, alla chiesa dei
Santi Nereo ed Achilleo, a San .Salvatore a Ponte Rotto, con una caratteristica spiccata a
Santa Margherita, vicino a Santa Croce, un po’ più attenuato a San Sisto sulla via Appia.
Il motivo che succedaneamente si ripete anche in edifici che hanno data di fondazione
diversa, ci porta a delle considerazioni d’ordine speciale, che hanno una reale importanza e
per la storia delle costruzioni romane e per la storia dell’architettura in genere. Abbiamo
accennato ad una spiccala corrispondenza, nel piano costruttivo, fra la chiesa dei Santi Apo-
stoli e il palazzetto di Venezia. Ora a questo punto occorre sollevare una piccola questione,
Per l’incertezza, circa la data di fondazione del palazzetto, nacque buona dose di false inter-
pretazioni del suo carattere architettonico. Fu detto che l’opera fosse frutto degli ultimi anni
del Quattrocento, e, per un ordine di pagamento ai marmorari, che avevano lavorato capitelli
di colonne « prò fundamentis architectorum jardini » del 20 maggio x 467,1 si credè che quello
fosse il giorno in cui s’incominciarono a gettare le fondamenta del piccolo edificio.2 Ma lo
Zippel,3 esaminando con cura i libri di conto della fabbrica, insieme ad altri documenti con-
cernenti l’amministrazione dei palazzi apostolici sotto il papa Barbo, riuscì a provare che il
palazzetto dovè avere origine insieme al maggiore edificio e, in ogni modo, nel tempo in cui
Paolo II era ancora cardinale. E la conclusione storica a cui giunse lo Zippel, è per noi di
aiuto grande nelle nostre ricerche. Gli elementi comuni a tutte le opere del tempo di Sisto IV
già si ritrovano al tempo di Paolo II, anzi ci si mostrano con tutte le loro spiccate caratteri-
stiche : sagomature semplici e fredde, pilastri ottagonali e capitelli tozzi, a dado liscio, adorni
alle estremità dalle foglie a palmette stilizzate. Nè il Pontelli, nè Meo del Caprina a questo
tempo eran giunti a Roma, nè caratteri consimili si ritrovano mai fuori di Roma e provincia.
Se non che alcuni dettagli del palazzo di Venezia, nell’ala a sinistra di chi entra, ci
sorprendono per un carattere unico, che non trova riscontro se non a Roma. Si disse che
il palazzo di Venezia fosse un prodotto dell’arte fiorentina, o meglio toscana, ma non si badò
che analogie con le costruzioni toscane non esistevano punto, chè anzi intercorrevano grandi
differenze. Ond’ è che lo Zippel, seguendo la versione oramai comune, è costretto ad aggiun-
gere che « la merlatura, sorretta dalla robusta cornice di beccatelli, fa somigliare l’edificio
ad una fortezza, che ebbe senza dubbio numerosi modelli nei palazzi-fortezza di Roma me-
dievale, come ve n’erano moltissimi in Firenze ; ma il Rinascimento fiorentino non innestò,
come accadde per il palazzo Venezia, le forme caratteristiche della costruzione medievale,
alle linee così eleganti, così gaie e moderne della nuova architettura. Nè quelle grandi finestre
quadrangolari, soggiunge lo Zippel, tagliate dalle robuste traverse marmoree che dànno il
carattere più saliente alla maestosa e forte semplicità dell’edificio, trovano riscontro nel-
l’edilizia toscana di quel tempo : il primo esempio di architettura civile, in cui le finestre ad
arco sono sostituite da finestre quadrate e crociate, lo troviamo in Firenze solo al princi-
piare del Cinquecento >>.+
1 Muntz, Les arts, II, pag, 59; Palais de Venise, 3 Zippel, Per la storia del palazzo di Ve?iezia, in
pag. 179. Ausonia, anno II, voi. I.
2 D. Gnoli, Il palazzetto di Venezia, nel giornale 4 Zippel, op. cit., pag. 119 e 120. Cfr. Burck-
La Tribuna, 11 ottobre 1902. hardt, Le Cicerone, pag. 252.
PAOLO GIORDANI
Di poi, dalla metà del Quattrocento fino alla venuta a Roma di Bramante, il motivo
si attenua, perde della sua freddezza, ma diventa comune; al palazzo Nardini al Governo
Vecchio, si mostra nel portico in un modo un po’ diverso, con la sagomatura a sottilissimo
rilievo e schiacciata, quasi formante come una striscia sottile di calcina sovrapposta netta-
mente alla muratura. Ma il piano della volta rimane identico, se pure muta negli aggetti.
I portici dei Santi Apostoli e di San Pietro in Vincoli presentano appunto la variante
lineare già rimarcata al palazzo Nardini, per quanto, in queste costruzioni, il piano architet-
tonico attualmente si mostri mutato. Però, seguendo il disegno della volta, si può con facilità
appunto rintracciare l'antica forma. Sempre, più o meno linearmente variato, il motivo si
rimostra nell’atrio del palazzetto di Venezia, in Santa Maria del Popolo, alla chiesa dei
Santi Nereo ed Achilleo, a San .Salvatore a Ponte Rotto, con una caratteristica spiccata a
Santa Margherita, vicino a Santa Croce, un po’ più attenuato a San Sisto sulla via Appia.
Il motivo che succedaneamente si ripete anche in edifici che hanno data di fondazione
diversa, ci porta a delle considerazioni d’ordine speciale, che hanno una reale importanza e
per la storia delle costruzioni romane e per la storia dell’architettura in genere. Abbiamo
accennato ad una spiccala corrispondenza, nel piano costruttivo, fra la chiesa dei Santi Apo-
stoli e il palazzetto di Venezia. Ora a questo punto occorre sollevare una piccola questione,
Per l’incertezza, circa la data di fondazione del palazzetto, nacque buona dose di false inter-
pretazioni del suo carattere architettonico. Fu detto che l’opera fosse frutto degli ultimi anni
del Quattrocento, e, per un ordine di pagamento ai marmorari, che avevano lavorato capitelli
di colonne « prò fundamentis architectorum jardini » del 20 maggio x 467,1 si credè che quello
fosse il giorno in cui s’incominciarono a gettare le fondamenta del piccolo edificio.2 Ma lo
Zippel,3 esaminando con cura i libri di conto della fabbrica, insieme ad altri documenti con-
cernenti l’amministrazione dei palazzi apostolici sotto il papa Barbo, riuscì a provare che il
palazzetto dovè avere origine insieme al maggiore edificio e, in ogni modo, nel tempo in cui
Paolo II era ancora cardinale. E la conclusione storica a cui giunse lo Zippel, è per noi di
aiuto grande nelle nostre ricerche. Gli elementi comuni a tutte le opere del tempo di Sisto IV
già si ritrovano al tempo di Paolo II, anzi ci si mostrano con tutte le loro spiccate caratteri-
stiche : sagomature semplici e fredde, pilastri ottagonali e capitelli tozzi, a dado liscio, adorni
alle estremità dalle foglie a palmette stilizzate. Nè il Pontelli, nè Meo del Caprina a questo
tempo eran giunti a Roma, nè caratteri consimili si ritrovano mai fuori di Roma e provincia.
Se non che alcuni dettagli del palazzo di Venezia, nell’ala a sinistra di chi entra, ci
sorprendono per un carattere unico, che non trova riscontro se non a Roma. Si disse che
il palazzo di Venezia fosse un prodotto dell’arte fiorentina, o meglio toscana, ma non si badò
che analogie con le costruzioni toscane non esistevano punto, chè anzi intercorrevano grandi
differenze. Ond’ è che lo Zippel, seguendo la versione oramai comune, è costretto ad aggiun-
gere che « la merlatura, sorretta dalla robusta cornice di beccatelli, fa somigliare l’edificio
ad una fortezza, che ebbe senza dubbio numerosi modelli nei palazzi-fortezza di Roma me-
dievale, come ve n’erano moltissimi in Firenze ; ma il Rinascimento fiorentino non innestò,
come accadde per il palazzo Venezia, le forme caratteristiche della costruzione medievale,
alle linee così eleganti, così gaie e moderne della nuova architettura. Nè quelle grandi finestre
quadrangolari, soggiunge lo Zippel, tagliate dalle robuste traverse marmoree che dànno il
carattere più saliente alla maestosa e forte semplicità dell’edificio, trovano riscontro nel-
l’edilizia toscana di quel tempo : il primo esempio di architettura civile, in cui le finestre ad
arco sono sostituite da finestre quadrate e crociate, lo troviamo in Firenze solo al princi-
piare del Cinquecento >>.+
1 Muntz, Les arts, II, pag, 59; Palais de Venise, 3 Zippel, Per la storia del palazzo di Ve?iezia, in
pag. 179. Ausonia, anno II, voi. I.
2 D. Gnoli, Il palazzetto di Venezia, nel giornale 4 Zippel, op. cit., pag. 119 e 120. Cfr. Burck-
La Tribuna, 11 ottobre 1902. hardt, Le Cicerone, pag. 252.